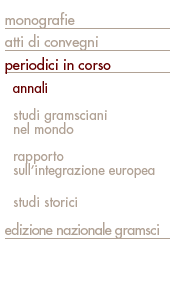|

|

|
 |
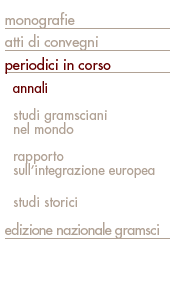

|
| <–
torna
indietro
|
|
ANNALE II
La politica del Partito
comunista italiano nel periodo costituente.
I verbali della direzione tra il V e il VI Congresso
1946-1948
a cura di Renzo Martinelli e Maria Luisa Righi
Roma, Editori Riuniti,
1992
p. 659, L. 90.000
ISBN 978-88-359-3659-4 |
| |
Introduzione
di Renzo Martinelli –>
La documentazione che pubblichiamo nel presente volume
– tratta dall’archivio del Pci depositato
presso la Fondazione Istituto Gramsci di Roma –
rappresenta una delle fonti di maggiore importanza per
la storia del Partito comunista italiano nel periodo costituente.
Si tratta dei verbali – qui riprodotti in forma
integrale, e ovviamente nel loro ordine cronologico –
di tutte le riunioni della direzione comunista tenute
tra il V (29 dicembre 1945-5 gennaio 1946) e il VI (5-10
gennaio 1948) Congresso nazionale, che costituiscono,
come è evidente, un osservatorio indispensabile
per comprendere appieno l’azione effettiva di un
«soggetto» che ha svolto, negli anni in cui
la conquista della repubblica e l’elaborazione della
Costituzione segnano la nascita dell’Italia democratica,
un ruolo determinante. Questo materiale, per il suo intrinseco
significato politico, come per la sua natura riservata
(la consultazione di documenti di questo tipo è
a tutt’oggi limitata ai due maggiori partiti: mentre
l’archivio del Pci è già da qualche
anno a disposizione degli studiosi, quello della Dc è
stato aperto appena qualche mese fa, nel febbraio 1992)
presenta un interesse del tutto particolare, che trova
un’immediata conferma anche ad una lettura superficiale
mentre un esame più approfondito consentirà
di ricostruire con precisione i termini del dibattito
interno, connettendoli da un lato alle questioni fondamentali
del periodo, dall’altro – sullo sfondo del
«partito nuovo» – alla formazione e
alle caratteristiche del gruppo dirigente.
La direzione è, nel Pci – in un partito che
è sempre stato, per vocazione e per tradizione,
centralizzato e «verticista» – un organo
di rilevante importanza, nel quale si discutono e si decidono
(spesso in termini assai poco diplomatici) i problemi
politici di fondo e, nello stesso tempo, le questioni
concrete di maggior peso relative all’attività
del partito. Se infatti è al Comitato centrale
che spetta statutariamente la funzione dirigente, è
in realtà la direzione ad assumere di fatto questo
compito, per il fenomeno – nel quale si manifesta
con chiarezza il peso delle tendenze oligarchiche negli
organismi collettivi – dell’accentramento
del potere nella sede più ristretta (favorita in
ciò, indubbiamente, anche dalla sua maggiore snellezza
e operatività).
Secondo lo statuto, la direzione – alla quale veniva
affidata la guida di tutta l’attività del
partito – era eletta dal Comitato centrale, che
stabiliva anche «il numero dei membri effettivi
e supplenti» a sua volta, essa designava la segreteria,
la commissione di organizzazione, i responsabili delle
commissioni di lavoro, e infine i direttori dei quotidiani
«che hanno funzione di organo centrale del partito»:
un’altra prerogativa, di grande importanza, era
quella di convocare – ciò che doveva avvenire
di regola ogni tre mesi – lo stesso organo da cui
derivava la sua investitura, cioè il Cc.
È
proprio quest’ultima attribuzione a fondare oggettivamente
un primato dell’organo più ristretto rispetto
a quello più ampio, che pure, a norma di statuto,
aveva il compito di dirigere il partito nel periodo di
tempo compreso tra due congressi infatti, l’orientamento
politico generale sul quale il Cc avrebbe discusso, era
preliminarmente concordato in direzione, e così
un insieme di altri problemi concreti, attinenti agli
spostamenti dei quadri, alle iniziative pubbliche, alla
gestione della stampa, ecc. Riunendosi, in questo periodo,
piuttosto frequentemente, la direzione esercitava inoltre
un controllo abbastanza stretto sull’attività
generale del partito, lasciando alla segreteria –
un organismo che assumerà in seguito, tuttavia,
un peso sempre maggiore – dei compiti essenzialmente
organizzativi: la sua funzione poteva quindi essere considerata
davvero centrale, come una sorta di «motore»
del partito.
Le analisi e le previsioni dibattute al suo interno, l’interpretazione
degli avvenimenti italiani e internazionali, la «lettura»
della situazione economico-sociale e le opzioni che ne
derivano, sono quindi – proprio per il ruolo dominante,
di effettiva responsabilità, che svolgeva la direzione
comunista – gli elementi di maggiore interesse che
possiamo trarre da questi verbali: cosi, attraverso la
conoscenza approfondita dei modo stesso in cui, nella
discussione, i suoi membri pervenivano ad elaborare un’azione
determinata partendo da idee, opinioni, valutazioni particolari,
possiamo analizzare l’effettiva politica del Pci,
cogliendo il processo più intimo delle decisioni,
l’aspetto anche personale delle scelte dirette ad
intervenire sulla realtà.
Ed è attraverso questa possibilità di seguire
«in presa diretta», senza troppe mediazioni
o diaframmi, lo sviluppo di questa analisi collettiva,
che possiamo farci un concetto più preciso anche
dell’ideologia, più o meno consapevole, del
vertice comunista, che si manifesta assai chiaramente
quando vengono affrontati i problemi politici di fondo;
ma che si rivela, talvolta, anche nelle scelte apparentemente
più trascurabili (come l’impostazione di
determinate campagne di stampa, le argomentazioni relative
a temi particolari, lo stesso linguaggio usato nel corso
di determinate discussioni, ecc.).
Prima di schizzare rapidamente le caratteristiche più
precise del dibattito interno, è opportuno ricordare
la composizione della prima direzione del Pci regolarmente
eletta dopo la Liberazione – che è appunto
quella designata dal Comitato centrale nella sua prima
riunione, immediatamente successiva alla fine dei lavori
del V Congresso. Ne fanno parte 16 membri effettivi (Amendola,
Colombi, Di Vittorio, Li Causi, Longo, Massola, Negarville,
Novella, Pajetta, Roveda, Scoccimarro, Secchia, Sereni,
Roasio, Spano, Togliatti) e 6 membri candidati (D’Onofrio,
Grieco, Rita Montagnana, Teresa Noce, Giuliano Pajetta,
Terracini) un organismo in definitiva assai ristretto,
se si pensa che il Pci contava allora già due milioni
circa di iscritti.
Tutti i membri della direzione, ad eccezione di Emilio
Sereni (che è quindi, in questo senso, l’unico
«homo novus»), facevano comunque già
parte di quella precedente, che aveva preparato il V Congresso,
e rispetto alla quale non vi sono quindi – in relazione
alle caratteristiche sociali e alla formazione intellettuale
e politica dei vari membri – mutamenti di rilievo.
La direzione comunista si conferma infatti come un organismo
quasi esclusivamente maschile (solo due donne sono presenti,
e per di più tra i membri candidati), formato da
dirigenti sperimentati e capaci, che sono tutti «rivoluzionari
di professione»: è questo il dato che unifica
uomini di diversa estrazione sociale, provenienti dal
mondo del lavoro, come Secchia o Roasio, o di origine
intellettuale, come Togliatti o Sereni, ma attivi nel
partito già da molto tempo; maturati politicamente,
cioè, prima del crollo del fascismo e della Resistenza.
È questo un dato che sottolinea fortemente l’elemento
della continuità, ben rappresentato del resto dalle
stesse figure dei massimi dirigenti – Togliatti
(segretario generale), e Longo (vicesegretario generale)
– nelle quali si riflettono le esperienze politiche
formative di un’intera generazione di comunisti
venuti all’impegno politico sotto le bandiere del
marxismo e della Terza Internazionale: dalla lotta antifascista
in Italia, con il suo corredo di anni di galera e di esilio,
alla scuola leninista di Mosca, alle battaglie in Spagna
e nella guerra di Liberazione. Tale continuità
significa anche un notevole grado di omogeneità:
sulla base della loro formazione e della loro esperienza,
i membri della direzione del Pci sono in grado di «leggere»
ciò che accade nel mondo e in Italia secondo schemi
e criteri generali comuni, rapportando i fenomeni sociali
e politici alla struttura di classe e alla storia concreta
del paese – una storia recente vissuta direttamente
e «personalmente», che costituisce lo sfondo
permanente dell’analisi e della discussione interna.
In questo senso, lo «storicismo» dei dirigenti
comunisti, di cui si è spesso parlato in termini
piuttosto generici, non è solo un astratto elemento
della loro formazione culturale, più o meno rilevante
nelle diverse personalità – e certamente
assai spiccato in Togliatti – ma rappresenta anche,
in qualche misura, un portato dei fatti, un esito delle
prove attraversate collettivamente. Da questo punto di
vista, l’antitesi fascismo/antifascismo è
indubbiamente la base storico-politica fondamentale, il
referente più stabile e costante di tutta l’elaborazione
del Pci nel periodo costituente, ciò che occorre
tenere ben presente per comprendere i criteri politici
di fondo e l’ottica stessa del dibattito interno.
È evidente che, per analizzare il significato della
documentazione costituita da questi verbali, occorre considerare
la situazione storica nella quale si inserisce e da cui
acquista valore, senza perdere di vista il condizionamento
oggettivo costituito dalla struttura stessa del «partito
nuovo»: una «macchina organizzativa»
già assai sviluppata al momento del V Congresso,
e che non cesserà di rafforzarsi e di complicarsi
nei due anni successivi.
Come il lettore vedrà, i temi affrontati nelle
riunioni della direzione si connettono ai più significativi
avvenimenti di quegli anni, tanto da fornire quasi una
sorta di «sommario» dei nodi più rilevanti
della vita politica italiana: per un approfondito inquadramento
storico rimandiamo perciò ai testi più noti
sul periodo (tra i quali manca, tuttavia, uno studio complessivo
sul Pci).
È invece opportuno richiamare, almeno
sommariamente, gli esiti politici del V Congresso, dal
momento che la direzione del Pci ricava da questa assise
nazionale – la prima dopo il 1931, quando i comunisti
si erano riuniti clandestinamente a Colonia – non
solo la sua legittimità, ma soprattutto la linea
strategica fondamentale da seguire.
Il congresso si era svolto a Roma a cavallo tra il 1945
e il 1946, poco dopo il varo del primo governo De Gasperi,
a cui il Pci partecipava con la responsabilità
di tre ministeri: la Giustizia (Togliatti), l’Agricoltura
(Gullo), e le Finanze (Scoccimarro).
La prospettiva su cui puntavano esplicitamente i dirigenti
comunisti era quella di una duratura collaborazione con
la Dc e con il Psi, cioè quella di una stabilizzazione
della formula dell’unità antifascista: l’obiettivo
di rimanere al governo del paese (così da avviare
concretamente una politica di rinnovamento economico-sociale
basata sulle cosiddette «riforme di struttura»)
anche dopo le elezioni della Costituente e la scelta istituzionale
– due scadenze imminenti, dalle quali si riteneva
potesse scaturire, oltre alla conquista di una democrazia
avanzata, anche un ulteriore rafforzamento del partito
– pare va, se non scontato, del tutto realistico.
Una simile prospettiva richiedeva evidentemente un clima
internazionale favorevole, nel quale rimanesse fermo,
come elemento fondamentale, l’accordo tra le tre
grandi potenze: sarà inutile ricordare, a questo
proposito, che al momento del V Congresso la guerra fredda
non era ancora un fenomeno dominante, né la divisione
dell’Europa in blocchi contrapposti sembrava ineluttabile,
anche se i segni premonitori erano già abbastanza
visibili.
In questo quadro, il rapporto di Togliatti al congresso
si caratterizzò come la più efficace e completa
esposizione della strategia di un partito che aveva già
affermato la propria funzione nazionale, e che appariva
legittimamente fiducioso nella possibilità di continuare
a giocare in futuro, grazie alla sua forza e alla sua
capacità politica, un ruolo importante nel governo
del paese. Nel rapporto era lucidamente articolata la
linea tesa a stimolare un progresso democratico continuo
– la lotta, appunto, per una «democrazia progressiva»
– alla quale i comunisti affidavano le loro speranze
di imprimere al paese un graduale sviluppo «verso
il socialismo». Due fattori erano ritenuti essenziali
a questo disegno: il mantenimento della collaborazione
con la Dc, e la realizzazione di una stretta unità
politica – anzi, di una unità organica, cioè
di una fusione – tra i socialisti e i comunisti.
Questa fusione tra il Pci e il Psi, con la conseguente
formazione di un nuovo grande partito della sinistra,
appariva tuttavia, già al momento del congresso,
assai poco realistica; e infatti, nella relazione dedicata
da Longo a questo tema, si ripiegava di fatto sulla proposta
transitoria di una federazione tra i due partiti. La prospettiva
dell’unità organica veniva comunque mantenuta
nel suo valore strategico, nonostante le reticenze e le
difficoltà che cominciavano ad essere espresse
da parte socialista Infatti, i termini essenziali del
sistema politico italiano – già evidenti
ancora prima della Costituente nell’emergere, sullo
sfondo di un’articolata pluralità di formazioni
minori, dei tre grandi partiti di massa – indicavano
realisticamente ai comunisti la necessità di una
politica di alleanze capace di realizzarsi nello stesso
tempo, in forme e modi diversi, su questi due terreni:
quello del travagliato rapporto, da sempre problematico,
coi socialisti, e quello, nuovo, di una collaborazione
coi cattolici.
Proprio su questo piano, tuttavia, il Pci dovrà
registrare una decisiva sconfitta: escluso dal governo
del paese nella primavera del 1947 insieme con i socialisti
– con i quali, mentre la prospettiva della fusione
sfuma definitivamente, viene comunque rinnovato il patto
d’unità d’azione – si troverà
a capeggiare una dura lotta di opposizione che, al momento
del VI Congresso (gennaio 1948), sarà nondimeno
considerata – pur in un clima nazionale e internazionale
assai negativo – come la leva e la garanzia di un’imminente
vittoria elettorale.
In definitiva, il bilancio di questi due anni cruciali
non certo positivo, per i membri della direzione comunista,
almeno sul piano propriamente politico; mentre per quanto
riguarda il rinnovamento istituzionale, e la crescita
del «partito nuovo», si può invece
parlare di un rilevante successo. Questa contraddizione
tra lo sviluppo quantitativo del Pci e la sua mancata
affermazione come forza di governo, tra il ruolo storico
determinante assolto nel periodo costituente e la debolezza
evidente sul piano politico, un dato assai significativo,
che riflette con efficacia – sullo sfondo di una
situazione in rapido mutamento – la stessa natura
variegata e complessa del partito.
Il V Congresso aveva lanciato con forza la campagna per
la repubblica e la Costituente, proponendo contemporaneamente
un insieme di riforme strutturali che avrebbero dovuto
ricostruire l’economia italiana in termini di sviluppo
e di equità sociale: ma era l’obiettivo del
rinnovamento istituzionale, con ogni evidenza, ciò
che stava più a cuore ai comunisti, resi consapevoli,
attraverso l’esperienza del fascismo, del valore
della democrazia. Nella risoluzione approvata al termine
dei lavori, questa impostazione – già esplicita
nella relazione introduttiva di Togliatti – espressa
in termini sintetici, con una chiara esposizione della
linea politica alla cui realizzazione dovranno lavorare
gli organismi dirigenti.
Il primo obiettivo dunque quello di ottenere finalmente
la Costituente e la repubblica; non vi dovrà essere
più alcun rinvio di un’assemblea che il partito
«considera [...] come l’inizio di un rinnovamento
profondo e radicale di tutta la vita del paese. Con essa
dovrà prendere nuovo slancio l’azione diretta
a restituire all’Italia la piena indipendenza nazionale,
la unità politica e morale, la libertà democratica,
il benessere per le masse lavoratrici e il posto che le
spetta tra i popoli liberi dell’Europa e del mondo»
Alla Costituente viene così attribuita una funzione
decisiva; ciò anche in relazione al pericolo di
un risorgere del fascismo, più probabile e minaccioso
in una situazione ancora fluida, e che poteva trovare
alimento nelle tensioni politiche e sociali diffuse in
tutto il paese. A questo pericolo contribuivano sia la
riorganizzazione di strutture e formazioni neofasciste,
sia la spinta estremistica di determinati strati del Pci,
a cui risaliva non di rado la responsabilità di
tumulti ed episodi sanguinosi – «regolamenti
di conti», vendette personali, giudizi sommari –
particolarmente frequenti in Emilia-Romagna (una regione,
com’è noto, in cui la Resistenza aveva assunto
più distintamente i caratteri di un duro scontro
di classe).
A questo proposito, pensiamo non ci sia più bisogno,
ormai, di argomentare l’inconsistenza di una «doppiezza»
del Pci, volto, secondo vecchi stilemi polemici, a preparare
l’insurrezione fingendosi nel contempo democratico:
si tratta di un’argomentazione propagandistica che
non trova un effettivo riscontro nei fatti e che riceve
la più chiara smentita proprio dai verbali della
direzione. Come il lettore potrà notare agevolmente,
il timore di un precipitare della situazione, con la conseguente
necessità di tenere a freno le frange estremiste,
evitando, nello stesso tempo, un rafforzamento del fronte
moderato e conservatore – e le due cose apparivano
strettamente collegate – si presenta infatti come
una costante in tutta la discussione interna, illuminando
con chiarezza il peso rilevante esercitato sulla concreta
strategia comunista dalle esperienze del passato.
Non possibile, infatti, comprendere la politica del Pci
in questo periodo senza valutare appieno quanto abbia
inciso, sullo stesso modo di ragionare dei suoi dirigenti,
la riflessione sul cosiddetto «diciannovismo»:
da questa esperienza deriva infatti la preoccupazione
che si possa ripetere una situazione analoga ogni volta
che i contrasti sociali e politici raggiungono una soglia
eccessiva, rischiando di sconfinare sul terreno della
provocazione e della violenza. Per questo, una delle costanti
più evidenti nello sforzo pedagogico messo in opera
dal gruppo dirigente per «acculturare» un
partito di due milioni di iscritti (composto, nella sua
grande maggioranza, da lavoratori manuali) si può
individuare appunto nel superamento dell’estremismo,
e nella diffusione di un costume democratico capace di
soppiantare le impostazioni settarie o ideologicamente
dogmatiche. È uno sforzo complesso e non facile,
che trova un riscontro preciso anche nel nuovo statuto,
nel quale l’iscrizione al partito è consentita
sulla base dell’accettazione del programma politico,
«indipendente mente dalla razza, dalla fede religiosa,
e dalle convinzioni filosofiche»
Ma se il Pci aveva indubbiamente compiuto una chiara scelta
a favore della democrazia – e si preoccupava di
evitare che fosse messa in pericolo con errori già
scontati a caro prezzo in passato – aveva certamente
anche qualche ragione per diffidare dei suoi avversari:
ottenere la Costituente e la repubblica appariva di conseguenza
un obiettivo continuamente insidiato, continuamente in
pericolo; e a maggior ragione, quindi, appariva come un
fattore profondo di stabilizzazione democratica, una conquista
necessaria per la stessa salvaguardia dell’esistenza
del partito e per il più agevole sviluppo, secondo
anche una vecchia indicazione di Engels, della lotta della
classe operaia.
I comunisti, d’altra parte, erano ben consapevoli
che il conseguimento dei loro obiettivi fondamentali in
quella fase richiedeva una situazione internazionale favorevole,
e fin da questo momento – non avendo grandi possibilità
di influire su questo piano – il gruppo dirigente
si sforza di «esorcizzare», con ripetute dichiarazioni,
la temuta prospettiva di un inasprimento dei rapporti
tra le grandi potenze, e di una conseguente divisione
dell’Europa in blocchi contrapposti: «Il partito
comunista – si legge nel documento già citato
– è contrario a una politica di “blocchi”
di potenze, perché tale politica non potrebbe mettere
capo ad altro che all’asservimento diretto o indiretto
del nostro paese. Esso desidera che nel campo economico
la collaborazione e gli aiuti indispensabili, e le garanzie
che debbono accompagnare questo aiuto, si realizzino in
modo che non diminuisca l’indipendenza nazionale
e consenta la difesa degli interessi dei diritti della
nostra emigrazione». L’Italia deve attuare
una politica di pace, cercando «la sua salvezza
nella unità di queste grandi potenze» e respingendo
l’ostilità e gli intrighi contro l’Urss,
nelle cui popolazioni «gli operai e la parte più
avanzata dei lavoratori italiani vedono i portatori nel
mondo di una nuova civiltà.
Questa impostazione di politica estera – che postula
conseguentemente, per risolvere il problema di Trieste,
trattative dirette tra Italia e Jugoslavia – si
scontrerà assai presto con le prime, concrete manifestazioni
della «guerra fredda». Queste ridurranno gradualmente
le possibilità di manovra dei comunisti: così,
anche il programma di riforme delineato al congresso rimarrà
in sostanza lettera morta. Nella risoluzione approvata
sono, a questo proposito, esposti degli obiettivi assai
avanzati, che comprendono in primo luogo, accanto alla
riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato,
la riforma industriale e agraria, con la nazionalizzazione
«dei grandi complessi monopolisti, delle grandi
banche e delle compagnie di assicurazione, un inizio di
pianificazione nazionale e l’istituzione di un sistema
di controllo nazionale della produzione, il cui primo
passo sarà la estensione generale e il riconoscimento
dei consigli di gestione» Nel campo agricolo, sono
proposte la liquidazione del latifondo, la riforma dei
patti agrari, la difesa della piccola e media proprietà.
Si tratta di proposte generali, che indicano uno stato
d’animo e una posizione che si possono indubbiamente
definire «di attacco»: pur consapevoli delle
difficoltà, i comunisti escono dal loro V Congresso
– anche per il peso e l’impressione suscitati
dall’imponente crescita numerica del «partito
nuovo» – con un margine evidente di sopravvalutazione
delle possibilità oggettivamente consentite dalla
situazione. In effetti, se si confronta la linea programmatica
tracciata dal documento preso in esame con i risultati
conseguiti praticamente nei due anni successivi, si ha
il senso preciso della sconfitta che il «partito
nuovo» ha dovuto registrare sul piano politico e
su quello economico-sociale. A questa fanno da contrappeso
la formazione di un grande partito di massa e il rinnovamento
istituzionale, configurando nell’insieme, come abbiamo
rilevato più sopra, una sorta di paradosso, che
è all’origine della irripetibile singolarità
di una vicenda storica – quella del Pci –
ormai conclusa.
I temi affrontati nelle discussioni della direzione ripercorrono
i nodi politici del biennio 1946-47: così, dal
risultato delle elezioni amministrative, al referendum
istituzionale, all’esclusione dal governo delle
sinistre, alla lotta contro il governo De Gasperi nella
seconda metà del 1947, si delinea concretamente
il senso profondo della strategia comunista, la «lettura»
che della situazione italiana viene data dai dirigenti
del Pci. Accanto a questi argomenti, non si può
non rilevare lo spazio dedicato, nel dibattito, ai problemi
dello sviluppo stesso del «partito nuovo»,
e, correlativamente, al rapporto con l’Unione sovietica.
Un esame che tenga d’occhio questi diversi piani
– e soprattutto, evidentemente, le loro connessioni
– è destinato a sgombrare il campo da molte
superfetazioni polemiche e mitologiche e da molte incrostazioni
strumentali, offrendo per la prima volta la possibilità
di giudicare la vita del Pci non già sulla base
di categorie discutibili – abbiamo già ricordato
la famigerata «doppiezza» – ma in riferimento
alla concreta realtà storica.
I verbali che ci sono pervenuti riguardano poco meno di
quaranta riunioni della direzione e sono, di norma, sufficientemente
ampi e corretti: solo in qualche caso si tratta di sintesi
o di stesure incomplete. Considerando che accanto alla
direzione operava una segreteria per il lavoro quotidiano,
e il Comitato centrale per il dibattito più ampio,
non si tratta certo di un numero esiguo: la direzione
si riunisce mediamente due volte al mese e affronta in
genere pochi ma definiti punti all’ordine del giorno,
dando vita spesso a una discussione che dura più
giorni. In questa sede ci limiteremo, senza svolgere un
esame analitico del materiale, a qualche osservazione
sui dibattiti – concernenti la Costituente, la crisi
di governo del maggio 1947, la fondazione del Cominform,
la politica economica – che ci sono sembrati più
significativi.
La discussione che si svolge sulla questione istituzionale
si intreccia cronologicamente con la preparazione, e poi
con la concreta effettuazione, delle elezioni amministrative:
le prime votazioni che si tengono in Italia dopo la caduta
del fascismo, e le prime che – con la partecipazione
delle donne – si svolgono a suffragio universale.
Nello stesso tempo, il dibattito tra le forze politiche,
è incentrato sulla scadenza e sui poteri dell’Assemblea
costituente: in questo dibattito si inseriscono due questioni
particolari, quella dell’obbligatorietà del
voto e quella, sollevata dai liberali, di un referendum
che sottragga la scelta istituzionale alla Costituente
per rimetterla al giudizio popolare.
I comunisti sono contrari ad ambedue queste proposte,
ma la situazione è tale che – mentre ottengono
di fatto l’abbandono della prima – non possono
opporsi efficacemente alla seconda. Sul piano politico,
due sono gli obiettivi del Pci, che si tengono a vicenda:
prima di tutto la Costituente, il fine a cui non si può
rinunciare a costo di compromessi anche pesanti; quindi
la presenza nel governo del paese. La discussione interna
mostra che il gruppo dirigente è pronto a concessioni
rilevanti per ottenere questi due risultati, dando prova
di flessibilità e moderazione costanti, ispirate
nello stesso tempo dalla situazione reale – che
non consentiva certo atteggiamenti troppo radicali –
e, come abbiamo già notato, dalle esperienze del
passato (la lezione, in particolare, dell’avvento
del fascismo), profondamente interiorizzate e assimilate
dal vertice del Pci.
Il richiamo al periodo 1919-20, ricorrente in molti articoli
e discorsi dei dirigenti comunisti, non ha infatti un
valore rituale o propagandistico, ma risponde ad effettive
preoccupazioni, mostrando con evidenza quella forma di
sommaria analogia storica a cui, sembra, gli uomini politici
non sanno rinunciare. D’altronde, per quanto riguarda
la Costituente, la vittoria della repubblica al referendum
(ottenuta con un margine assai ristretto di voti favorevoli)
fu preceduta, com’è noto, da manovre e tentativi
che inducono a ritenere la prudenza e i timori dei comunisti
effettivamente fondati. Togliatti non aveva mai dato per
scontato l’obiettivo della Costituente, e aveva
insistito in varie occasioni sulle difficoltà da
superare, denunciando il sabotaggio, la resistenza passiva,
le esplicite riserve degli ambienti più conservatori.
Questi timori – relativi soprattutto al pericolo
di un colpo di Stato monarchico, che appare, immediatamente
prima e immediatamente dopo lo svolgimento del referendum,
come una minaccia reale – sono alla base di una
accentuata preoccupazione difensiva, assai comprensibile
in un partito che aveva vissuto recentemente anni di persecuzioni
e di vita clandestina. Come si può notare, i verbali
della direzione testimoniano questa preoccupazione esclusivamente
difensiva – che certamente, alla base, poteva venire
interpretata in modo diverso – prendendo in esame
anche l’eventualità di una reazione alle
minacce antidemocratiche. Ma indicano soprattutto –
ciò che è molto più significativo
– con quanta attenzione e prudenza i comunisti,
e in particolare Togliatti, valutassero realisticamente
la situazione, e fossero pronti, in sostanza, ad accontentarsi
anche di un successo parziale.
Nella riunione che si tiene alla metà di febbraio,
affrontando lo specifico punto dei poteri della Costituente,
e la proposta di Nenni di accettare il referendum preventivo
sulla questione istituzionale al quale i comunisti si
erano fino a quel momento dichiarati contrari –
Togliatti afferma: «De Gasperi ci vuoi far ricattare
sul tipo di repubblica perché egli pensa di dire:
repubblica si, ma repubblica col crocifisso, col papa
presidente». Longo, che interviene subito dopo,
pone la questione di un eventuale colpo di Stato, ottenendo
da Togliatti una risposta assai indicativa per comprendere
l’analisi della situazione sviluppata dai comunisti.
Per il vicesegretario del Pci «Su questa questione
dovremmo avere un’idea esatta su quello che è
l’atteggiamento degli Alleati perché in ultima
analisi, sul terreno della forza sono essi che decideranno.
Saranno decisi ad impedire una repubblica? Saranno decisi
ad impedire un colpo di mano dei monarchici?». A
questi interrogativi Togliatti risponde: «lo credo
che su questo punto, sul terreno della forza, non possiamo
essere molto sicuri perché la monarchia si organizza
e, poi, sarà aiutata dagli Alleati stessi; poi
ci sono i carabinieri ed anche una parte dell’esercito.
Posta così la questione a me pare che a noi non
convenga arrivare cosi, improvvisamente, non preparati
organizzativamente dal punto di vista di lotta armata
[...]. Io penso che non abbiamo nessun interesse a provocare
un colpo di forza; a noi converrebbe che alle elezioni
non ci sia alcuna provocazione per il colpo di Stato monarchico».
In base a queste considerazioni, il capo del Pci si mostra
disponibile anche ad accettare che il referendum si svolga
dopo le elezioni per la Costituente, affermando: «dovremmo
pagare nel senso che la repubblica non viene fatta il
giorno delle elezioni ma dopo 7-8 mesi e sarà una
repubblica di tipo diverso, col crocifisso ed il papa,
ma sarebbe tuttavia un passo avanti anche se piccolo».
Una posizione che mostra chiaramente quanto fosse considerato
importante – al di là delle caratteristiche
che avrebbe potuto assumere concretamente – l’obiettivo
del rinnovamento istituzionale.
Sulla questione del colpo di Stato, comunque, non tutti
si dimostrano cauti come Togliatti; Di Vittorio, ad esempio,
afferma: «Quanto al colpo di Stato stesso, la sua
possibilità deve essere esaminata seriamente [...];
noi abbiamo una qualche esperienza e possediamo dei quadri
che ci possono permettere di far fronte al colpo di Stato.
[...] non bisogna considerare l’eventualità
di un colpo di Stato come una cosa contro la quale non
abbiamo nulla da fare e da dire. Io penso che il partito
debba rivedere questa eventualità e prendere le
misure necessarie, lavorando, naturalmente, per cercare
di evitare una tale eventualità».
La discussione su questo tema continua con pareri diversi
e anche contrapposti: mentre Togliatti e Longo sono assai
preoccupati, in questo momento, per l’ipotesi del
referendum preventivo, altri, come Li Causi, ritengono
invece che potrebbe essere un vantaggio la contemporaneità
del referendum e delle elezioni. Il problema sarà
risolto pochi giorni dopo, nella riunione della direzione
del 25 febbraio, quando di fatto è stato già
trovato un compromesso sul voto obbligatorio, e dopo che
i socialisti si sono pronunciati a favore di un referendum
da tenersi nello stesso giorno delle elezioni. La direzione
comunista – anche per la possibilità che
venga chiesto un referendum sui poteri della Costituente
– decide di accettare questa proposta: in una brevissima
riunione è quindi messa di nuovo in luce, con maggiore
evidenza, l’importanza attribuita all’obiettivo
fondamentale del partito: ottenere finalmente la Costituente.
Si può anche cedere, per questo, sul tema del referendum,
poiché la vittoria della repubblica è considerata
sicura.
Longo esprime nel modo più chiaro questo atteggiamento,
sottolineando il pericolo di «spaventare»
i ceti medi: «bisogna centrare l’attenzione
sulla repubblica [...] sarebbe conveniente accettare un
referendum preventivo sulla questione monarchia o repubblica.
Nel caso che si dovesse svolgere anche un referendum sui
poteri della Costituente dovranno presentarsi con una
posizione che contenga i poteri in certi limiti che non
spaventino determinate categorie».
Il valore attribuito dai comunisti al mutamento istituzionale,
che in questo medesimo periodo li spinge a una grande
moderazione anche sul piano economico-sociale, attenuando
notevolmente i tratti più immediati e combattivi
della loro stessa identità politica, è forse
anche all’origine del risultato, per certi aspetti
singolare e inaspettato, del 2 giugno: la vittoria della
repubblica, ma la sconfitta, in qualche misura, dei partiti
più dichiaratamente e combattivamente repubblicani
(comunisti e socialisti) rispetto alla Dc. L’impostazione
stessa della campagna elettorale condotta dal Pci –
un’impostazione già adottata, in effetti,
per il primo turno dell’impostazione stessa della
campagna elettorale condotta dal Pci – un’impostazione
già adottata, in effetti, per il primo turno delle
elezioni amministrative – privilegia infatti nettamente,
piuttosto che insistere sui tradizionali temi sociali,
la questione istituzionale.
A questo proposito, si manifestano all’interno della
direzione anche delle significative differenziazioni,
tra chi appunto sottolinea il peso delle questioni economiche
e della competizione con gli altri partiti (Roasio, Teresa
Noce) e chi invece – primo fra tutti Togliatti –
è pronto a grandi concessioni, pur di favorire
tra i partiti democratici un atteggiamento unitario in
favore della repubblica. La linea di composizione e di
sintesi di queste differenziazioni – che rimangono
tuttavia nell’ambito di una semplice varietà
di opinioni, senza delineare veri e propri contrasti –
è comunque assai più vicina alle posizioni
di Togliatti, di Longo, di Secchia che non a quelle dei
dirigenti, citati più sopra, indubbiamente di minor
peso politico.
Non esistono altri verbali espressamente dedicati alla
Costituente, e nemmeno ai risultati del 2 giugno, che
appaiono al partito piuttosto deludenti. Pur avendo infatti,
conseguito l’obiettivo essenziale, cioè la
repubblica, i rapporti di forza usciti dalle urne non
possono non porre ai comunisti qualche problema, in rapporto
alla loro presenza nel governo del paese. E in effetti,
da questo momento fino all’espulsione delle sinistre
dal governo nel maggio 1947, su questo tema vi sarà,
nel gruppo dirigente comunista un teso dibattito, più
o meno esplicito, che ha come sfondo una situazione in
continuo movimento, caratterizzata da una prima incrinatura
nei rapporti interni alla maggioranza già nell’estate
del 1946 (superata con la sostituzione di Corbino al ministero
delle Finanze), poi da due successive crisi di governo;
la prima nel gennaio, la seconda, che porterà infine
alla conclusione dell’unità antifascista,
nel maggio 1947. A questo proposito i verbali recano un
contributo di conoscenza non trascurabile, illuminando
efficacemente i limiti dell’analisi e della percezione
politica del gruppo dirigente.
I comunisti avevano deciso, dopo il 2 giugno, di partecipare
al governo (anche per ragioni «istituzionali»:
basterà richiamare le scadenze del trattato di
pace e della Costituzione), segnalando tuttavia un indubbio
elemento di distacco; Togliatti, infatti, non aveva accettato
cariche governative, per potersi dedicare con maggiore
agio alla guida del partito.
Quanto, tuttavia, questa presenza sia considerata in termini
problematici emerge chiaramente nella riunione della direzione
del 17 settembre; Longo, in questa occasione, afferma:
«Possiamo avere una politica di collaborazione col
governo anche rimanendo fuori. Noi partecipiamo al governo
per far applicare la parte di programma del nostro partito
accettato dal governo e per fare realizzare più
che sia possibile di esso». Secchia replica, al
contrario «che questo non è il momento di
andare alla opposizione. In alcune regioni se noi fossimo
all’opposizione il p.[artito] si troverebbe nella
illegalità [...]. Nel p.[artito] vi è del
“primitivismo”, si pensa che ogni obiettivo
[...] dovrebbe realizzarsi non appena viene posto».
È una posizione condivisa da molti altri, come
Li Causi, il quale sostiene che il partito «deve
continuare la sua linea di unità nazionale».
Queste divergenze di opinione, che si manifesteranno più
esplicitamente nella sessione del Comitato centrale immediatamente
successiva, mettono in luce – anche se l’impostazione
di Togliatti, decisamente favorevole alla partecipazione
al governo, prevale largamente – gli umori e le
tendenze di strati non trascurabili del Pci, preoccupati
di un logoramento del partito, e di una sua debolezza
(che appare come il prezzo del rapporto con la Dc) nel
realizzare il programma di governo. Avendo presenti tali
difficoltà, Togliatti aveva lanciato appunto in
questo periodo il cosiddetto «nuovo corso»
nella politica economica, spingendo il partito a un’azione
che sollecitasse «dal basso», attraverso ampi
movimenti di lotta sociale, la concreta realizzazione
di questo programma. Tuttavia, a prescindere dalle difficoltà
che questa politica incontra nell’organizzazione
del partito, è il rapido peggiorare della situazione
politica che, sostanzialmente, non ne permette un’effettiva
attuazione.
Infatti, la questione del governo, risolta in questa occasione,
si ripresenterà dopo pochi mesi, già all’inizio
dell’anno seguente. Anche se l’espulsione
delle sinistre dalla direzione politica del paese avverrà
solo nel maggio, possiamo considerare la crisi del gennaio
1947 come un primo tentativo in questo senso, operato
da De Gasperi subito dopo il suo viaggio negli Stati Uniti,
in un momento in cui, sul piano internazionale, siamo
alla vigilia del lancio della «dottrina Truman»
(marzo 1947).
Che l’obiettivo del presidente del Consiglio sia
già, nella prima crisi, quello di «sbarcare»
i comunisti e i socialisti dal governo appare piuttosto
evidente, e i comunisti lo rilevano più volte,
a chiare lettere, su «l’Unità».
Questo intento, tuttavia, viene per il momento frustrato,
e la crisi si chiude con una ricostituzione del tripartito
che appare al Pci, in termini di «scampato pericolo»,
come una notevole vittoria. Nella riunione della direzione
del 4 febbraio Togliatti, concludendo una sommaria ricostruzione
degli avvenimenti, nella quale egli valorizza appunto
il successo comunista, affronta il tema delle prospettive
politiche affermando: «De Gasperi ha manifestato
l’intenzione di fare le elezioni a giugno. Ritiene
questo governo come governo di emergenza. Si faranno le
elezioni a giugno? Ne dubito. [ ... ] le elezioni si potranno
fare a novembre.
«Durerà il governo
fino allora? De Gasperi per farlo durare ha chiesto un
impegno di solidarietà. Quest’impegno non
è un gran che. La nostra libertà di critica
resterà presso a poco quella di prima. È
chiaro che ormai tutto quello che si fa viene fatto in
vista dei comizi elettorali».
Comincia a manifestarsi qui un errore di previsione, su
cui occorre richiamare l’attenzione, che non è
solo di Togliatti, ma è condiviso da tutto il gruppo
dirigente. Le elezioni, infatti, subiranno una proroga
dopo l’altra (la data definitiva sarà fissata
solo nel febbraio 1948): l’intenzione di De Gasperi
è verosimilmente quella di votare dopo aver sbarcato
dal governo le sinistre, quando avrà in sostanza
tutto il potere nelle sue mani. Tra l’altro, se
si tiene presente, oltre a ciò che avviene in Italia,
il graduale aggravarsi del clima internazionale, ci si
rende conto di quanto questi continui rinvii abbiano contribuito
al risultato del 18 aprile.
Ma la discussione più significativa avviene nella
riunione della direzione del 5-6 maggio, che precede immediatamente
le dimissioni del governo De Gasperi (a questo punto,
la crisi appare infatti scontata).
La relazione, dedicata questa volta proprio all’esame
della situazione politica, è svolta dallo stesso
Togliatti, che riferisce tra l’altro circa il colloquio
avuto nella mattinata con De Gasperi: questi gli ha parlato
della gravità della situazione finanziaria, e della
conseguente necessità «di una concentrazione
politica che dia alle diverse categorie di consumatori
e produttori italiani la fiducia necessaria per superare
la contingenza».
Togliatti, sulla base di questo colloquio, «ritiene
di poter escludere che l’on. De Gasperi voglia programmaticamente
allontanare il partito comunista dal governo, ma pensa
che voglia tentare la formula dell’allargamento
con i tecnici [...]. In definitiva si dichiara favorevole
all’accettazione dell’inclusione di tecnici
nel governo, ma sottolinea l’assoluta necessità
che vengano, in pari tempo, assicurati alcuni punti fondamentali
nel programma, tali che diano la certezza che il governo
non seguirà la linea di una politica liberistica».
Qual è l’opinione dei membri della direzione
comunista? La maggioranza concorda con la valutazione
di Togliatti: solo alcuni intuiscono e affermano chiaramente
che la manovra tende a «sbarcare» i comunisti
dal governo. In effetti, l’esame della stampa comunista,
durante tutto il tortuoso svolgimento della crisi, conferma
questa mancata percezione, un’assenza di consapevolezza
per certi aspetti sorprendente, che fa indubbiamente il
gioco della Dc.
Il gruppo dirigente del Pci sembra anzi ritenere possibile
un governo che non sia presieduto da De Gasperi, e si
espone in un aperto appoggio al tentativo di Nitti. Le
dichiarazioni di Togliatti in questo periodo, soprattutto
dopo i colloqui con De Gasperi, danno sempre l’idea
di una soluzione vicina e accettabile per i comunisti:
solo alla fine del mese, dopo il fallimento di Orlando,
il tono de «l’Unità» cambia.
Ma fino all’ultimo, il vertice comunista è
propenso a credere in un esito accettabile, e persino
a prendere in considerazione un voto di astensione a un
governo democristiano monocolore.
Nella riunione della direzione che precede immediatamente
la presentazione del nuovo gabinetto alla Costituente,
si stenta ancora, in effetti, a prendere pienamente coscienza
della gravità di ciò che si è ormai
compiuto. Togliatti tiene una breve relazione in tono
difensivo, sostenendo che: «neppure in questa occasione
[quando fu sollevato l’incidente con Sumner Welles]
fu detto chiaramente, anche se tutta l’intonazione
di De Gasperi poteva convincere del contrario, che egli
intendeva escludere i comunisti dal governo». In
questa stessa occasione Spano, appoggiato da Pajetta (ma
controbattuto da tutti gli altri), propone che il gruppo
comunista si astenga al momento della formazione del nuovo
governo. Concludendo il dibattito – che mette in
luce toni e atteggiamenti diversi, tra chi considera l’opposizione
almeno un’occasione per rafforzare il partito (Colombi),
chi addirittura sembra valutaria positivamente (Massola),
chi arriva a postulare un governo ancora democristiano,
ma senza De Gasperi (Negarville) – Togliatti mostra
del resto di non essere ancora convinto che il nuovo ministero
andrà in porto, e ritiene comunque necessario operare
per un largo fronte parlamentare contro De Gasperi, per
un ampio blocco politico che possa far pesare la sua esistenza:
«Se il governo riuscisse ad avere la maggioranza,
mettere subito avanti i motivi contro di esso, sulla necessità
di un controllo sul governo durante le elezioni e su altri
motivi di agitazione. Per il momento, quindi, avere la
linea di votare contro, conquistando il maggior numero
possibile di voti».
Solo nelle settimane successive il Pci prenderà
pienamente coscienza dell’entità della sconfitta
subita, avviando – con un indubbio ritardo –
un ripensamento dell’esperienza governativa e del
suo esito deludente, al quale contribuiranno anche le
pesanti critiche mosse ai comunisti italiani alla riunione
costitutiva del Cominform, nel settembre 1947.
Il dibattito che si svolge in direzione, tra il 7 e il
10 ottobre 1947, sulla fondazione del Cominform e sull’operato
della delegazione italiana è di rilevante importanza
per una comprensione approfondita di tutta la successiva
politica del Pci. Dopo la relazione tenuta da Longo, che
prende atto della divisione del mondo in due blocchi e
sostiene quindi la necessità di «modificare
[...] la nostra linea politica», si apre una discussione
che assume in qualche momento toni aspri e risentiti:
il primo a prendere la parola è Terracini il quale
solleva delle riserve sui poteri della delegazione italiana
(«Le questioni che sono state poste alla conferenza
di Varsavia sono di una tale importanza che solo il Comitato
centrale e forse anche il congresso hanno il potere di
deciderle [...] i nostri compagni sono andati con una
scadente e insufficiente informazione; né, del
resto, essi erano stati precedentemente informati del
tema e degli scopi della discussione») e infine
afferma: «Si va dunque verso un acutizzarsi della
situazione; ma se noi cambiassimo oggi, radicalmente,
la nostra politica, perderemmo i contatti con gli altri
ceti, anche se la classe operaia e i contadini potrebbero
temporaneamente rafforzarsi. Qualche correzione si può
sempre fare, ma non mi sembra che la nostra politica debba
essere sottoposta a profonde modifiche».
La posizione di Terracini – che aveva mosso dei
rilievi anche alla politica estera sovietica, anticipando
in qualche modo le posizioni espresse qualche giorno dopo
nella famosa intervista sulla situazione internazionale
– rimarrà del tutto isolata nel dibattito,
e anch’egli, alla fine, approverà l’operato
della delegazione italiana e i risultati della conferenza
del Cominform: eppure, nonostante le critiche di cui sarà
oggetto da parte di molti intervenuti, si può osservare
che la sua argomentazione è in ultima analisi condivisa,
per ciò che riguarda la politica del partito, da
tutti i dirigenti di maggior peso. Così, ad esempio,
Scoccimarro, pur nell’ambito di un apprezzamento
per la fondazione del Cominform che risente esplicitamente
di una visione ideologica della situazione internazionale
(«L’internazionale non è mai stata
sciolta nel cuore di ogni comunista e perciò io
saluto con entusiasmo la creazione di questo Ufficio»)
dichiara: «Sono d’accordo che siano stati
commessi degli errori, ma non credo che occorra portare
oggi un mutamento sostanziale alla nostra linea».
La posizione espressa dopo questa affermazione tende quindi
ad accettare le critiche dei sovietici, ma entro limiti
precisi, senza mettere in discussione la strategia di
fondo del Pci; su questa linea, lo sforzo che faranno
anche altri intervenuti sarà quello di valorizzare
tutti gli elementi di ripensamento e di autocritica già
affiorati nei mesi prece denti, subito dopo l’esclusione
dal governo, ed esposti in modo particolare nelle lettera
inviata il 16 agosto a tutte le organizzazioni di partito
dalla direzione.
Accanto a questa impostazione, si manifesta anche un orientamento
più «duro», attraverso il quale si
esprimono atteggiamenti che giudicano assai probabile
uno svolgimento «catastrofico» della situazione
internazionale, e di conseguenza si preoccupano di attrezzare
il partito per ogni evenienza, ritenendo la lotta parlamentare
priva di prospettive. Chi accentua questi aspetti utilizza
in genere un lessico accentuatamente ideologico, ribadendo
il primato e il ruolo guida dell’Unione Sovietica:
così Colombi afferma che il linguaggio di Terracini
«mi pare non sia un linguaggio da bolscevico [...]
corriamo il pericolo di abdicare alla nostra qualità
di militanti bolscevichi che riconoscono nel Partito comunista
dell’Unione Sovietica il partito dirigente della
classe operaia mondiale [...] dobbiamo, con tutte le nostre
forze, impedire che l’Italia diventi una base di
partenza per l’imperialismo americano ed a questo
scopo occorre portare le masse sul terreno dei grandi
scioperi, senza sacrificare alle fortune elettorali la
necessità della lotta e del combattimento; occorre
cioè vedere se non riusciamo noi a fare ai reazionari
quello che essi vorrebbero fare contro di noi».
Si può dire quindi che il dibattito mette di fronte,
più chiaramente che in altre occasioni, due schieramenti
che mostrano una notevole differenza di vedute, pur convenendo
nell’esprimere una critica comune a Terracini (e
anche all’operato insufficiente di cui ha dato prova
la direzione, e lo stesso Togliatti, nel tradurre in pratica
i necessari elementi di correzione già individuati).
La composizione di questi contrasti avviene, nella replica
di Longo e nell’intervento conclusivo di Togliatti,
su un terreno che accoglie le critiche avanzate, ma senza
trarne tutte le implicazioni, spostando piuttosto il discorso
sulle insufficienze organizzative del partito e sulla
sua difficoltà ad applicare concretamente una linea
giusta: un terreno per così dire mediano, che in
qualche modo nasconde una contraddizione fondamentale
della politica comunista; una contraddizione che vale,
tuttavia, a salvaguardare l’unità del gruppo
dirigente e del partito.
È infatti proprio
l’accoglimento delle critiche mosse all’azione
del Pci in Italia, accompagnato da manifestazioni di omaggio
e di fedeltà alla politica internazionale dell’Urss,
che consente di non mettere sostanzialmente in discussione
la strategia di fondo e la scelta del terreno democratico,
salvaguardando un margine importante di autonomia: il
duro attacco a Terracini – che, per quanto riguarda
la situazione interna, come abbiamo notato, non esprime
una posizione divergente da quella degli altri membri
della direzione – ha anche questa precisa funzione,
in parte, strumentale.
Togliatti, in un discorso che pone termine alla discussione
con toni difensivi e anche interlocutori («mi pare
che [discussione] debba essere considerata come un primo
scambio poiché solo così possono giustificarsi
alcune incertezze, la mancanza di una linea nuova e gli
smarrimenti che qua e là si sono intravisti negli
interventi dei compagni») riprende tutta la tematica
del partito bolscevico, rincarando la dose contro Terracini
e ricordandogli i suoi passati contrasti col partito:
ma per quanto riguarda le osservazioni alla politica del
Pci espresse dal Cominform, afferma: «La critica,
ad ogni modo, non investe tutta la nostra linea; la critica
è giusta soprattutto se si tiene conto del modo
di sviluppo del nostro partito [Occorre dire al partito
che ci sono delle deficienze tali che, se non corrette,
non gli permetteranno di fare dei passi in avanti e di
resistere con successo agli avvenimenti. Bisogna impostare
la critica in modo che non esasperi o scoraggi il partito
e la classe operaia e respingere quella che giustamente
un compagno ha definito la psicosi delle occasioni perdute».
La riunione si conclude con l’approvazione unanime
dell’operato della delegazione italiana alla riunione
costitutiva del Cominform, registrando un sostanziale
accordo interno (di cui la critica a Terracini è
un fattore non trascurabile). Ma, su un diverso piano
di analisi, è anche un’occasione importante
per comprendere la mentalità e la formazione dei
dirigenti comunisti, così come lo sfondo teorico
e le contraddizioni della politica comunista.
I verbali costituiscono, come abbiamo visto in riferimento
ad alcuni temi politici fondamentali del periodo costituente,
un materiale essenziale per comprendere le scelte di fondo
del Pci; ma i dibatti ti interni valgono anche come fonte
e testimonianza preziosa da un altro punto di vista, consentendoci
di investigare efficacemente l’ideologia stessa
del gruppo dirigente comunista.
Intendiamo qui per ideologia non l’adesione alla
teoria e alla prassi del marxismo-leninismo – a
cui, in questi documenti, non troviamo riferimenti –
ma l’insieme dei criteri di fondo che guidano, non
sempre consapevolmente, il ragionamento politico, condizionando
l’attività concreta; le convinzioni fondamentali,
cioè – di carattere non solamente teorico,
ma piuttosto storico e politico – che sono alla
base dell’analisi e dell’interpretazione della
realtà italiana e internazionale, dello stesso
modo di inquadrare e affrontare i problemi da parte del
vertice comunista. Uno sfondo culturale comune, in ultima
analisi, che orienta la «lettura» della situazione,
costituendo un importante fattore – pur nella delineazione
di posizioni e gruppi diversi – dell’elaborazione
e della stessa unità politica della direzione.
Si tratta prima di tutto della convinzione – che
unifica verosimilmente il partito nel suo complesso, e
che occorre tenere ben presente al di là della
sua apparente ovvietà – di «avere dalla
propria parte il futuro». L’intero gruppo
dirigente comunista – cioè, verosimilmente,
tutto il partito – appare infatti convinto che lo
sviluppo storico ha ormai irreversibilmente condannato
il capitalismo e che il socialismo – non dimentichiamo
l’impatto straordinario della vitto ria dell’Urss
contro le potenze dell’Asse – è destinato
a breve scadenza a trionfare.
Possiamo parlare, in questo senso, di un elemento ideologico
di tipo inconsapevolmente millenaristico, che prende la
forma di una sorta di storicismo deterministico, «razionalmente»
sicuro dell’imminente successo del movimento operaio:
un fattore di cui oggi è evidentemente difficile
comprendere tutta l’importanza, ma che certamente
ha giocato un ruolo effettivo e considerevole nell’analisi
e nelle impostazione del Pci
Su questa base si spiegano affermazioni che, a cinquant’anni
di distanza, possono apparire sorprendentemente ingenue,
ma che allora facevano parte del senso comune dei comunisti
(e dei socialisti) di tutto il mondo, e che non a caso
accompagnano la politica del «nuovo corso»
lanciata da Togliatti, come abbiamo visto, dopo il 2 giugno
1946: «La proprietà italiana, se vuole salvarsi,
deve rammentare una buona volta che la legge della conservazione
intelligente [...] si esprime in questi termini: perdere
ogni giorno metodicamente qualcosa per non perdere tutto.
Solo così, la conservazione si allea alla storia
e può rientrare nello sviluppo della democrazia.
Altrimenti perde tutto»
Argomentazioni di questo genere, che costituiscono una
sorta di saldo retroterra storico-politico di tutta la
strategia del «partito nuovo», se ne potrebbero
individuare parecchie, nei documenti e nei discorsi dei
leader comunisti. Nei verbali della direzione, pur non
espressa in forma così evidente, questa certezza
nel futuro si manifesta spesso indirettamente; il riferimento
più significativo è forse il richiamo all’Urss,
alla sua funzione e alla necessità di non avere
esitazioni nel propagandare le conquiste e i traguardi
raggiunti dal «paese del socialismo».
È lo stesso Togliatti, in varie occasioni, a rilevare
come, su questo piano, gli sforzi del partito appaiano
insufficienti, e sia invece opportuno diffondere l’idea
della «superiorità del socialismo»;
il gran de prestigio internazionale dell’Urss, la
potenza mondiale che garantisce con la sua stessa esistenza
l’indubitabile vittoria della classe operaia, dev’essere
convertito in un’arma di propaganda e di penetrazione
nella società italiana, alla quale sarebbe assurdo
rinunciare per timore di effetti controproducenti.
Analizzando i risultati del lavoro di partito nella campagna
elettorale per le amministrative, il segretario del Pci,
nella riunione del la direzione del 9-10 aprile 1946,
afferma a questo proposito: «Secondo me vi è
una enorme deficienza politica per quello che riguarda
la Russia; noi non facciamo propaganda per la Russia,
abbiamo paura, ciò è sbagliato perché
la gente diventa fredda e pensa che il nostro silenzio
vuol dire che quegli altri hanno ragione.
«Occorre
quindi fare una propaganda per la Russia sui quotidiani
ed anche con del materiale di propaganda [...]. Noi dobbiamo
dimostrare la forza della Russia, la possibilità
di questo paese, quello che potremmo avere se gli fossimo
amici e così via».
Più avanti, dopo aver osservato che occorre controbattere
più efficacemente le calunnie contro la Russia,
Togliatti propone di utilizzare, a fini propagandistici,
«un film sovietico (quello, per esempio, della parata
sportiva sulla Piazza Rossa)», e a questo punto
lo interrompe Pajetta: «Noi abbiamo pensato che
la visione di un tale film possa essere controproducente».
Togliatti «Non credo; si tratta di un film che fa
vedere come alcune settimane dopo la fine della guerra
la Russia ha ripreso la sua attività di pace. Fa
vedere lo sviluppo di quella gente, la ricchezza di quel
paese; non capisco come debba essere controproducente
un film a colori tecnicamente perfetto. Credi che producano
qualche cosa i film dei gangsters americani? C’è
qui un errore di impostazione politica dei nostri compagni
e tale errore bisogna correggerlo».
Così il mito dell’Unione Sovietica (e di
Stalin) sarà utilizzato ampiamente nell’opera
di acculturazione politica delle masse che il vertice
comunista persegue costantemente: in questo mito –
vale a dire, in ciò che appariva allora una solida,
determinante realtà – si riassumeva in effetti
un essenziale punto di forza, nel quale si confondevano,
potenziandosi a vicenda, il peso statuale di una grande
potenza e un elemento ideologico (la realizzazione del
socialismo) che costituiva la legittimazione stessa dell’esistenza
e della funzione del Pci.
Il ruolo di tale fattore diverrà ancora maggiore,
evidentemente, quando il partito, in concomitanza con
l’aggravarsi della situazione internazionale, sarà
costretto all’opposizione: allora il punto di riferimento
politico costituito dall’Urss – e dai paesi
di «democrazia popolare» – assolverà
a una funzione decisiva di identità e di forza,
fungendo da contrappeso agli avvenimenti interni e «materializzando»,
per così dire, la speranza nel futuro. Non è
un caso, ci sembra, che proprio in questo momento tornino
le recriminazioni sulla tiepidezza del partito nel difendere
l’Urss e siano a maggior ragione ritenute del tutto
inaccettabili le posizioni espresse da Terracini nell’intervista
all’international News Service» che abbiamo
già ricordato.
Nella riunione della direzione (25 ottobre 1947) che discute
proprio questo problema – risolto poi con una sostanziale
autocritica di Terracini nel successivo Cc dell’11-13
novembre 1947 – si manifestano contro il presidente
dell’Assemblea costituente toni e atteggiamenti
molto aspri: assai significativo è il fatto che
la posizione di Terracini sia ritenuta del tutto inconcepibile
per un comunista, sia cioè connessa immediatamente
all’ideologia, e anzi alla stessa unità del
partito. Togliatti, introducendo brevemente la riunione,
sottolinea infatti che «non è assolutamente
possibile che i membri della direzione non condividano
la linea politica del partito». E Giuliano Pajetta
si collega nel suo intervento a questa affermazione, con
parole che richiamano l’eco della tradizione cominternista:
«Le spiegazioni date oggi da Terracini non vanno.
Come si può lottare per l’unità ideologica
del partito quando le divergenze si verificano anche in
seno alla direzione? [...]. Ritengo che la direzione non
possa accontentarsi, come l’opinione pubblica, della
smentita e della rettifica di Terracini. Tutto il partito
sa delle discussioni che si sono avute con Terracini e
chiede, secondo me giustamente, spiegazioni esaurienti».
La critica all’Unione Sovietica è così
ritenuta un elemento di dissenso politico-ideologico intollerabile,
fino a suggerire che questa stessa critica possa essere
la spia di un dissenso relativo a tutta la linea del partito;
Reale dirà infatti, nel suo intervento: «Sono
d’accordo nel considerare assai grave l’intervista
di Terracini; gravi e insoddisfacenti sono, del resto,
le sue giustificazioni. Io ritengo che Terracini non sia
d’accordo su tutta la nostra linea e in particolare
non è d’accordo sulle decisioni di Varsavia».
E Sereni, assente alla riunione, scrive dell’atteggiamento
di Terracini, in una lettera inviata su questo tema alla
segreteria come di un’«effettiva opposizione
alle decisioni della direzione».
Così, l’ideologia del Pci individua nell’Urss
– l’espressione tangibile della certezza nella
vittoria della classe operaia – un primo, essenziale
elemento costitutivo, ben più importante e significativo
dell’ossequio formale al marxismo-leninismo, ripetuto
in qualche rara occasione in modo piuttosto liturgico
(e che fa parte di un armamentario teorico, sostanzialmente
esteriore) La fedeltà all’Urss come «paese
del socialismo» – anche se non come modello
di socialismo; ancora nella relazione ai VI Congresso
(gennaio 1948) Togliatti parlerà infatti di una
«via italiana», formula che aveva già
usato al la Conferenza di organizzazione tenuta a Firenze
nel gennaio 1947 – indica d’altronde il primato
della politica «realistica» (che privilegia
i rapporti di forza, il valore e il peso delle istituzioni,
la potenza statuale) nella impostazione generale del Pci,
e non solo sui piano della politica internazionale. La
medesima impostazione guida infatti l’attività
del «partito nuovo» nella situazione italiana:
qui, parlando di ideologia, dovremmo parlare più
precisamente di principi di analisi politica, di teoria
e pratica del «partito nuovo», e soprattutto
– a nostro parere – dell’elaborazione
dell’esperienza del passato, per cercare di comprendere
le connessioni e il grado complessivo di coerenza di questi
diversi piani.
I verbali della direzione offrono, per un esame di questo
tipo, indicazioni e materiali importanti, che vanno dai
richiami espliciti alle «lezioni» della storia
più recente, ai frammenti di analisi e di interpretazione
della realtà italiana che sostengono determinate
scelte, al linguaggio stesso usato nelle discussioni,
che presenta oscillazioni e mutamenti assai significativi
e registra, dopo la costituzione del Cominform –
un avvenimento che «periodizza» indubbiamente
la storia del Pci, approfondendo l’elemento di svolta
costituito dalla crisi del maggio 1947 – una evidente,
maggiore permeabilità alle formule della tradizione
comunista (così, in qualche occasione, Togliatti
definisce di «fronte popolare» la politica
nei confronti degli altri partiti democratici, mentre
la «democrazia progressiva» si identifica
talvolta con la «democrazia popolare», ecc.).
D’altronde, il primato del realismo politico che
salda, in ultima analisi, i vari livelli di attività
e di consapevolezza del Pci, componendoli in una strategia
unificante, discende dallo stesso atto di nascita del
«partito nuovo», che si può individuare
nella «svolta di Salerno»: un effettivo «compromesso
storico» che implica anche, a ben vedere, un accordo
preciso sul terreno della continuità dello Stato-apparato,
dello Stato-amministrazione, mentre stabilisce, nello
stesso tempo, il predominio dei parti ti nella fondazione
del futuro Stato democratico.
La «svolta di Salerno» rappresenta però
anche l’ultima espressione della politica dei «fronti
popolari» adottata al VII Congresso del l’Internazionale
comunista: già nella genesi, quindi, di un rinnovamento
straordinario del partito comunista, è presente
un fattore di continuità, di richiamo alla tradizione.
Questi due elementi non cessano di agire nel periodo costituente,
disponendosi in una sorta di originale equilibrio, e,
mentre ancorano l’azione del «partito nuovo»
a un’analisi in ogni momento realistica e spregiudicata
della situazione, ne condizionano nello stesso tempo,
almeno in parte, gli sviluppi e le prospettive, mantenendo
in un ambito oggettivamente determinato la sua libertà
di movimento.
Nei dibattiti della direzione, questa sorta di premessa
originaria, di limite costitutivo non espresso, appare
molto evidente per la stessa relativa assenza di un preciso
esame della situazione economico-sociale dell’Italia;
i frammenti di ricerca e di interpretazione che sono reperibili
nei verbali appaiono largamente condizionati dall’analisi
politica in senso stretto, dalla considerazione delle
forze in campo e delle alleanze possibili, e infine dalle
opportunità del momento, che guidano le scelte
del partito anche sui terreno più immediato delle
lotte sociali e delle rivendicazioni economiche.
Nella riunione del 16-18 aprile 1947, dedicata alla «Politica
e all’azione del partito nella situazione presente»
(la relazione è tenuta da Longo), Togliatti esprimerà
nel modo più esplicito questa impostazione, affermando:
«Noi facciamo una politica di alleanza di classi,
questa è la verità; la nostra politica di
fronte popolare, di unità nazionale, di collaborazione
con tutte le forze che vogliono dare un contributo positivo
alla ricostruzione del paese nell’interesse di tutta
la nazione e non di pochi gruppi privilegiati, è
effettivamente una politica di alleanza di classi. Da
questa politica ricaviamo determinate conseguenze nel
campo politico; essa ci porta a compiere determinati atti,
a dare determinati voti in Parlamento, a contenere determinate
campagne, a limitare lo slancio aggressivo delle masse
in determinati momenti per non compromettere i risultati
che vogliamo ottenere e cioè di realizzare una
alleanza politica ed anche di classe con quelle forze
che possono essere nostre alleate nella lotta per raggiungere
determinati obiettivi fondamentali».
Ma, aggiunge subito dopo il segretario del Pci, questo
non deve farci dimenticare le leggi della lotta di classe
che agiscono nel paese, in una «società capitalistica
in sfacelo, in decomposizione in conseguenza della guerra
e di tutte le altre cose e nella quale i vecchi gruppi
dirigenti capitalistici conducono una lotta disperata
per non perdere le loro posizioni» (qui si manifesta,
con evidenza, quello storicismo deterministico che abbiamo
richiamato a proposito della fiducia del gruppo dirigente
nell’ineluttabilità del socialismo). Togliatti
rileva appunto che le necessità politiche concrete
possono indurre a falsare l’analisi della realtà,
possono cioè dissimulare l’acutezza dello
scontro sociale, introducendo nelle file comuniste una
visione della situazione inconsapevolmente deformata:
e non a caso questo avvertimento si iscrive in un periodo
in cui l’aggravarsi del contesto internazionale
fa credere in un imminente pericolo di guerra (e di repressione
anticomunista).
Nelle parole del segretario generale del Pci colto appunto
un dato generale, riscontrabile agevolmente nei dibattiti
precedenti; in effetti, la «lettura» e l’interpretazione
della realtà italiana non solo risente dell’impostazione
politica generale del partito nuovo ma, in una certa misura,
ne fa parte in termini subalterni, la giustifica. Potremmo
dire che il gruppo dirigente del Pci, in questo senso,
elabora e realizza una strategia in cui l’assenza
di schemi politici rigidamente ideologici (nel senso ph
tradizionale del termine), ovvero il suo stesso spregiudicato
realismo, ottunde in parte la visione delle cose, stimolando
ad esempio una relativa fiducia nella Dc che non troverà
riscontro nei fatti.
Ciò avviene anche per i condizionamenti inevitabili
connessi al più «potente» strumento
d’analisi e di conoscenza concreta della realtà
italiana che il gruppo dirigente ha a disposizione: cioè
lo stesso partito, con la sua organizzazione ramificata
e in rapida espansione, e con il rapporto privilegiato
– ma anche, evidentemente, parziale – che
stabilisce nei confronti di precisi strati e gruppi sociali
(i mezzadri dell’Italia centrale, i forti nuclei
operai dei centri settentrionali, ecc.).
E infatti il «partito nuovo» uno dei temi
centrali di questi verbali, in un doppio senso: da un
lato in quanto esplicito oggetto delle cure del vertice,
destinatario di messaggi e di indicazioni che devono tradursi
efficacemente in pratica per realizzare la politica comunista;
dall’altro in quanto organismo in crescita che «si
fa sentire», più o meno direttamente e consapevolmente,
attraverso le esigenze e le tensioni espresse dalle migliaia
dei suoi iscritti, il loro senso comune e la loro ideologia
(su cui sarebbe necessario fare un discorso a par te)
così come attraverso le richieste e le manovre
dell’apparato. In fatti, l’aderenza del «partito
nuovo» – il più grande dei partiti
di massa italiani – alla società nazionale,
mentre trasmette impulsi, correnti, percezioni collettive,
e funziona da tramite, da canale privilegiato, tra il
paese e il gruppo dirigente, costringe quest’ultimo
anche a «venire a patti» con una realtà
politicamente e culturalmente più arretrata, che
potrà essere modificata solo gradualmente.
Ciò costituisce evidentemente un punto da tener
presente per impostare su basi più corrette il
tema già citato della «doppiezza»,
che rimanda non solo ai differenti piani e livelli di
consapevolezza e di esperienza politica presenti nel Pci
– un fenomeno inevitabile in qualunque organismo
complesso, e certamente acuito, in questi anni, dalla
tumultuosa rapidità di crescita degli iscritti
– ma anche alla diversità dei relativi tempi
di mutamento e di sviluppo. La stessa complessità
del «partito nuovo» – che è,
nello stesso tempo, ideologia, apparato, strategia, soggettività
collettiva ed altre cose ancora – rende infatti
problematica e non lineare la relazione dinamica tra i
diversi tempi di sviluppo interno: l’ideologia non
«si muove» con io stesso ritmo delle esperienze
politiche concrete, e queste, che posso no essere considerate
il fattore essenziale di sviluppo del partito, non provocano
certo un immediato adeguamento della struttura organizzativa,
più rigida e di conseguenza più lenta (e
si potrebbe continuare). Cosi, la sfasatura tra questi
diversi piani, di cui la cosiddetta «doppiezza»
dà conto solo in termini deformati e riduttivi,
appare all’origine di molti elementi di ambiguità
e di incertezza: come il mancato adeguamento, che il vertice
non tralascia di criticare, dell’azione pratica
alla linea elaborata, o, viceversa, l’espressione
di tendenze e manifestazioni contrarie alla strategia
del partito.
La scelta del partito di massa – riprendiamo il
filo più puntuale del nostro discorso – si
traduce infatti, concretamente, nella larga adesione di
categorie omogenee, unificate da medesime condizioni di
vita e di lavoro, che costituiscono una base di fronte
alla quale il gruppo dirigente si mostra consapevolmente
responsabile; si tratta prima di tutto di sviluppare il
carattere «realizzatore» del partito, di conseguire
cioè dei risultati positivi, concreti, anche sul
piano economico, per evitare la possibilità di
esplosioni sociali incontrollabili Togliatti, osservando
l’importanza di questo terreno di intervento, mette
in luce acutamente la maggiore capacità dell’organizzazione
comunista nel capeggiare e promuovere agitazioni per obietti
vi immediati (manifestazioni di disoccupati, cortei e
proteste contro il carovita, ecc.) rispetto a quella di
individuare e imporre soluzioni per i problemi di fondo,
rilevando i pericoli che possono derivarne in situazioni
determinate. Affrontando le condizioni dei braccianti
del Polesine, che vivono in condizioni miserevoli e senza
prospetti ve di miglioramento, il segretario del Pci afferma
a questo proposito (verbale del 16-18 aprile 1947): «Quando
chiedi a quei compagni: “Qual è la prospettiva
che voi avete? Cosa avverrà qui, fra un anno?”.
I compagni più intelligenti ti dicono: “Se
il partito, fra un anno, non avrà il pugno duro,
qui scoppia tutto perché la gente non può
andare avanti”; e pensate che lì vi sono
dei casi di sommossa dei braccianti che vorrebbero far
saltare gli argini del Po; voi capite che vuoi dire una
cosa simile; non è solo l’interruzione del
traffico sulla via Emilia, ma la cosa è più
grave; lì vi è un problema di riforma agraria,
di investimenti di capitali, di trasformazione di culture».
Il passaggio fondamentale che il «partito nuovo»
deve compiere, per innovare effettivamente la prassi tradizionale,
consiste quindi nel passare dalla propaganda e dall’agitazione
alla capacità di intervenire nei fatti, di realizzare
soluzioni effettive per i problemi sociali. È chiaro
invece che l’ideologia più popolare alla
base del Pci è quella della lotta rivendicativa
immediata, delle agitazioni sociali di protesta, di una
combattività diffusa ma non sempre incisiva e intelligente,
in cui si esprime – sulla base delle reali difficoltà
della situazione – tutto il peso di un antico ribellismo.
Si tratta allora di contemperare esigenze diverse e in
parte contraddittorie che si riflettono, nei verbali,
in una lettura delle condizioni economiche-sociali dell’Italia
che, mentre individua l’arretratezza di aree importanti
del paese (i residui latifondistici nel Mezzogiorno),
non è del tutto priva di orientamenti più
moderni. Così Togliatti, esponendo dopo il 2 giugno
1946 il «nuovo corso», si rifà a un’impostazione
esplicitamente keynesiana, nella quale si riflette un’analisi
che ha come punti di riferimento l’esperienza di
paesi più avanzati, come l’Inghilterra e
gli Stati Uniti. Appare piuttosto come limite, su questo
piano, la «dipendenza» dai movimenti sociali
che si delineano spontaneamente nel paese che evidenzia
come la preoccupazione di controllare e indirizzare le
lotte dei lavoratori prevalga spesso su considerazioni
più profonde.
Da questa esigenza deriva la particolare attenzione del
vertice comunista ai problemi del sindacato, in un periodo
in cui quest’ultimo presenta una debolezza organizzativa
notevole, che spinge Di Vittorio a chiedere a più
riprese un aiuto in termini di quadri e di sostegno politico.
La sensibilità di Togliatti per lo sviluppo del
sindacato, e per le sue specifiche esigenze, appare, nei
dibattiti della direzione, superiore a quella degli altri
membri, che su temi particolari – come lo sblocco
dei licenziamenti – manifestano chiaramente un atteggiamento
di immediata tutela «politica» dei lavoratori,
non sempre in accordo con le misure economiche ritenute,
dallo stesso Di Vittorio, indispensabili.
In generale, del resto, proprio sul piano delle misure
economiche, la situazione non si presenta certo favorevole
per i comunisti, soprattutto perché i partiti moderati
hanno la possibilità di far giocare a loro vantaggio
l’arma del ricatto politico: l’esempio classico
è quello del mancato cambio della moneta. Infatti,
di fronte alla minaccia di un ulteriore rinvio della Costituente,
il Pci rinuncia a irrigidirsi sulla questione del cambio,
abbandonando di fatto, nella riunione del Consiglio dei
ministri dell’il gennaio 1946, questa richiesta
(sulla quale aveva particolarmente insistito, anche in
sede di partito, Scoccimarro, allora ministro delle Finanze).
Non è questa, tuttavia, l’unica ragione dell’atteggiamento
comunista: soprattutto Togliatti – come ammetterà
in seguito – ritiene che il cambio della moneta
sia una misura sgradita alle masse conta dine, verso le
quali il «partito nuovo» si sforzava di realizzare
una politica di alleanza. Tanto è vero che il Pci
non chiederà l’inserimento di questa misura
nel programma del secondo governo De Gasperi, e neanche
nel «nuovo corso economico» lanciato nella
seconda metà del 1946. Nel terzo gabinetto De Gasperi,
i comunisti perderanno inoltre il ministero delle Finanze
(accorpato con quello del Tesoro e affidato a Campilli),
nonostante che Scoccimarro avesse minacciato, in questo
caso, un ritiro del Pci dal governo. Invece, il rospo
viene ingoiato, per salvaguardare – al di là
degli obiettivi economici perseguiti – la formula
del tripartito.
Anche per queste intrinseche motivazioni di opportunità
politica, non si discute troppo dell’economia italiana
nelle riunioni della direzione, e nemmeno delle modalità
della ricostruzione: i problemi economici valgono soprattutto
nel loro significato politico, o in riferimento a determinati
movimenti di lotta Questo indubbio condizionamento, recato
dallo stesso imponente organismo di un partito di massa
in tumultuoso sviluppo, non impedisce comunque che si
discuta approfonditamente delle prospettive economiche
almeno in un’occasione, cioè nella riunione
– già citata più volte – del
16-18 aprile 1947. Longo, introducendo la discussione,
affronta il tema del prestito finanziario degli Stati
Uniti all’Italia, e della possibilità di
mantenere l’alleanza con la Dc riuscendo nello stesso
tempo a conseguire dei risultati concreti sul piano di
una ricostruzione «progressiva», che tuteli
i ceti più disagiati e preveda una qualche forma
di intervento dello stato nell’economia. In questa
occasione – che ha luogo quando è già
nell’aria la crisi che escluderà le sinistre
dal governo – il gruppo dirigente dà vita
un dibattito in cui il realismo politico ed economico
trovano probabilmente, in un reciproco equilibrio, la
loro espressione più avanzata, e il punto estremo
di elaborazione.
Longo si dichiara a favore del prestito internazionale
all’Italia, manifestando una spregiudicatezza che
non sarà reiterata, in condizioni politiche nazionali
e internazionali mutate, di fronte al successivo piano
Marshall: «Se noi comunisti facciamo nostra una
politica che tenga conto della necessità e delle
condizioni per cui è possibile avere dei prestiti,
io credo che noi non saremmo di ostacolo – anche
se fossimo dirigenti del governo – per avere questi
prestiti; cade quindi ciò che si cerca di fare
apparire sui giornali e cioè che una possibilità
di collaborazione economica si può avere solo escludendo
i comunisti dal governo. [...] la finanza internazionale,
oltre a perseguire degli scopi politici, persegue anche
degli scopi economici ed una nostra politica favorevole
dovrebbe smontare il buon gioco che essa finanza ha oggi
dicendo che occorre eliminare noi dal governo perché
essa possa addivenire ad una collaborazione economica».
Longo propone quindi: «nel campo della ricostruzione:
prestito; nel capo della produzione: assicurare allo Stato
leve di comando economiche (nazionalizzazioni, riforma
dell’Iri); nel campo dell’alimentazione: assicurare
l’indispensabile ai lavoratori e alla povera gente».
Il dibattito che segue si presenta di fondamentale importanza
per cogliere, in un momento cruciale, l’ideologia
del gruppo dirigente cioè, appunto, la sua valutazione
complessiva della situazione, i criteri di analisi della
realtà, i limiti soggettivi della percezione politica.
Pur essendo costante il riferimento alle questioni economiche
– che, come in tutti i momenti di crisi effettiva,
assumono un peso assai rilevante, se non decisivo –
la sostanza riguarda infatti la prospettiva che il «partito
nuovo» ha davanti a sé sulla quale si manifestano
differenziazioni e divergenze non secondarie. E, in questo
quadro, colpisce ancora una valutazione della politica
democristiana – presente in molti interventi –
che denota un’evidente mancanza di analisi critica.
Cosi Sereni afferma: «Il problema politico che nasce
è questo: il prestito estero si farà contro
di noi o con noi? E qui si inquadra il problema della
situazione politica generale [...] È mia impressione
che De Gasperi si renda conto che senza i comunisti al
governo egli non può restare [...]. Io credo che
De Gasperi comprenda che una politica apertamente reazionaria
non giova a lui e che la Dc si liquiderebbe, in un processo
di questo genere».
A questa considerazione positiva si contrappone apertamente
Colombi, affrontando il problema nei suoi termini politici
di fondo: «vi è nella nostra prospettiva
una possibilità di accordo con la Democrazia cristiana?
Fin dove è possibile, a noi, continuare una politica
di accordi con la Dc su delle basi che ci portino al compimento
delle riforme strutturali e soprattutto ci portino a venire
in contro ai bisogni delle masse?». Per Colombi,
questa domanda è retorica: «io non penso
che la Dc marcerà a fondo sulla nazionalizzazione,
non penso che essa, nella condizione in cui è oggi,
accetterà di fare una politica tendente a far pagare
veramente alle vecchie classi dirigenti, io non penso
che si possa fare affermare il concetto che l’Iri
diventi uno strumento della politica economica del governo
fino a che la Dc è partito dirigente del governo».
Tuttavia, nel dibattito questo problema rimane sullo sfondo,
«dietro» i temi economici. Così il
verbale ci fornisce una documentazione preziosa anche
dei punti-limite, dei capisaldi economici sui quali, dopo
tre anni di deludente collaborazione governativa, i comunisti
non possono cedere, che sono sostanzialmente – nelle
parole di Togliatti, poi riprese da altri e, nelle conclusioni,
da Longo – due: le nazionalizzazioni (in particolare
quella dell’industria elettrica), e la salvaguardia
(previo risanamento) dell’Iri. Si tratta di una
posizione che esprime compiutamente, ci sembra, una tradizione
ideologica che viene da lontano (le nazionalizzazioni
costituiscono la rivendicazione classica del movimento
operaio di ispirazione socialista) e, nello stesso tempo,
una impostazione più moderna, tesa a garantire
l’intervento dello Stato nell’economia.
Queste misure si collegano evidentemente alla prospettiva
della continuazione della presenza del Pci al governo,
che viene ritenuta ancora più necessaria in un
momento in cui la lotta di classe si sviluppa acutamente
nel paese. Lo stesso Togliatti, prevenendo possibili critiche
alla contradditorietà di questa posizione, sostiene
la necessità di non mutare la linea politica del
partito, ma di riuscire a coniugare la maggiore spregiudicatezza
nell’analisi con una maggiore spregiudicatezza nella
politica concreta. E una visione indubbiamente difficile
da realizzare, che individua per la prima volta l’economia
come un terreno su cui intervenire direttamente e postula
l’acquisizione degli strumenti necessari per sviluppare
una reale capacità di governo, per operare progressive
trasformazioni.
Questo sforzo – che assume criticamente, potremmo
dire in extremis, anche la lezione ricavata dall’esperienza
governativa – è espresso efficacemente da
Longo nell’intervento conclusivo: «Come possiamo
intervenire nella direzione economica? Soltanto con delle
misure politiche o anche con delle misure economiche?
Le misure politiche non bastano e noi dobbiamo mettere
in condizioni le forze democratiche dirigenti dello Stato
di intervenire anche economicamente, come l’industria
elettrica, l’Iri. [...] tutto il nostro piano ha
un senso, anche economicamente, se noi ci assicuriamo
quelle leve sufficienti per potere agire». Torna
in questo senso l’idea di un piano che colleghi
le questioni immediate a quelle generali e che consenta
la mobilitazione dei ceti popolari e medi anche degli
altri partiti, per evitare l’isolamento dei comunisti,
in un’impostazione che richiama tentativi già
esperiti senza successo, come il «nuovo corso».
Una visione che deve fare i conti, prima di tutto, con
i limiti stessi dell’organizzazione e della tradizione
del «partito nuovo» su cui ci siamo già
soffermati e che, in questa stessa occasione, sono di
nuovo messi in luce da Togliatti.
Poiché la preoccupazione fondamentale dei dirigenti
è quella di superare il «primitivismo»
e l’estremismo del partito, che si esprime in molti
episodi riferiti nelle riunioni della direzione, un notevole
impegno è rivolto all’attività di
formazione degli iscritti e a un’attenta politica
dei quadri, perché l’organizzazione riesca
ad assolvere i compiti politici fondamentali, soprattutto
in riferimento ai ceti medi e al rapporto con i socialisti
e i cattolici, i due partiti con i quali il Pci persegue
un’alleanza di lungo periodo.
Le difficoltà non vengono nascoste, e le critiche
che il vertice comunista rivolge alle organizzazioni locali
sono reiterate con precisione, a testimonianza di quanto
arduo fosse un lavoro di «acculturazione»
diretto a masse di lavoratori uscite dal periodo fascista
in uno stato di diffuso analfabetismo politico. Ma il
limite di fondo è significativamente individuato
nella stessa composizione sociale del Pci, che rende difficile
il perseguimento della politica di conquista e di alleanza
coi ceti medi. Secchia, nella relazione sui risultati
delle elezioni amministrative, afferma a questo proposito
(verbale del 9-10 aprile 1946): «Queste elezioni
hanno rivelato chiaramente che il nostro partito è
ancora essenzialmente il partito degli operai e dei braccianti
e non è ancora il partito nuovo che volevamo creare,
cioè un partito che possa avere un’influenza
che vada al di là degli operai e dei salariati.
Quasi dappertutto abbiamo scarsissima influenza tra gli
intellettuali, i commercianti e i bottegai».
E ancora su questo tema, in una lettera (15 aprile 1946)
che la direzione invia a tutti i segretari federali –
nella quale si prendono di mira le maggiori carenze rivelate
nella campagna elettorale dall’organizzazione del
partito – si dice: «Il problema dei ceti medi
e degli intellettuali non è ancora uscito, per
molte nostre organizzazioni, dallo stadio della impostazione:
si scrivono articoli su di esso, si tengono discorsi e
conferenze, ma non si vedono le iniziative concrete per
la difesa di questi gruppi sociali [...]. In parecchie
organizzazioni nostre è ancora tenace l’atteggiamento
ostile o di diffidenza verso i ceti medi urbani e soprattutto
verso gli intellettuali, atteggiamento che deve al più
presto scomparire»
Più avanti, si critica la spontaneità dimostrata
nel lavoro di partito, riaffermando il dovere di ogni
iscritto di impegnarsi individualmente, e soprattutto
si condanna il fenomeno dell’indisciplina, che ripropone
ancora la questione del «primitivismo». Lo
sforzo del gruppo dirigente non si limita, su questo piano,
a lottare contro le velleità insurrezionali, ma
si inserisce in un’opera complessiva di formazione
democratica che cerca di introdurre un costume interno
lontano da «caporalismi» e da autoritarismi,
mirando nello stesso tempo a un sostanziale controllo,
a una guida in termini positivi, delle più acute
tensioni sociali.
Lo sviluppo di un grande partito di massa non permette
del resto una direzione troppo autoritaria e burocratica:
e anche se in effetti i fenomeni di autoritarismo e di
burocratismo appaiono tutt’altro che rari, il vertice
del partito è ben consapevole che non si può
gestire un organismo complesso e articolato, inquadrato
da un numeroso apparato con gli stessi metodi con i quali
si gestiva negli anni Venti il Partito comunista d’Italia,
e si adopera quindi per formare ed educare rapidamente
migliaia e migliaia di quadri, con iniziative che vanno
dalle scuole di partito, all’utilizzazione della
stampa, alle conferenze che molte federazioni organizzano
settimanalmente, sull’esempio di quella di Roma.
Nello stesso tempo, occorre adeguarsi, nel lavoro di agitazione
e propaganda, al livello e alle caratteristiche della
base sociale del Pci: Togliatti è molto attento
a questi aspetti concreti dell’attività del
«partito nuovo», sino a indicare precisamente
i termini e le modalità più efficaci della
propaganda: «Il partito va avanti con opuscoli pesanti,
non accessibili alle grandi masse. – afferma nella
riunione del 14, 16, 18 febbraio 1946, dedicata alla propaganda
per le imminenti elezioni amministrative. – L’errore
che fate è di fidarvi su Spinella, su Onofri ...
Essi sono degli intellettuali, dai quali è alieno
lo spirito della propaganda elettorale; dovete farvi fare,
e discutere, un manifesto, da Di Vittorio, da Longo, da
Scoccimarro, da Amendola, ecc. Non si tratta di mettere
giù molte pagine e gli argomenti che trattano quelli
non servono; occorre della roba molto più viva,
di poche pagine, che possa essere letta in dieci minuti.
Questo, secondo me, è il punto più grave
di deficienza della nostra azione elettorale»
Così il superamento del «primitivismo»
– che si rivela nelle posizioni settarie, nella
sottovalutazione della conquista dei ceti medi, nell’esibizione
di atteggiamenti grossolanamente rivoluzionari, nel l’indulgenza
verso atti di intimidazione e di violenza, ecc. –
è affidato a una molteplicità di mezzi e
di iniziative, di cui fa parte anche una propaganda più
semplice, che servirà a popolarizzare meglio la
politica del partito, consentendo alle organizzazioni
periferiche un effettivo contatto con le masse popolari.
La preoccupazione del gruppo dirigente – in relazione
alle spinte «massimalistiche» ed estremistiche
diffuse nel partito – di non ripetere gli errori
commessi dal movimento operaio nel primo dopo guerra,
non dev’essere d’altronde intesa solo in termini
ristretti, ma si collega a una visione più ampia.
Quella esperienza riveste infatti un carattere generale,
paradigmatico, come mostrano i frequenti riferimenti contenuti
nei verbali, che arrivano talvolta a istituire analogie
o termini di confronto palesemente discutibili, ma proprio
per questo assai indicativi (Secchia, analizzando i risultati
delle elezioni amministrative, illustra addirittura, per
ogni località, il raffronto con quelle del 1920).
Allo stesso modo, la necessità di conquistare i
ceti medi deriva esplicitamente dall’analisi del
«biennio rosso» elaborata in modo particolare
nelle Lezioni sul fascismo di Togliatti (1935)56; persino
gli elementi della tattica elettorale, di cui la direzione
comunista discute in varie occasioni, sono ricollegati,
in molti interventi, all’esperienza dei «blocchi»
realizzati nel 1914 e nel 1920, così come la valutazione
delle caratteristiche e delle ambiguità della Dc
sottintende un richiamo all’esperienza del partito
popolare: si pensa che i cattolici non vorranno ripetere
quella politica di divisione delle forze popolari e di
collusione coi fascismo che aveva contribuito alla crisi
dello Stato liberale.
Così, le categorie storico-politiche fondamentali
usate dalla direzione nel periodo costituente hanno un
retroterra comune, costituito dallo svolgimento e dall’esito
della crisi del primo dopoguerra, che si era risolta nella
sconfitta del movimento operaio e nella messa al bando
per vent’anni dei comunisti e di tutti gli altri
partiti – dal la vita politica nazionale. Quella
vicenda aveva mostrato con evidenza la vocazione antidemocratica
della classe dominante, la tradizione conservatrice dello
Stato, la «presa» di correnti reazionarie
anche su strati popolari: il successo ottenuto con la
Resistenza e la liquidazione del fascismo non poteva certo
far dimenticare il prezzo pagato per gli errori precedenti,
né il pericolo, sempre presente, che si riproducesse
una situazione di crisi della rinata democrazia.
Di qui scaturisce l’ideologia forse più vera
e sentita del gruppo dirigente comunista nel periodo costituente,
che possiamo riassumere nel termine di antifascismo: una
sorta di sistematizzazione e teorizzazione delle esperienze
del passato, o meglio, delle lezioni che ne erano state
ricavate. Una visione che condiziona anche l’analisi
dell’economia e della società italiana, conferendo
una particolare attenzione ai fattori sociali tradizionali
piuttosto che ai più moderni fenomeni – del
resto, in quegli anni, ancora embrionali – di sviluppo
del capitalismo italiano. L’antifascismo appare
in effetti, sulla base dei successi raggiunti nel periodo
1943-47, una concezione politico- ideologica complessiva
che caratterizza la nascita del «partito nuovo»,
contribuendo in modo decisivo a fondarne stabilmente l’identità
più profonda.
All’interno della direzione comunista, sulla base
di questo comune sentire, si manifesta una sostanziale
unità, che è certo tra i fattori di maggior
forza e prestigio del partito. Ciò non toglie –
come abbiamo notato in qualche occasione – che si
possano distinguere, attraverso un attento esame delle
varie posizioni, opinioni e atteggia menti differenziati,
che uniscono, talvolta assai significativamente, varie
personalità.
Se si volesse fare una distinzione sommaria (che è
forse l’unica permessa, senza forzature, dalla documentazione)
potremmo osservare che su molti temi decisivi –
dall’organizzazione di partito ai rapporti coi socialisti,
dal tema delle agitazioni operaie a quello del governo
– si delineano spesso divergenze significative tra
personalità più intransigenti, come Colombi,
Roasio, Teresa Noce, Pesenti, che appaiono più
inclini a dar prova di combattività e di durezza,
e dirigenti di maggiore elasticità e prudenza,
come Amendola, Negarville, Novella. Tuttavia, queste differenze
non raggiungono mai il livello di una vera lotta politica,
anche per l’abilità e il riconosciuto prestigio
di Togliatti. In effetti l’unità non è
conseguita in modo meccani CO O esteriore, ma appare come
il risultato di una dialettica intensa, che mette in luce
un importante dato di fondo: la presenza di molte spiccate
individualità, di un ricchezza intellettuale e
politica assai rara.
Il segretario generale del Pci svolge un’azione
pedagogica, possiamo dire, anche all’interno della
direzione, riaffermando in ogni mo mento la validità
della linea di fondo del partito, e riuscendo a manovrare
con abilità di fronte alle disillusioni governative
ed elettorali del 1946-47 La sua funzione appare effettivamente
centrale anche nell’influenzare e guidare i dirigenti
più autorevoli e più vicini a lui, cioè
Longo e Secchia. Così, se volessimo definire più
precisa mente il gruppo dirigente, senza identificarlo
– come abbiamo fatto sinora – con tutta la
direzione del Pci, dovremmo individuarlo in queste tre
maggiori personalità, di cui i verbali mostrano
appieno le capacità di elaborazione e di direzione.
Sono questi tre uomini il nucleo dirigente del Pci nel
periodo costituente, gli artefici principali del primo
compromesso storico.
La storia del Pci è prima di tutto costituita dalle
sue concrete esperienze politiche, e dalla loro successiva
elaborazione e incorporazione in una linea strategica:
attraverso questi verbali, possiamo allora non solo apprezzare
il peso delle lezioni del passato sulle scelte del presente,
ma anche osservare la genesi di un nuovo paradigma, che
si afferma nel periodo costituente sulla base del conseguimento
di quella funzione nazionale che il «partito nuovo»
seppe assolvere nel momento stesso in cui si formava.
Questa esperienza, che segna la genesi stessa del partito
comunista di massa, facendone un soggetto determinante
della vita politica italiana, non cesserà di agire
nei decenni seguenti come un punto di riferimento essenziale,
trovando il suo sviluppo più compiuto nella proposta
del compromesso storico, e nella politica di unità
nazionale degli anni 1976-1979: un tentativo di riprendere
il cammino unita rio interrotto nel 1947, che si concluderà
con una sconfitta politica dalle conseguenze imprevedibili.
Dal fallimento di questa esperienza infatti, prenderà
le mosse la vicenda più recente e travagliata del
Pci, sboccata nella formazione di un nuovo partito.
Ma il discorso, su questo tema, ci porterebbe troppo lontano
dal corretto ambito del nostro lavoro, limitato in questa
sede alle suggestioni e agli spunti più immediati
offerti dalla documentazione raccolta. La nostra introduzione
finisce qui, consegnando al lettore e allo studioso uno
strumento la cui utilità per la comprensione del
passato (e del presente) non ha bisogno di essere ancora
sottolineata.
Al termine della nostra fatica, ci è grato ringraziare
prima di tutto Giuseppe Vacca, che ha voluto ospitare
la presente pubblicazione negli «Annali» della
Fondazione Istituto Gramsci, della quale è direttore.
La nostra sincera gratitudine va inoltre a Fabrizio Zitelli
e Marcello Forti, curatori dell’Archivio del Pci,
per la disponibilità e la competenza dimostrate
nel corso delle ricerche necessarie, e a Gastone Gensini,
responsabile dell’archivio della direzione del Pds,
per le molte indicazioni e informazioni con le quali ha
seguito valida mente il lavoro. Non possiamo dimenticare,
infine, il personale della Fondazione Istituto Gramsci,
che ha collaborato a rendere più agevole il nostro
compito in molti modi, meritando anch’esso la nostra
riconoscenza. |
|
|
 |
| |
| ©
copyright 1996, 2015
| FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI onlus |
cf 97024640589
|
| sede
legale, uffici amministrativi
|
ROMA VIA PORTUENSE 95c
|
tel. 0039 0683901670 fax 0039 0658157631 |
| segreteria,
archivi, biblioteca
|
ROMA VIA SEBINO 43a| tel. 0039 065806646 fax 0039 0658157631 |
|
|