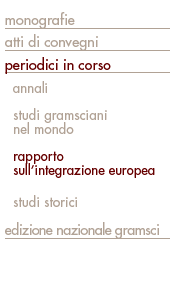|
Prefazione
di Roberto Gualtieri e José Luis
Rhi-Sausi
La Questo
rapporto vede la luce in uno dei momenti più
deli-
cati dell’intera storia della costruzione europea,
in cui le prin-
cipali politiche dell’Unione e le maggiori conquiste
da essa
rea lizzate nel corso dell’ultimo quindicennio
sono sottoposte a
fortissime tensioni. Se, infatti, a partire dal 2010
l’impatto della
crisi economico-finanziaria sull’Unione monetaria
ha messo in
evidenza i limiti e le asimmetrie del modello di governance
eco-
nomica definito nei trattati, nel corso del 2011 le
conseguenze
della «primavera araba» si sono riverberate
con forza sulle di-
mensioni dell’azione dell’Ue che più
di altre erano state interes-
sate dai cambiamenti del nuovo quadro istituzionale:
la Politica
estera e di sicurezza comune (la Pesc) con la sua «ancella»
Po-
litica di sicurezza e difesa comune (Psdc) e lo Spazio
di libertà,
sicurezza e giustizia (Slsg).
Il tutto in un contesto politico che vede le attuali
classi di-
rigenti europee fortemente condizionate da un «primato
della
politica nazionale» e che, sul piano istituzionale,
si traduce
nella tendenza a privilegiare il metodo intergovernativo
rispetto
a quello comunitario e, sul piano politico e programmatico,
è
caratterizzato da un impianto conservatore, se non da
un vero
e proprio slittamento a destra. Quest’ultimo,
però, da un lato
non sembra rappresentare un argine all’ascesa
di forze populi-
ste, dall’altro ostacola l’assunzione di
scelte adeguate alle nuove
sfide economiche, sociali e politiche che il contesto
internazio-
nale presenta all’Europa.
Per quanto riguarda la crisi economico-finanziaria,
non c’è
dubbio che le innovazioni introdotte a partire dalle
tumultuose
giornate del maggio 2010 siano molto significative.
L’istituzione
di due meccanismi di sostegno finanziario, rispettivamente
di
tipo intergovernativo (Efsf) e comunitario (Efsm), sulla
base
dell’articolo 122.2 del Tfue, e la parallela decisione
della Bce di
acquistare i titoli dei paesi in difficoltà hanno
segnato una svolta
sul terreno della solidarietà interna all’area
dell’euro, impensa-
bile fino a pochi mesi prima. Successivamente, le proposte
legi-
slative della Commissione e i risultati della task force
istituita dal
presidente del Consiglio europeo Van Rompuy hanno avviato
una riforma del patto di stabilità e di crescita
e dei meccanismi
di governance economica di indubbio rilievo. Qualunque
sarà
l’esito del negoziato tra Parlamento e Consiglio
(che nel mo-
mento in cui scriviamo è in corso), la riforma
determinerà un si-
gnificativo rafforzamento del coordinamento delle politiche
eco-
nomiche nazionali, e in particolare della disciplina
fiscale, sia sul
versante preventivo che su quello correttivo, oltre
a migliorare
la sorveglianza degli squilibri macroeconomici.
Parallelamente, l’istituzione delle tre nuove
autorità europee
su banche, assicurazioni e mercati e dell’European
sistemic risk
board, pur con tutti i suoi limiti, definisce (grazie
anche al ruolo
svolto dal Parlamento europeo nel procedimento legislativo)
il
primo embrione di un vero e proprio sistema di vigilanza
eu-
ropeo sui mercati finanziari. Infine, la riforma dell’articolo
136
del Trattato di Lisbona realizzata con procedura semplificata
nel
marzo 2011 (e che per divenire operativa attende le
27 ratifi-
che nazionali), con la quale si consente l’istituzione
di un fondo
salva-Stati permanente (Esm) che dal 2013 prenderà
il posto
dell’Efsf e dell’Efsm, dà indubbia
sostanza all’impegno poli-
tico a difendere la moneta unica e i suoi membri dagli
attacchi
speculativi. È vero, come non ha mancato di rilevare
il Parla-
mento europeo1, che si sarebbe potuto istituire un meccanismo
permanente senza ricorrere ad un impegnativo (e rischioso)
pro-
cedimento di riforma del Trattato e, soprattutto, che
sarebbe
stato auspicabile un meccanismo di tipo comunitario
analogo
all’Esfm, invece di un fondo intergovernativo
come quello deli-
neato dal nuovo comma 3 dell’articolo 136 del
Tfue.
Ma, in ogni caso, un meccanismo di stabilità
permanente
con una dotazione di base di 700 miliardi di euro, la
possibilità
di emettere obbligazioni e quella di acquistare i titoli
dei paesi
euro sul mercato secondario rappresentano un’innovazione
di
grande rilievo, che per di più, grazie al compromesso
strappato
dal Parlamento europeo (in base al quale si dovrebbero
definire
i meccanismi che governeranno la condizionalità
degli aiuti at-
traverso un regolamento), sarà saldamente collegata
alle istitu-
zioni europee e al metodo comunitario.
E tuttavia, come mette bene in evidenza Ronny Mazzocchi
nella sua rubrica, queste significative novità
non appaiono suffi-
cienti ad affrontare i problemi di fondo dell’economia
europea
e a fronteggiare la minacciosa crisi dei debiti sovrani
di alcuni
pae si. Una governance tutta fondata sul rigore di bilancio,
infatti,
non sembra in grado né di rilanciare la crescita
e lo sviluppo, né
di rassicurare i mercati sulla solvibilità delle
economie più fragili
ed esposte agli attacchi speculativi. Al contrario,
il rischio con-
creto è quello di innescare un circolo vizioso
tra dinamiche re-
cessive e sfiducia dei mercati (che appaiono preoccupati
più dalla
possibilità di uscita dalla moneta unica che
dal deficit in quanto
tale), di fronte al quale le pure cospicue risorse dei
meccanismi di
stabilità attuali e di quello futuro potrebbero
risultare inadeguate.
Sono insomma i presupposti concettuali e politici della
strategia
prevalsa nel Consiglio europeo che non convincono: da
un lato,
infatti, l’aumento dei deficit pubblici non dovrebbe
essere con-
siderato una causa, ma un effetto della crisi e della
conseguente
decisione di molti governi di sostenere con cospicue
iniezioni
di denaro pubblico il traballante sistema bancario.
Dall’altro, la
tesi secondo cui politiche fiscali restrittive avrebbero
un effetto
espansivo, oltre a essere assai discutibile sul piano
dottrinale e su
quello «storiografico», risulta smentita
dai fatti.
Per questo, occorre definire e mettere in campo una
visione
differente della governance economica europea, capace
di affian-
care alla stabilità e alla riduzione dei deficit
il sostegno alla cre-
scita e allo sviluppo e, allo stesso tempo, in grado
di rafforzare
la dimensione comunitaria rispetto a quella intergovernativa.
Le
idee non mancano: creazione di un’Agenzia europea
del debito
ed emissione di eurobond per finanziare investimenti
in infra-
strutture, riforma del mercato finanziario volta a facilitare
la ca-
nalizzazione del risparmio privato verso investimenti
a lungo ter-
mine rispetto agli impieghi speculativi e di breve periodo,
tassa
sulle transazioni finanziarie, riforma del sistema delle
risorse
proprie che consenta un rafforzamento del bilancio dell’Ue,
correzione degli squilibri macroeconomici anche attraverso
un
incremento dei salari reali dei paesi in surplus. Ciò
che occorre
è uno spostamento degli equilibri politici nell’Ue,
sia in Parla-
mento sia nel Consiglio, e la formazione di una diversa
maggio-
ranza al tempo stesso più progressista e più
europeista.
Anche sul terreno dell’azione esterna dell’Ue
i limiti emersi
sono di natura sia istituzionale sia politica. Non c’è
dubbio, in-
fatti, che le innovazioni introdotte dal Trattato di
Lisbona in
questo ambito siano state significative. In particolare,
l’attribu-
zione all’Alto rappresentante delle funzioni di
presidente stabile
del Consiglio affari esteri e di vicepresidente della
Commis-
sione, responsabile sia del tradizionale portafoglio
delle relazioni
esterne sia del coordinamento della più generale
azione esterna
della Commissione, è un’innovazione ricca
di potenzialità. Sta-
bilendo un ponte tra la Politica estera e di sicurezza
comune,
definita da procedure di tipo intergovernativo, e la
dimensione
comunitaria dell’azione esterna dell’Unione,
l’Alto rappresen-
tante può rendere più coerente ed efficace
l’azione dell’Ue re-
alizzando sinergie tra strumenti e politiche differenti
e valoriz-
zando la peculiarità dell’approccio europeo,
fondato sul multila-
teralismo, sul primato della diplomazia, sulla cooperazione
e sul
sostegno alla democrazia. Con l’istituzione del
Servizio europeo
per l’azione esterna (Seae), l’Alto rappresentante/vicepresidente
si è finalmente potuto dotare di uno strumento
operativo che,
anche grazie al ruolo svolto dal Parlamento europeo
nel difficile
negoziato con il Consiglio, dispone di ampie competenze
ed è
saldamente collegato alla Commissione (oltre che sottoposto
a
un forte controllo parlamentare).
E tuttavia, è indubbio che le potenzialità
derivanti da questo
nuovo assetto non si siano tradotte in una politica
estera europea
finalmente efficace e coerente. Come mette in evidenza
Raffaello
Matarazzo nella sua rubrica, non sono mancati successi
impor-
tanti, come la mediazione realizzata nello scorso settembre
con
la Serbia in occasione della votazione della risoluzione
sul Ko-
sovo all’Onu o l’attribuzione all’Ue
di un nuovo status nell’as-
semblea generale delle Nazioni unite. Ma l’esplosione
delle ri-
volte democratiche nei paesi arabi, e in particolare
la crisi libica,
ha messo in evidenza, oltre all’inadeguatezza
del tradizionale
approccio dell’Ue nei confronti del Mediterraneo,
la persistente
fragilità della sua azione esterna e le difficoltà
a svolgere un
ruolo incisivo in un teatro così cruciale per
i destini del nostro
continente. Facendo poi emergere una preoccupante divisione
strategica e politica sul terreno della gestione delle
crisi, che ri-
schia di vanificare i notevoli sforzi compiuti in questi
anni e di
mettere in discussione le prospettive della Politica
di sicurezza
e difesa comune. Al momento in cui scriviamo, la crisi
libica è
ancora in corso e una sua soluzione non appare all’orizzonte
(mentre è troppo presto per valutare l’annunciata
revisione della
dimensione meridionale della politica di vicinato).
I limiti e le
potenzialità della Politica di sicurezza e difesa
comune, che tale
crisi ha in qualche modo confermato, sono tuttavia analizzati
in
modo approfondito nella monografia del volume, per una
sintesi
e una presentazione della quale rimandiamo all’introduzione
di
Roberto Gualtieri e Raffaello Matarazzo.
Quel che è certo è che, analogamente a
quanto avviene sul ter-
reno della governance economica, anche per la Politica
estera, di
sicurezza e difesa, i problemi dell’Europa sono
insieme di natura
istituzionale e politica. Sul piano istituzionale, pesa
senza dubbio
il fatto che, a dispetto delle molteplici innovazioni
introdotte nel
Trattato di Lisbona e del superamento della struttura
a «pilastri»
dell’Ue, la natura intergovernativa delle procedure
decisionali in
materia di Pesc e di Psdc non sia stata sostanzialmente
intaccata.
Questo elemento ha sicuramente privato la Pesc/Psdc
di quello
«scudo comunitario», che invece è
stato introdotto dal Trattato
nei confronti dell’ex «terzo pilastro»,
ossia dello Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, rendendo quindi particolarmente
forte l’im-
patto delle divergenze politiche tra i principali paesi
dell’Ue.
A loro volta, tali divergenze appaiono il frutto di
una visione
conservatrice e fortemente condizionata da un malinteso
pri-
mato dell’interesse nazionale, che non sembra
in grado di fare i
conti adeguatamente con il fatto che gli spazi per un
autonomo
protagonismo internazionale dei singoli paesi europei
si sono or-
mai ridotti drasticamente e l’unica possibilità
di avere un ruolo
significativo nella definizione di un nuovo assetto
del sistema
internazionale è quella di rendere finalmente
l’Unione europea
un attore credibile sul terreno della Politica estera
e di quella di
sicurezza e difesa.
La rubrica di Fabrizia Panzetti analizza in modo puntuale
le profonde innovazioni che il Trattato di Lisbona ha
introdotto
nell’ambito dello Spazio di libertà, sicurezza
e giustizia. A diffe-
renza che nel caso della Politica estera e di sicurezza
comune, la
comunitarizzazione di questo ambito delle politiche
europee ha
innescato delle dinamiche impreviste, che hanno visto
il Parla-
mento europeo giocare un ruolo centrale. Nel rinnovo
dell’ac-
cordo Swift sull’uso dei dati finanziari dei cittadini
europei da
parte degli Stati Uniti nel quadro della lotta al terrorismo
e nella
vicenda dell’espulsione dei rom in Francia, il
Parlamento ha
esercitato pienamente le sue prerogative legislative
e politiche,
contribuendo in misura sostanziale alla difesa dell’acquis
comu-
nitario e dei diritti dei cittadini europei di fronte
alla debolezza
di altre istituzioni e al tentativo francese di giocare
spregiudi-
catamente la carta «securitaria» a fini
di politica interna. Le vi-
cende dei mesi successivi, con lo scontro italo-francese
su Schen-
gen e la successiva lettera comune Berlusconi-Sarkozy,
ma anche
con la sentenza della Corte europea di giustizia contro
il reato
di clandestinità introdotto nella legislazione
italiana, hanno con-
fermato questa duplice tendenza. Da una parte, la forte
spinta
di alcuni governi conservatori europei a rinazionalizzare
le poli-
tiche relative allo Spazio di libertà, sicurezza
e giustizia e a irri-
gidire l’azione di contrasto all’immigrazione
irregolare e alla li-
bera circolazione di alcune minoranze nel territorio
dell’Unione;
dall’altra, l’efficacia di uno «scudo
comunitario» che, in questo
ambito, vede un forte ruolo della Corte europea di giustizia
e
assegna al Parlamento europeo una funzione cruciale
nella di-
fesa dei trattati e dei diritti dei cittadini dell’Unione.
Nei pros-
simi mesi vedremo se questa inedita funzione di vero
«custode
dei trattati» e di propulsore della loro effettiva
implementazione
verrà esercitata pienamente ed adeguatamente
nei confronti
dell’annunciata revisione di Schengen e nella
sfida complessa,
ma decisiva, di dare piena attuazione al principio di
solidarietà
sancito dall’articolo 80 Tfue nell’ambito
delle politiche relative
al controllo delle frontiere, all’asilo e all’immigrazione.
Le significative dinamiche che hanno caratterizzato
le poli-
tiche economiche e monetarie, l’azione esterna
dell’Ue e lo Spa-
zio di libertà, sicurezza e giustizia offrono
ampio materiale di
riflessione sulle trasformazioni della peculiare forma
di governo
dell’Ue e degli equilibri tra le diverse istituzioni
innescate dal
Trattato di Lisbona e dalle turbolente vicende degli
ultimi mesi.
La rubrica di Sandro Guerrieri analizza puntualmente
queste
trasformazioni, sottolineando l’emergere di una
nuova dialettica
tra un Consiglio europeo, che sempre più assume
un ruolo po-
litico centrale intorno al suo presidente stabile e
all’azione dei
suoi membri più influenti, ed un Parlamento europeo
rafforzato
non solo nelle prerogative, ma anche nella volontà
di agire ef-
fettivamente come rappresentante diretto dei cittadini
europei
(secondo la nuova formulazione introdotta dal Trattato
di Li-
sbona). Di fronte alla sempre più evidente debolezza
della Com-
missione, questa nuova dialettica determina una sorta
di trasfor-
mazione della tradizionale dinamica tra Commissione
e Stati
membri, rinnovando significativamente sia la polarità
comunita-
ria sia quella intergovernativa e politicizzandole entrambe.
Nel
Consiglio europeo, infatti, la spinta intergovernativa
si esprime
su un terreno nuovo e le innovazioni introdotte nella
governance
economica rendono legittimo il riferimento a un nuovo
«me-
todo dell’Unione», distinto sia da quello
intergovernativo sia da
quello comunitario. A sua volta, la difesa del metodo
comunita-
rio esercitata dal Parlamento connota quest’ultimo
politicamente
in forme inedite e assai differenti da quelle che hanno
caratteriz-
zato il tradizionale approccio funzionalista, assegnando
un ruolo
centrale ai gruppi politici europei e spingendo il Parlamento
stesso ad un dialogo a tutto campo con il Consiglio
europeo,
che travalica apertamente i confini delle prerogative
legislative e
di bilancio definite dai trattati e connota in forma
nuova la sua
funzione generale di indirizzo e di controllo politico.
Questo processo di crescente politicizzazione delle
dinami-
che interistituzionali è ancora agli inizi ed
è aperto a esiti diffe-
renti. Esso rappresenta tuttavia un fatto nuovo, che
impone di
guardare agli appuntamenti elettorali dei prossimi tre
anni come
ad un unico grande ciclo europeo, in cui le elezioni
nazionali in
programma (a cominciare da quelle in Francia, Italia
e Germa-
nia) e poi il rinnovo del Parlamento europeo (nel 2014)
sotto-
porranno alla verifica dei cittadini l’attuale
indirizzo conserva-
tore che caratterizza le politiche dell’Ue e i
suoi risultati e con-
sentiranno di confermarne il corso o di imprimere una
svolta,
che le vicende economiche e politiche degli ultimi anni
fanno
apparire necessaria e urgente.
|