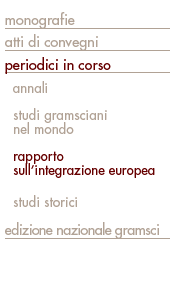|
Prefazione
di Roberto Gualtieri e José Luis
Rhi-Sausi
La dialettica
tra sfide e opportunità, tra repentine trasformazioni
del quadro economico e politico interno e internazionale
e rilancio del processo di integrazione ha accompagnato
fin dalle origini la storia della costruzione europea
e le sue
tappe fondamentali (basti pensare allo stretto nesso
che ha legato
tra loro il Piano Schuman, il Piano Marshall e lo scoppio
della guerra fredda; la costruzione del Mercato comune,
Suez
e la decolonizzazione, la stabilizzazione del bipolarismo;
Maastricht
e l’89). Con la chiusura del primo decennio del
nuovo
secolo tale dialettica appare particolarmente stringente.
Da un
lato, infatti, assistiamo all’esplosione della
più grande crisi economica
e finanziaria del dopoguerra, che, al di là delle
dinamiche
interne al sistema finanziario che l’hanno innescata,
è il
precipitato dell’erosione, che durava da tempo,
di equilibri decennali
tra aree del pianeta, sistemi produttivi e gruppi sociali.
Una crisi che, se per un verso rilancia il valore dell’economia
sociale di mercato – che della costruzione europea
costituisce il
cuore e l’anima –, al tempo stesso colpisce
duramente il nostro
continente e le sue istituzioni comuni e fa emergere
in modo
evidente l’inadeguatezza della strategia di sviluppo
e degli strumenti
che l’Unione europea si era data a Lisbona dieci
anni fa
per affrontare le sfide della globalizzazione. Dall’altro
lato, proprio
quando la crisi rivela l’inadeguatezza dei tradizionali
meccanismi
di coordinamento delle politiche economiche e minaccia
la moneta comune, giunge finalmente a compimento, dopo
un travagliato percorso (ricostruito da Sandro Guerrieri
nel
suo contributo) quel processo di riforma istituzionale
di spessore
costituzionale che aveva avuto avvio anch’esso
all’inizio del
decennio – alla vigilia dell’entrata in
circolazione della moneta
unica e all’indomani dell’11 settembre –
con la dichiarazione di
Laeken del 2001. Un processo che non mirava solo ad
adeguare
i meccanismi di governance all’imminente allargamento
a est, ma
si fondava sull’esplicita consapevolezza dell’inadeguatezza
non
solo tecnica degli «aggiustamenti» all’impianto
di Maastricht
rea lizzati ad Amsterdam e Nizza, di fronte alla ormai
ineludibile
necessità di dotare l’Europa di un’effettiva
sostanza democratica
e di metterla in condizione di «assumere le proprie
responsabilità
nella gestione della globalizzazione».
Quanto l’introduzione del nuovo assetto istituzionale
definito
dal trattato di Lisbona fosse urgente è esemplificato
in
modo esemplare proprio dal modo inadeguato con cui l’Unione
europea ha risposto alla crisi esplosa nel 2008. Come
è ben ricostruito
nel saggio di Ronny Mazzocchi, l’European Economic
Recovery Plan lanciato dalla Commissione alla fine di
quell’anno
è stato in realtà poco più che
un’etichetta giustapposta a una serie
di misure anticicliche nazionali che si sono rivelate
non solo
insufficienti, ma che hanno per di più aggravato
gli squilibri e
le asimmetrie tra le politiche fiscali europee con conseguenze
potenzialmente destabilizzanti che non hanno tardato
a manifestarsi.
Con il precipitare della crisi greca, il nuovo Consiglio
europeo e il suo presidente hanno così dovuto
fare i conti con il
tema ineludibile del «governo economico europeo»,
ossia con la
duplice necessità di dotare l’Europa (e
innanzitutto l’eurozona)
delle risorse e degli strumenti per svolgere la funzione
di «prestatore
di ultima istanza» anche al proprio interno e
di affiancare
alla politica monetaria comune una vera politica fiscale
e di
bilancio europea, capace, da un lato, di coordinare
in modo più
cogente le politiche fiscali nazionali, e, dall’altro,
di mobilitare
risorse significative a livello europeo per grandi investimenti
in
reti, infrastrutture e innovazione.
In un primo tempo, è stata scelta la strada di
un impegno
politico a evitare il fallimento di un paese dell’area
dell’euro,
che è tuttavia risultato poco efficace e al quale
ha fatto seguito
la scelta di un primo pacchetto di interventi bilaterali
affiancati
a un intervento dell’Fmi. Solo quando i mercati
hanno mostrato
di non ritenere adeguato lo strumento prescelto, il
Consiglio europeo
ha deciso di aprire la strada a un intervento più
sostanzioso
e più europeo, concretizzatosi nelle misure varate
nella
notte tra il 9 e il 10 maggio dall’Ecofin e precisate
nei giorni
successivi: l’adozione di un «Meccanismo
europeo di stabilizzazione per preservare la stabilità
finanziaria» con una dotazione
di 750 miliardi di euro (250 milioni provenienti dall’Fmi
e 500
dall’Europa, dei quali 440 forniti dagli Stati
membri), la decisione
della Bce di acquistare titoli di debito nazionali sul
mercato
secondario per sostenerne il corso e il rafforzamento
del
coordinamento delle politiche di bilancio. Si tratta
di misure
molto significative, non solo per l’entità
delle risorse messe in
campo e per il nuovo ruolo della Banca centrale europea,
ma
soprattutto la natura della prima tranche di 60 miliardi
del pacchetto
varato dall’Ecofin. La base giuridica di tale
tranche è, infatti,
esplicitamente individuata nell’articolo 122.2
del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede
la concessione
di «un’assistenza finanziaria dell’Unione»
a uno Stato
membro che «si trovi in difficoltà o sia
seriamente minacciato
da gravi difficoltà a causa di calamità
naturali o di circostanze
eccezionali che sfuggono al suo controllo». Si
tratta di una
svolta significativa, perché la previsione di
un volume di risorse
pari a 60 miliardi di euro implica per la prima volta
la possibilità
di fare ricorso, se necessario, all’emissione
di titoli di debito
europei sotto la garanzia degli Stati membri.
L’apertura di un varco nel muro, contro cui la
proposta di
emettere eurobond si era finora sempre infranta, costituisce
indubbiamente
un precedente di grande importanza, che renderà
difficile giustificare in seguito perché l’emissione
di titoli
europei debba essere negata per gli investimenti, quando
essa è
stata prevista per sostenere le bilance dei pagamenti
dei paesi
in difficoltà. E, tuttavia, non è affatto
detto che l’Europa sarà
in grado di procedere con la sufficiente speditezza
e determinazione
lungo questa strada, nonostante essa sia l’unica
che consentirebbe
di compensare l’esigenza di maggiore rigore a
livello
dei bilanci nazionali con il necessario stimolo allo
sviluppo e alla
crescita.
Basta esaminare la nuova Strategia Eu2020 presentata
dalla
Commissione, che, se corregge (solo in parte) alcuni
limiti della
precedente Strategia di Lisbona (in particolare la sua
eccessiva
impronta neo-liberale, l’assenza della nozione
di politica industriale
e un’enfasi sull’economia della conoscenza
disgiunta da
un’adeguata sottolineatura della necessità
per l’Europa di rilanciare
la sua vocazione manifatturiera), risulta inadeguata
sia
sotto il profilo degli obiettivi che sotto quello degli
strumenti.
Oppure è sufficiente esaminare il dibattito sul
bilancio europeo
e il modo in cui Commissione e Consiglio continuano
a eludere
il nodo delle risorse proprie. I segnali positivi sul
versante della
mobilitazione del risparmio privato europeo per investimenti
in beni comuni (innanzitutto reti e infrastrutture),
come quelli
rappresentati dalla nascita del «Fondo Marguerite»
(che unisce
l’italiana Cassa depositi e prestiti e i suoi
omologhi europei),
non appaiono dunque per il momento collocati nel quadro
di
una coerente strategia capace di misurarsi in modo realistico
ma
ambizioso con i diversi elementi di un vero «governo
economico
europeo» (tra i quali ovviamente vi è anche
il contributo alla riforma
dei mercati finanziari). Solo i prossimi mesi diranno
se le
potenzialità del nuovo assetto istituzionale
verranno utilizzate
per consentire all’Europa di affrontare in modo
adeguato la crisi
e la necessità di rilanciare il proprio sviluppo.
Anche le altre dimensioni della costruzione europea
evidenziano
una contraddizione tra le esigenze di innovazione rilanciate
dal contesto interno e internazionale, le potenzialità
del
nuovo quadro istituzionale e il riflesso conservatore
che caratterizza
l’azione del Consiglio e della Commissione. Basti
pensare,
come sottolinea Fabrizia Panzetti nel suo contributo,
al
modo in cui il nuovo programma di Stoccolma varato dal
Consiglio
europeo sulle priorità, gli obiettivi e gli strumenti
dello
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sostanzialmente
eluda
novità fondamentali come il nuovo ruolo assegnato
in questo
settore al Parlamento europeo dal trattato di Lisbona
e il carattere
vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
Il voto con cui il Parlamento europeo, nonostante le
fortissime
pressioni esercitate sui suoi membri, ha respinto l’accordo
Swift che consentiva la cessione agli Stati Uniti dei
dati sensibili
bancari ai fini di lotta al terrorismo in forme che
violavano
manifestamente le leggi europee e i diritti dei cittadini,
ha dimostrato
però che gli effetti del trattato di Lisbona
sono assai
più profondi di quanto da molti ritenuto. E che
quindi l’enfasi
sulla dimensione della sicurezza e sull’intergovernatività
che caratterizza
il programma di Stoccolma dovrà fare i conti
con una
dialettica interistituzionale inedita che potrebbe contribui
re a
ridefinirne il profilo, rendendolo più adeguato
all’esigenza di
dare maggior corpo e sostanza alla dimensione della
cittadinanza
europea.
La proiezione esterna dell’Europa costituisce
il terzo grande
ambito in cui la dialettica tra sfide e opportunità
è particolarmente
pronunciata. Il nuovo assetto istituzionale definito
dal
trattato di Lisbona coincide, infatti, con una stagione
di profondi
cambiamenti sulla scena internazionale. La transizione
verso un assetto multipolare procede con tensioni e
scosse che
mettono in luce come, se da un lato i vecchi equilibri
economici
e politici non tengono più, dall’altro
la strada per la costruzione
di un nuovo ordine internazionale sia ancora lunga e
difficile.
La crisi economica e finanziaria; l’ascesa della
Cina e il suo crescente
peso non solo in Asia ma in quella che i cinesi definiscono
una «grande periferia» che dal Medio Oriente
si spinge
fino all’Africa; il consolidamento della dimensione
statuale della
Russia e la ritrovata assertività della sua politica
estera, con la
conseguente maggiore capacità di condizionare
gli equilibri politici
alle sue frontiere; le crescenti tensioni a cui è
sottoposto
il regime di non proliferazione (a partire dal loro
vero epicentro:
il confronto tra India e Pakistan); la riscoperta della
dimensione
asiatica nella politica estera giapponese e turca; la
rottura
dei vecchi equilibri mediorientali e la nuova centralità
regionale
dell’Iran (innescati dal tentativo della precedente
amministrazione
statunitense di giocare la «carta sciita»
per rivoluzionare
il vecchio status quo); la crisi politica che ha colpito
in Israele le
forze consapevoli della necessità strategica
della pace e, sull’altro
fronte, la scomposizione del movimento nazionale palestinese,
con il conseguente stallo del processo di pace; la persistente
minaccia
del terrorismo jihadista; per non parlare dei mutamenti
in atto in America Latina e in Africa. È un quadro
complesso,
che non segna solo una nuova dislocazione geografica
delle
forze, ma anche un forte intreccio tra politica ed economia,
tra
vecchie e nuove dimensioni della sicurezza, tra il ruolo
di attori
statali e non statali.
In questo scenario, la nuova amministrazione americana
è
impegnata in un ambizioso e difficile tentativo di rispondere
all’evidente «crisi di egemonia» che
ha colpito gli Stati Uniti e
di correggere, con inevitabile gradualità, gli
squilibri e le asimmetrie
accumulatesi dopo la fine del bipolarismo e accentuatesi
per effetto della risposta dell’amministrazione
Bush all’11
settembre e più in generale del suo tentativo
di consolidare
l’apparente unipolarismo post-1989 in modo unilaterale
e non
cooperativo. Il tentativo (simmetrico a quello in atto
sul piano
economico di diminuire gradualmente lo squilibrio strutturale
della bilancia dei pagamenti americana, l’eccesso
di debito privato
e i rischi di deindustrializzazione senza mettere in
pericolo
il ruolo del dollaro e il mercato dei titoli del tesoro)
è di ricostruire
un’architettura multilaterale che consenta di
ridurre la
sovraesposizione politico-militare statunitense e i
suoi crescenti
costi economici e politici senza creare vuoti di potere
e pregiudicare
la ricerca di stabilità e di sicurezza. Di qui
il «reset»
nei confronti della Russia e la rinnovata centralità
assegnata al
Trattato di Non Proliferazione, che non costituiscono
solo una
condizione per contrastare la proliferazione delle armi
di distruzione
di massa e i rischi di terrorismo nucleare, ma a loro
volta
appaiono strettamente collegati allo sforzo di perseguire
una
stabilizzazione del «grande Medio Oriente»
su basi cooperative.
Una stabilizzazione che nelle intenzioni dovrebbe favorire
una
onorevole exit strategy dall’Afghanistan e un
«contenimento»
politico dell’Iran che escluda l’ipotesi
di attacco israeliano, contribuendo
al tempo stesso a creare le condizioni per una ripresa
del processo di pace. Si tratta di una strategia che
ha conseguito
alcuni importanti successi (la firma del nuovo trattato
Start e
la Nuclear Posture Review, la riforma sanitaria, la
risposta alla
crisi), ma che al tempo stesso sconta un quadro politico
interno
problematico e un’evidente difficoltà a
condizionare gli attori
politici regionali e non statali soprattutto nel «grande
Medio
Oriente».
Questo sofferto processo verso un nuovo multipolarismo
e il
tentativo dell’amministrazione Obama, non privo
di contraddizioni,
di incardinarlo in una rinnovata architettura multilaterale
presentano per l’Europa al tempo stesso rischi
e opportunità.
I rischi sono innanzitutto quelli di una marginalizzazione
del
vecchio continente, ma anche quelli di un fallimento
del tentativo
americano di «governare la transizione»
in Afghanistan e in
Medio Oriente, che non potrebbe che innescare sviluppi
assai
preoccupanti dal punto di vista dell’Europa e
della sua sicurezza.
Le opportunità non derivano solo dal contesto
molto più
propizio a una nuova Ostpolitik derivante dal nuovo
approccio
americano verso la Russia, ma sono quelle offerte dall’apertura
rilevante di nuovi spazi per l’iniziativa internazionale
europea e
dalla possibilità di dare vita a una rinnovata
partnership strategica con gli Stati Uniti che assegni
un ruolo centrale al rafforzamento
del processo di integrazione e punti alla costruzione
di
un nuovo ordine democratico multilaterale.
Scongiurare i rischi e cogliere le opportunità
impongono
innanzitutto volontà politica, ma richiedono
anche di saper
effettivamente fare della nuova architettura istituzionale
delineata
a Lisbona l’occasione per definire un assetto
di governance
in grado di dare coerenza e consistenza all’azione
esterna
dell’Unione. Il problema principale è quello
di rafforzare la
coe renza tra le differenti dimensioni dell’azione
esterna della
Ue (oltre che tra questa e la dimensione esterna delle
sue politiche
interne) e di definire le relazioni e le complementarità
tra
la Pesc/Psdc e la Nato, nel quadro del processo di costruzione
di una difesa comune. A questo proposito le novità
introdotte
dal trattato di Lisbona sono considerevoli: non solo,
infatti, la
nuova figura dell’Alto rappresentante/vicepresidente
della Commissione
(oltre che presidente del Consiglio Affari Esteri) assume
la titolarità della conduzione e del coordinamento
tanto
della componente intergovernativa che di quella comunitaria
dell’azione esterna dell’Unione, ma con
il Servizio Europeo per
l’Azione Esterna sarà finalmente possibile
unificare gli strumenti
di tale azione e coordinare la programmazione strategica
degli
strumenti finanziari dell’Unione europea (che
costituiscono l’elemento
più originale della sua azione internazionale)
con le iniziative
in ambito Pesc. Se a tutto ciò si aggiungono
le nuove disposizioni
che regolano la politica estera e di sicurezza comune
e la politica di sicurezza e difesa comune, la cooperazione
strutturata
permanente e le clausole di assistenza reciproca e di
solidarietà,
emerge una strumentazione istituzionale potenzialmente
in grado di far compiere un salto di qualità
all’azione esterna
della Ue e di sostenerne le ambizioni di attore globale.
In questo quadro, le priorità della politica
estera europea
sono facilmente individuabili: i Balcani occidentali,
con la
necessità di sviluppare sempre più un
approccio regionale nei
confronti del processo di allargamento e la sfida ad
assumere
fino in fondo il ruolo di garante della sicurezza della
regione; la
partnership orientale, concepita come ponte nei confronti
della
Russia e non più diaframma (a patto di saper
superare progressivamente
le divisioni interne ai 27 su questo punto); il Medio
Oriente e il Mediterraneo.
Proprio al Mediterraneo, agli scenari strategici che
si stanno
aprendo nell’area e al ruolo che l’Europa
ha giocato e giocherà
nel prossimo futuro, è dedicata la monografia
di quest’anno.
In particolare, i due saggi di apertura si soffermano
su due
fattori che sono destinati a incidere significativamente
sul futuro
strategico dell’area, rappresentati, da un lato,
dal rinnovamento
dello scacchiere delle alleanze nel quadro mediorientale;
dall’altro,
dall’esito dell’ondata incombente di successioni
al vertice,
attesa per gran parte dei paesi del Mediterraneo.
Il saggio di Fabio Nicolucci fa chiarezza sul complesso
panorama
della politica mediorientale anche alla luce degli avvenimenti
che hanno caratterizzato l’area negli ultimi anni.
Si tratta
di una questione di fondamentale importanza, soprattutto
per
gli effetti che si avranno in termini di stabilità
del Mediterraneo
nel suo complesso. Il sostanziale fallimento della politica
americana
in Iraq, l’assunzione dell’Iran come potenza
regionale e
l’emergere di nuovi elementi di contrapposizione
basati su fattori
etnico-religiosi lasciano presagire un panorama poco
rassicurante.
A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge una
politica americana, più promettente che in passato,
ma comunque
titubante e sempre meno incisiva, a cui si contrappone
la
concorrenza di altri attori che guardano a est con interesse
crescente
e un’Europa che ancora non riesce a convincere.
Il saggio di Philippe Droz-Vincent si sofferma sull’ondata
di successioni che ha interessato alcuni paesi della
sponda sud
(Marocco, Giordania e Siria) e che nel prossimo futuro
si propagherà
nella maggior parte di questi. In una regione come il
Mediterraneo, in cui gli ultimi trent’anni ha
predominato un’eccessiva
stabilità al vertice, le successioni previste
potrebbero
aprire nuovi interessanti scenari. Esse potrebbero rappresentare
un’occasione per superare la situazione di immobilismo,
un’opportunità
di rinnovamento politico. Sebbene non sia possibile
prevedere con esattezza gli esisti delle successioni,
l’analisi condotta
da Droz Vincent sembra, comunque, ridimensionare la
portata del cambiamento. La nuova generazione al potere
resterà
legata al sistema autoritario che l’ha preceduta.
Se non per
via ereditaria, i nuovi leader saranno scelti nel ristretto
ambito
delle elite al vertice.
In seguito a questo focus sugli scenari aperti in ambito
politico,
la parte monografica del Rapporto prende in considerazione
l’evoluzione delle politiche europee nell’area
del Mediterraneo
presentandone le principali caratteristiche, obiettivi
e
innovazioni introdotte di recente, mettendone in risalto
opportunità
e limiti.
Il saggio di Dorothée Schmid, in particolare,
traccia il quadro
delle politiche e del dibattito che hanno interessato
l’azione
comunitaria nel Mediterraneo negli ultimi quindici anni,
passando
dal partenariato euro-mediterraneo alla politica di
vicinato
alla più recente Unione per il Mediterraneo.
Nonostante
il rinnovamento del quadro politico di riferimento,
le politiche
comunitarie nel Mediterraneo non sembrano essere state
sufficientemente
incisive per affrontare le sfide e cogliere le nuove
opportunità che l’area presenta. L’obiettivo
della creazione di
un’area di pace e di stabilità è
lungi dall’essere realizzato. Rispetto
ai primi anni Novanta, il Mediterraneo vive gli stessi
conflitti e tensioni ancora attive (Sahara occidentale,
Israele-
Palestina e Cipro), e i fattori di instabilità
si sono acuiti con il
passare del tempo. Queste conclusioni sono condivise
anche da
Bruno Marasà, il quale precisa come in prospettiva
la stabilizzazione
del vicinato, soprattutto a sud, rimarrà centrale
nelle
relazioni dell’Unione europea con la regione soprattutto
con riferimento
ai nuovi equilibri geo-politici determinati dall’evoluzione
dello scacchiere delle alleanze in Medio Oriente. Secondo
l’autore, il ruolo dell’Europa nell’area
dipenderà molto dalla
sua capacità di operare un rafforzamento della
dimensione politica
nell’azione verso il Mediterraneo, sfruttando
le opportunità
aperte in questo senso dalle innovazioni apportate dal
trattato
di Lisbona. Sarà necessario, in particolare,
rafforzare la capacità
dell’Unione di imporsi come attore rilevante nell’area,
il che si
traduce nella capacità di esprimersi con una
voce unica, di assumere
una posizione di rilievo nella pacificazione dell’area
e,
in particolare, nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese,
in un’ottica di crescente collaborazione con gli
Stati Uniti, sfruttando
il cambiamento di rotta inaugurato dall’amministrazione
Obama.
Allo stesso tempo, deve essere rafforzato il contributo
delle
politiche comunitarie nella promozione di riforme politiche
nei
paesi partner della sponda sud; obiettivo questo enunciato
dalla
Dichiarazione di Barcellona e perseguito nell’ambito
del paniere
politico del partenariato euro-mediterraneo. Ripreso
anche dai
«Piani di azione della politica di vicinato»,
questo principio ha
faticato a trovare una concreta attuazione. Il saggio
di Rosa Balfour
e Battistina Cugusi spiega come dietro questa impasse
abbia
per lungo tempo perdurato il timore di minare la stabilità
dell’area promuovendo quei movimenti e partiti
islamici che,
in molti paesi, rappresentano importanti forze di opposizione
o
con largo seguito nella società. Sebbene la possibilità
di dialogare
a livello politico con questi attori sia stata fortemente
dibattuta,
a livello europeo non esiste una posizione univoca né
una politica comune verso tali attori.
Il contributo di Lorenzo Coslovi e Paola Monzini mostra
bene come il tema delle migrazioni trans-mediterranee
sia considerato
tra i principali fattori di instabilità in provenienza
dalla
sponda sud del Mediterraneo. L’analisi dell’evoluzione
delle
politiche bilaterali condotte negli anni Ottanta e Novanta,
e, in
seguito, delle politiche europee svela il prevalere
di un approccio
restrittivo verso le migrazioni dai paesi della sponda
sud del
Mediterraneo. Il saggio spiega anche come l’adozione
di un approccio
di questo tipo abbia acuito il sentimento di insicurezza
piuttosto che attenuarlo. Esso, infatti, ha contribuito
a generare
conseguenze inattese, tra cui la diversione dei flussi
su rotte alternative,
ma più pericolose, con l’aumento del ruolo
della malavita
nella gestione delle nuove rotte, e ha contribuito a
rendere
a loro volta i paesi della sponda sud sempre più
paesi di transito
dei flussi migratori provenienti dall’Africa sub-sahariana.
Il saggio di Frédéric Blanc e Nathalie
Roux si sofferma sugli
aspetti economici delle relazioni euro-mediterranee
e soprattutto
sulle dinamiche degli scambi delineando l’evoluzione
che il sistema
di interdipendenza tra le due sponde del Mediterraneo
ha conosciuto dal 1995 a oggi. Come noto, la creazione
di una
zona di libero scambio ha rappresentato il perno della
strategia
fissata a Barcellona, in cui il rafforzamento dell’interdipendenza
economica rappresenta il volano attraverso il quale
stimolare lo
sviluppo dei paesi della sponda sud. Dal 1995, un importante
risultato raggiunto dal partenariato euro-mediterraneo
è stato
quello di aver effettivamente contribuito alla maggiore
apertura
internazionale dei partner della sponda sud, soprattutto
sul
fronte degli investimenti e degli scambi di servizi.
Gli autori sottolineano,
tuttavia, come il partenariato non abbia raggiunto i
suoi obiettivi principali. Le promesse di un dinamico
mercato
pan-mediterraneo, che alimentavano la visione tecnocratica
del
partenariato euro-mediterraneo prima maniera, sono naufragate
nello scarso sviluppo degli scambi sub-regionali (fermi
dal 1995
al 5%), in scambi caratterizzati da un’evidente
asimmetria (solo
il 9% delle esportazioni extra-Ue e il 6% degli Ide
extra-Ue
proviene dai paesi della sponda sud), in una scarsa
qualità degli
scambi stessi (forte polarizzazione su prodotti di specializzazione),
in una integrazione produttiva marginale.
Come mostra Mustafa K. Faid nel suo saggio, anche il
settore
energetico non è al riparo dalla relazione asimmetrica
che
caratterizza gli scambi commerciali nell’area
mediterranea: così,
mentre i paesi europei sono i principali paesi di sbocco
di questa
tipologia di esportazione (il 70% delle esportazioni
di petrolio
e il 90% di quelle di gas dell’Africa del nord
sono destinati
all’Europa), le importazioni dai paesi della sponda
sud, seppur
rilevanti, soddisfano solo il 15% del fabbisogno energetico
dei
paesi europei, secondo una strategia di diversificazione
delle
fonti di approvvigionamento. In prospettiva, il settore
energetico
sarà comunque determinante per il futuro dell’area
e delle relazioni
euro-mediterranee; un rafforzamento della cooperazione
in questo campo assume, dunque, rilevanza strategica.
Diverse
saranno le sfide all’ordine del giorno, prima
fra tutte quella che
vede l’area di fronte a una maggiore competizione
per le risorse:
da un lato cresceranno i consumi energetici dei partner
della
sponda sud (il fabbisogno dovrebbe crescere di circa
il 40% nei
prossimi 15 anni); e dall’altro gli ingenti investimenti
necessari
per farvi fronte potrebbero provocare tensioni sul piano
della
disponibilità.
Il saggio di Hanaa Ebeid, infine, presenta il punto
di vista
arabo sul ruolo dell’Unione europea e sulle politiche
comunitarie
nel Mediterraneo. Basandosi sui media e prendendo come
fonte soprattutto la carta stampata, l’analisi
svela una visione
dell’Europa complessa e sfaccettata, dove l’interesse
crescente
per il partenariato economico si mescola con un sentimento
di
insoddisfazione per i risultati di politiche che sembrano
essere
tagliate più per l’interesse della sponda
nord; dove la visione romantica
dell’Europa come potenza mondiale rispettosa del
diritto
internazionale deve fare i conti con le difficoltà
della stessa
di assumere una posizione decisiva sul conflitto israelo-palestinese
o di intraprendere un’azione indipendente dagli
Stati Uniti;
dove l’ammirazione per i risultati raggiunti nel
processo di integrazione
europea si scontra con gli episodi di discriminazione
ai danni di migranti della sponda sud, che molta eco
hanno nei
paesi di provenienza.
Quella proposta nella monografia è dunque un’analisi
ad
ampio raggio che concepisce l’integrazione tra
le dimensioni
economica, sociale e politica come l’unica chiave
per consentire
all’Europa di superare i limiti della politica
mediterranea di
questi anni e di cogliere le straordinarie opportunità
che le trasformazioni
in atto offrono di fare del Mediterraneo una vera e
grande zona di prosperità e di pace condivisa.
|