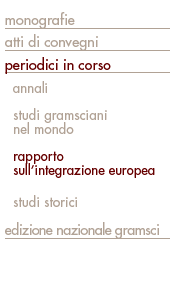|
 |

|
 |
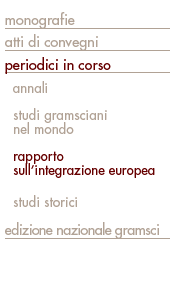

|
| <–
torna indietro |
Rapporto
2008 sull'integrazione
europea
della Fondazione Istituto Gramsci e del CeSPI
L'UNIONE EUROPEA
E IL GOVERNO
DELLA GLOBALIZZAZIONE
a cura di Roberto Gualtieri e Ferruccio Pastore
Il Mulino,
Bologna 2008
p. 296, € 21,50
ISBN 978-88-15-12543-9 |
 |
Prefazione
di Roberto Gualtieri
e Ferruccio Pastore
Il 2007 è
stato un anno di maturazione per l'Unione europea. Sembra
essersi chiuso un lungo periodo di disorientamento e di
esitazioni, pesantemente segnato dal fallimento del trattato
istituzionale e dalle profonde lacerazioni politiche nei
confronti della war on terror condotta dall'amministrazione
americana. Sul terreno economico, la buona performance
europea ha interrotto un lungo ciclo segnato da un differenziale
di crescita negativo tra i paesi ad alto reddito pro capite
dell'Unione e gli Stati Uniti. L’Unione europea
ha celebrato con i fatti il cinquantesimo anniversario
della firma dei Trattati di Roma, tornando a muoversi,
con alcuni passi concreti di grande importanza. Il primo
dato positivo riguarda l'allargamento, o meglio gli all’argamenti
paralleli dell'Unione, dello spazio Schengen e della zona
euro. È vero che l'ingresso nell'Ue di Romania
e Bulgaria, con cui l'anno si è aperto, ha rappresentato
solo la conclusione di un processo avviato da tempo, così
come è indubbio che l'implementazione della strategia
dell'allargamento nei confronti di paesi o aree fondamentali
per l'Europa come la Turchia o i Balcani continua a scontrarsi
con difficoltà e problemi non marginali. Tuttavia,
vedere l'Ue affacciarsi sul Mar Nero non è cosa
da poco, così come è difficile sottovalutare
l'importanza simbolica e politica dell' eliminazione delle
frontiere tra la Germania e la Polonia, o tra l'Italia
e la Slovenia, nel quadro dell'allargamento dell'area
di Schengen ai nuovi membri del 2004 (meno Cipro) realizzato
il 21 dicembre del 2007. A sua volta, l'introduzione dell'euro
a Malta e a Cipro, decisa in luglio e divenuta operativa
il 10 gennaio 2008, rappresenta senza dubbio un evento
poco più che trascurabile in termini quantitativi.
Ma è tutt'altro che privo di rilievo sia sul piano
della trasparenza dei mercati finanziari e della crescente
determinazione con cui l'Europa intende affrontare la
questione dei cosiddetti «paradisi fiscali»
(un tema che di recente è entrato prepotentemente
al centro dell'agenda politica tedesca e quindi europea),
sia su quello dell'indicazione di una crescente forza
di attrazione della valuta europea anche nei confronti
di paesi – come Malta – tradizionalmente legati
alla sterlina.
In un anno segnato da una grave crisi delle banche, non
solo statunitensi, e del sistema della finanza derivata
sviluppatosi sotto la spinta della politica monetaria
fortemente espansiva seguita dalla Federal Reserve per
sostenere la crescita americana, la solidità dell'euro
e dell'economia europea costituiscono un secondo elemento
degno di nota. Sull'onda del buon andamento della crescita
registrato nel 2006 sia dall'Ue-25 che dall'Ue-15 e dall'area
euro (grazie in particolare all'eccellente performance
della Germania), nonostante l'impatto della crisi finanziaria,
l'economia dell'Ue ha mantenuto pressoché inalterato
il suo tasso di sviluppo anche nel 2007. Nel corso dell'anno
passato come nota Fabio Sdogati nella sua rubrica «Economia
e allargamento» in questo volume – per la
prima volta dopo diversi anni i paesi Ue a più
alto reddito pro capite hanno evidenziato una crescita
superiore a quella statunitense, confermata anche dalle
previsioni per il 2008 seppure in un contesto di complessivo
rallentamento. Tutto ciò è in primo luogo
la conseguenza dell'efficacia dei processi di ristrutturazione
realizzati in questi anni dalle imprese europee e degli
effetti benefici dell'integrazione commerciale e produttiva
favorita dall'allargamento. In questo quadro, l'inedita
risolutezza e prontezza di intervento manifestata dalla
Banca centrale europea di fronte alla cosiddetta «crisi
dei mutui sub-prime» e il successo, unanimemente
riconosciuto, della sua azione possono essere considerati
come il primo esplicito segnale della ricerca di una maggiore
autonomia di azione volta a irrobustire il ruolo internazionale
dell'euro e a tutelare la specificità del modello
di sviluppo e del modello sociale europei dai rischi della
finanziarizzazione dell' economia favorita dalla politica
monetaria americana dell'«era Greenspan».
Il terzo dato positivo è costituito ovviamente
dalla firma, il 13 dicembre 2007, del Trattato di Lisbona.
Si tratta con ogni evidenza di un risultato di grande
importanza. Esso consente infatti di superare una pericolosa
impasse che, dopo l'esito negativo dei referendum francese
e olandese del 2005, rischiava di archiviare la prospettiva
di un significativo approfondimento del processo di integrazione.
Allo stesso tempo, la firma del nuovo trattato e la sua
auspicabile – e prevedibile – ratifica chiudono
finalmente una lunga stagione dominata dalla centralità
del tema
istituzionale e dalla tradizionale contrapposizione tra
la prospettiva federalista e quella intergovernativa:
due posizioni ormai di fatto entrambe anacronistiche e
scarsamente corrispondenti alla reale natura della costruzione
europea ed alle sue esigenze. Il risultato, come mette
in evidenza il contributo di Sandro Guerrieri, conserva
la sostanza delle innovazioni introdotte dal vecchio Trattato
costituzionale nonostante la rinuncia al – peraltro
ambiguo – carattere «semicostituzionale»
del precedente testo: rimangono, dunque, il superamento
della struttura a pilastri e il conferimento della personalità
giuridica all'Ue; sono confermati
la creazione di una figura di presidente del Consiglio
europeo nonché il rafforzamento del ruolo, delle
funzioni e dei mezzi dell'Alto rappresentante per la Pesc,
ora anche vicepresidente della Commissione e presidente
del Consiglio «affari esteri»; il nuovo testo,
inoltre, conferma la revisione dei criteri di voto a maggioranza
qualificata (sebbene solo a partire dal 2014, e forse
persino dal 2017), l'ampliamento del ruolo di codecisione
del Parlamento e l'attribuzione di un carattere vincolante
alla Carta dei diritti fondamentali (tuttavia esclusa
dal Trattato). In questa nuova architettura istituzionale
viene rafforzata la dimensione propriamente politica e
incentivata la formazione di «nuclei ristretti»,
sia pure nel contesto di una riconferma e di un'estensione
del «metodo comunitario» (di grande rilievo
è da questo punto di vista la «comunitarizzazione»
del terzo pilastro, di cui si parlava da oltre un decennio),
oltre che del tradizionale modello di multilevel governance
verticale e orizzontale che rende l’Ue un attore
unico nel panorama internazionale.
In questo quadro, diviene centrale la questione di una
vergenza politica dei paesi e degli attori fondamentali
dell'Unione nella ricerca di soluzioni comuni intorno
ai problemi più rilevanti per il futuro dell'Europa.
Anche da questo punto di vista, da un esame retrospettivo
delle vicende del 2007 emergono alcune indicazioni incoraggianti.
Al di là del persistente travaglio del sistema
politico polacco e delle posizioni non propriamente europeistiche
assunte in passato dal partito del neopremier Tusk, l’esito
delle elezioni che hanno portato alla sconfitta del partito
populista di destra dei gemelli Kaczynski ha indicato
chiaramente l'insostenibilità di una linea di governo
fondata sull'aperta contrapposizione all'Ue e la capacità
del contesto europeo di esercitare un certo grado di condizionamento
indiretto sulla politica interna dei suoi membri. Il cambiamento
intervenuto in un paese importante come la Polonia non
potrà essere privo di riflessi su alcuni problemi
cruciali che investono le relazioni internazionali dell'Ue,
a cominciare dalla questione dei rapporti con la Russia.
Più in generale si può dire che, anche per
effetto delle crescenti difficoltà in cui versa
l'unilatealismo statunitense, l'Europa sta manifestando
un significativo impegno nella costruzione di un'unità
(almeno tra i suoi membri fondamentali) intorno ad alcuni
dei principali problemi di politica estera sul tappeto,
evitando il ripetersi delle lacerazioni che hanno accompagnato
la vicenda irachena e manifestando una significativa disponibilità
ad assumere un ruolo meno defilato sul fronte internazionale,
pur in presenza di significative divergenze su questioni
politiche importanti (basti pensare allo strappo, poi
rammendato, sul progetto francese di «Unione mediterranea»).
Lo dimostra il ruolo svolto in uno scacchiere cruciale
come il Libano dopo l'invio delle truppe realizzato su
iniziativa italiana (sia pure al di fuori dei meccanismi
formali della Pesd), così come l'atteggiamento
assunto nella delicata questione dell'indipendenza del
Kosovo. È vero, infatti, che una proclamazione
unilaterale di indipendenza alle soglie dell'Europa costituisce
di per sé una sconfitta, così come è
vero che sulla questione del riconoscimento del nuovo
stato l'Unione non è riuscita ad assumere un atteggiamento
unanime. Tuttavia, occorre tenere presente che se l'indipendenza
di Pristina ha costituito l'esito finale di una lunga
vicenda da tempo compromessa, i principali paesi dell'Unione
hanno realizzato (anche grazie ad un ruolo attivo dell'Italia)
una significativa convergenza intorno a una posizione
comune tutt'altro che passiva e rinunciataria, fondata
sul tentativo di «governare» il processo di
costruzione di uno stato indipendente in Kosovo, attutendo
le frizioni con la Serbia e lavorando per indirizzare
i due paesi verso una crescente integrazione con l'Europa.
Tutti questi segnali consentono di affermare che nell'ultimo
biennio l'Europa si è rimessa in cammino, manifestando
una crescente consapevolezza della necessità di
assumere maggiori responsabilità internazionali.
Questa Ue rinnovata, che riemerge da anni di profonde
difficoltà istituzionali e politiche, ricerca la
sua legittimazione non più solo nella capacità
di risolvere le proprie contraddizioni interne, ma anche,
e sempre più esplicitamente, nella promessa di
affrontare efficacemente le contraddizioni globali di
un mondo alla ricerca di un multilpolarismo meno anarchico
e conflittuale dell'attuale. La monografia curata da Rosa
Balfour e Ferruccio Pastore ha appunto l'obiettivo di
analizzare e discutere le ambizioni e i limiti dell'Unione
europea come attore globale, riconoscendo i risultati
raggiunti e le potenzialità manifestate dall'Europa
su questo terreno, ma anche sottolineando le non poche
contraddizioni e difficoltà emerse negli ultimi
anni. In sette densi saggi, dedicati ai settori-chiave
dell'azione esterna dell'Ue, l'ambizione dichiarata –
spesso in forme magniloquenti – dalle istituzioni
europee di contribuire a «governare la globalizzazione»
viene vagliata alla luce dei fatti. Il quadro che emerge,
al di là degli sviluppi incoraggianti cui abbiamo
accennato, è frammentario, contrastato e aperto
a esiti diversi. In alcuni ambiti – come sul terreno
della lotta al riscaldamento globale – l'Unione
ha saputo porsi, nel giro di pochi anni, come un attore
globale di primo piano, capace di dettare l'agenda e di
mediare efficacemente tra gli Stati Uniti e le potenze
emergenti. In altri campi, come l'azione esterna in campo
economico o la politica migratoria, la Comunità
è indubbiamente un player di peso crescente, che
però si muove in maniera spesso contraddittoria,
invocando la necessità di immigrazione mentre innalza
muri, predicando solidarietà mentre impone liberalizzazioni
dagli effetti potenzialmente laceranti, o infine manifestando
una crescente autorevolezza e autonomia nel governo della
propria moneta, senza al contempo riuscire a edificare
in modo coerente una politica economica europea. Ci sono
poi settori, come quello della politica energetica, e
specificamente della sua dimensione esterna, dove l'Europa
non riesce ancora a identificare e perseguire una strategia
delle infrastrutture e degli approvvigionamenti con sufficiente
forza e coerenza. Infine, sul piano più propriamente
politico, la considerevole forza egemonica dimostrata
nella costruzione di una larga coalizione internazionale
per l'abolizione della pena di morte, che ha portato all'approvazione
della moratoria da parte dell' Assemblea generale delle
Nazioni Unite, si scontra con un uso della condizionalità
ondivago e asimmetrico sul terreno dei diritti umani.
La monografia, in un rapporto di complementarietà
dinamica con le rubriche tematiche, intende fotografare
questo ruolo complesso che l'Unione oggi svolge nel mondo.
È inutile sottolineare quanto questo tipo di riflessione
sia rilevante sul piano politico. In un mondo multipolare
instabile e competitivo, l'Unione non può più
vivere di rendita al riparo dell'egemonia statunitense
e di una sostanziale assenza di concorrenza commerciale
dall'esterno. Dal Medio Oriente all'Africa, dai rapporti
con la Russia a quelli con la Cina,l'India e il Brasile,
i costi del non agire, il prezzo dei particolarismi e
delle divisioni sono destinati a crescere. Di fronte a
queste sfide, oggi più che mai, il destino dell'Europa
è nelle mani degli europei. |
|
|
 |
| |
| ©
copyright 1996, 2015
| FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI onlus |
cf 97024640589
|
| sede
legale, uffici amministrativi
|
ROMA VIA PORTUENSE 95c
|
tel. 0039 0683901670 fax 0039 0658157631 |
| segreteria,
archivi, biblioteca
|
ROMA VIA SEBINO 43a| tel. 0039 065806646 fax 0039 0658157631 |
|
|
|