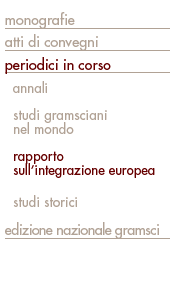|
 |

|
 |
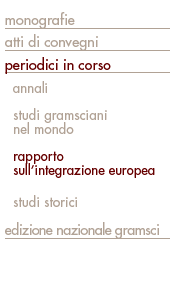

|
| <–
torna indietro |
Rapporto
2007 sull'integrazione
europea
della Fondazione Istituto Gramsci e del CeSPI
PERCHÈ
L'EUROPA?
a cura di José Luis Rhi-Sausi e Giuseppe Vacca
Il Mulino,
Bologna 2007
p. 286, € 21,00
ISBN 978-88-15-11907-0 |
 |
Introduzione
a cura di Stefano Fassina e Pier Carlo Padoan
Il nostro Rapporto sull’integrazione europea,
alla sua V edizione,
va in libreria in coincidenza con le celebrazioni del
cinquantesimo
anniversario della firma dei Trattati di Roma (25
Marzo 1957), istitutivi della Comunità economica
europea. L’anniversario
cade in una fase difficile del processo di integrazione
europea. I giri a vuoto della Strategia di Lisbona, la
bocciatura,
in Francia prima ed in Olanda poi, del Trattato costituzionale
e, successivamente, il modestissimo accordo raggiunto
sulle prospettive
finanziarie 2007-2013 sono le punte di un iceberg di
smarrimento delle ragioni dell’Unione. Sotto la
superficie del
mare in cui l’iceberg galleggia si intravede minaccioso
il risveglio
dei populismi nazionalisti, delle paure dell’altro,
delle identità
chiuse ed arroccate.
Di fronte alle sfide poste dall’integrazione dei
contesti nazionali,
l’Unione europea non è stata percepita dai
«suoi» cittadini
come uno strumento utile a riaffermare la cittadinanza
sociale,
il pilastro distintivo della costituzione materiale costruita
nei
paesi membri in mezzo secolo di vita democratica. Al contrario,
l’Unione europea è stata presentata come
una sorta di cavallo
di Troia del cosmopolitismo livellatore delle identità
nazionali,
come leva per far saltare i virtuosi compromessi socialdemocratici,
garanzia dei diritti individuali e collettivi. Quindi,
l’Unione
non come fattore di riappropriazione del primato della
politica
e di rinvigorimento della democrazia oltre la dimensione
dello
stato nazionale, ma come causa di espropriazione tecnocratica
della sovranità.
In tale contesto, la scelta compiuta dal Consiglio europeo
all’indomani
delle sconfitte referendarie in Francia ed Olanda, di
fare «una pausa di riflessione» non sembra
contribuire a ricostruire
le condizioni per ridare, da un lato, forza alle leadership
politiche «integrazioniste» e, dall’altro,
per orientare opinioni
pubbliche spaesate di fronte alle minacce esterne al benessere
economico, alla sicurezza fisica, all’identità
collettiva. Tali condizioni
sono, però, necessarie e vanno costruite affinché
l’Unione
possa attrezzarsi al mondo del XXI secolo.
Le difficoltà della fase attuale non vanno drammatizzate.
La
portata della stagnazione in corso va misurata con il
metro della
storia, non con quello della cronaca (cfr. il saggio di
Telò): ci
sono state altre crisi sistemiche nel lungo cammino intrapreso
dagli integrazionisti dal dopoguerra ad oggi (in particolare,
nel
1954, con il fallimento della Comunità europea
di Difesa). Inoltre,
va ricordato che il processo di integrazione va avanti
nella
realtà quotidiana, nonostante il blocco delle riforme
istituzionali
e le conseguenze dell’allargamento sui meccanismi
decisionali.
L’avanzamento inerziale dell’Unione dipende
da varie cause,
interne ed esterne. In primo luogo, tra le cause interne,
Manzella
ricorda i) l’ingranaggio giuridico e giurisprudenziale
che
consente all’Unione di fare policy oltre la lettera
dei Trattati, ii)
l’attività ordinaria della Commissione, iii)
il lavorio delle tecnostrutture
a Bruxelles e nelle altre capitali, iv) l’interdipendenza
tra ordinamento giuridico comunitario e ordinamenti nazionali,
ossia la continua produzione di norme da parte di questi
ultimi
e la corrispondente produzione di risposte da parte del
primo.
L’integrazione poi va avanti nei fatti, anche se
spesso difficili da
percepire e da attribuire all’Europa. E i fatti
dicono di una condizione
di vita di tutti i giorni che sarebbe assai piu insicura
e
meno confortevole dal punto di vista materiale se l’Europa
«non
ci fosse».
In terzo luogo, ma non meno rilevanti, cause esterne spingono
avanti l’integrazione politica pur nella fissità
del quadro
istituzionale e di governance. Ad esempio, come sottovalutare
il
rilievo per l’immagine che l’Unione ha di
se stessa della pronta
reazione alla crisi libanese di agosto 2006? Oppure, come
scartare
la possibilità che i continui movimenti geopolitici
nel settore
energetico accelerino la definizione di una politica comune
in un settore chiave per la sicurezza e la quantità/qualità
della
crescita economica? Naturalmente, affinché queste
possibilità si
traducano in azioni concrete, lo sforzo da compiere è
rilevante e
non va sottovaluata la possibilità che, anche per
carenza di leadership,
su questi come su altri temi strategici l’Europa
rimanga
al di sotto delle aspettative e finiscano per prevalere
soluzioni
nazionali, necessariamente di corto respiro.
Insomma, nonostante la pausa di riflessione, il motore
integrazionista
gira, lentamente e a singhiozzo per l’affaticamento,
l’usura ed il carico di lavoro degli ultimi tre
decenni e dell’ultimo
in particolare, ma gira. È, comunque, un andamento
inadeguato
ad affrontare le sfide, i rischi e le opportunità,
di fronte
agli stati del benessere e al processo di integrazione
nel suo insieme.
E, poiché inadeguato a dare forza sovranazionale
alla politica
e alla democrazia depotenziate nelle comunità nazionali,
lascia spazio ai motori «neo-sovranisti» di
destra e di sinistra, al
ripiegamento nazionalistico, alla chiusura identitaria.
Che fare per ridare slancio al processo di integrazione
politica?
Non basta puntare sulla fantasia politico-istituzionale.
Non
bastano certamente escamotage giuridici, quale la pur
importante
Dichiarazione annessa al Trattato costituzionale. Non
bastano
neppure appelli retorici alle ragioni del passato, ossia
all’Unione
come motore di pace e di sviluppo economico, in un continente
segnato da sanguinose guerre civili tra stati nazione
accecati
dalla politica di potenza. Per ridare slancio al processo
di integrazione
politica si deve partire da alcune domande di fondo:
perché l’Unione europea nel XXI secolo, nell’epoca
dell’interdipendenza?
Serve ancora un avanzamento politico dell’Unione?
Non basta, anzi, non deve bastare in un’Unione a
27 membri,
porsi l’obiettivo (non poco ambizioso viste, ad
esempio, le difficoltà
incontrate dalla Direttiva Bolkenstein) del mercato unico?
Per far andare avanti l’integrazione politica, le
leadership
europee della politica, della cultura, della religione,
dell’economia,
devono saperla rimotivare – a sé stesse e
con le opinioni
pubbliche – sul piano etico-politico e su quello
della funzionalità
economica e dei risultati concreti, per far dire ai cittadini
che l’Unione effettivamente migliora le loro condizioni
di vita.
Come fecero le leadership fondatrici negli anni ’40
e ’50, è da
questo livello che si deve muovere.
L’Unione europea, quindi, per riaffermare i valori
alti della
civiltà europea, filtrati attraverso le vicende
terribili di secoli di
storie nazionali, in particolare delle storie del Novecento:
cooperazione
e convivenza pacifica tra le comunità nazionali,
diritti
di cittadinanza, equità e coesione sociale, valore
sociale del
lavoro, democrazia sostantiva, affermazione della laicità
dello
stato in relazione alla dimensione pubblica del sentimento
religioso.
L’Unione europea, quindi, per favorire il dialogo
e l’incontro
tra le culture, per cogliere le potenzialità culturali
oltre
che economiche dell’integrazione dei mercati a livello
globale e
le opportunità dell’interdipendenza, per
contribuire ad una governance
democratica, quindi multilaterale, dell’ordine internazionale
post guerra fredda, per alimentare un ordine mondiale
capace di ridurre la povertà ed offrire possibilità
di sviluppo
economico sostenibile sul piano sociale ed ambientale.
L’Unione
europea, quindi, per ricostruire, in una dimensione sovranazionale,
il compromesso virtuoso tra democrazia e capitalismo,
i
welfare states, definito a scala nazionale nei decenni
successivi al
secondo conflitto mondiale.
In sintesi, l’Unione europea dei risultati che si
legittima non
solo attraverso istituzioni e processi più aperti
alla partecipazione
delle opinioni pubbliche nazionali e transnazionali, dei
parlamenti nazionali e delle autonomie subnazionali, ma
anche,
forse soprattutto, attraverso istituzioni e processi in
grado, lo ripetiamo,
di far arrivare ai cittadini miglioramenti concreti, siano
essi legati alla sicurezza, alla vita materiale, alle
possibilità di occupazione
per sé e per i propri figli. In fondo, su questo
terreno,
le difficoltà della politica europea sono le stesse
difficoltà
della politica nazionale in molti dei paesi membri dell’Unione.
Là dove la politica non è in grado di rispondere
alle domande
dei cittadini inevitabilmente diventa astratta e distante,
perde legittimità,
rischia di lasciare spazio a soluzioni oscure e oggettivamente
reazionarie.
Per far ripartire la marcia integrazionista è necessario
un
pensiero che assuma come fondativo dell’agire politico
il valore
dell’incontro e del dialogo tra le civiltà.
A tal fine, è di grande
utilità tornare alle parole di De Gasperi ricordate
da Tonini:
è essenziale attingere al liberalismo,
al socialismo, al personalismo
quali componenti, tutte insostituibili perché nessuna
autosufficiente,
del pensiero nuovo che serve alla costruzione dell’Europa
Unita.
Un’Europa nella quale le radici cristiane devono
essere assunte
non per «introdurre un criterio confessionale esclusivo
nell’apprezzamento della nostra storia». Ma
soltanto per parlare del retaggio europeo comune, di quella
morale
unitaria che esalta la figura e la responsabilità
della persona umana
col suo fermento di fraternità evangelica, col
suo diritto ereditato dagli
antichi, col suo culto della bellezza affinatosi attraverso
i secoli, con la
sua volontà di verità e giustizia acuita
da un’esperienza bimillenaria.
Per far ripartire la marcia integrazionista, è
necessaria, inoltre,
un’analisi che riconosca i vantaggi già colti
e le potenzialità
da cogliere dell’integrazione globale dei mercati
e delle comunità
nazionali. Un’analisi che, al tempo stesso, riconosca
la dimensione
storica, quindi reversibile di tale integrazione (come
avvenuto all’inizio del Novecento, con le politiche
che poi portarono
ai due conflitti mondiali) e i rischi connessi alle derive
nazionaliste. Un’analisi che sottolinei le crescenti
difficoltà, sopratutto
per le culture progressiste, a puntellare l’attuale
ordine
mondiale segnato dal cosmopolitismo dell’economia
e dal nazionalismo
della politica.
In tale contesto analitico, le contraddizioni e gli effetti
negativi
dell’integrazione globale delle comunità
nazionali, in particolare,
come ricorda Andriani, l’aumento delle disuguaglianze
ed il ripiegamento delle aspettative e delle condizioni
di vita
delle classi medie nei paesi sviluppati (non a caso sopratutto
fuori dall’Europa), non devono far perdere equilibrio
alla lettura
storica ed economica della fase in corso: l’integrazione
nei
mercati globali come potente fattore di riduzione della
povertà
(circa 500 milioni di persone nell’ultimo quarto
di secolo), come
condizione per l’innalzamento della crescita potenziale
(oltre il
4% l’anno nell’ultimo quinquennio), come vettore
di contaminazione
culturale e di riconoscimento reciproco tra civiltà
storicamente
separate o antagoniste. Certamente, l’Unione europea
deve attrezzarsi per saper cogliere tali opportunità
(Padoan).
Attraverso più vigorose politiche nazionali (come
richiede tra
l’altro la nuova Strategia di Lisbona), e attraverso
gli strumenti
per una politica economica europea, sia federale (ad esempio,
una diversa allocazione delle risorse per il bilancio
comunitario,
coerente con gli obiettivi del sostegno alla innovazione
e
alla sicurezza dei confini), sia intergovernativa (ad
esempio, un
utilizzo anticiclico del Patto di Stabilità e Crescita
e soprattutto
una composizione dei bilanci pubblici nazionali attenta
alla qualità
delle politiche finanziate). Tutto ciò dovrà
essere realizzabile
in un assetto a 27 paesi o, di fronte ad una stasi delle
riforme di
governance, mediante cooperazioni rafforzate.
Per promuovere sul terreno politico tale quadro analitico
sono ovviamente decisive le culture delle principali famiglie
politiche dell’Europa: la famiglia dei partiti conservatori
e la
famiglia dei partiti socialisti, laburisti e progressisti.
Entrambe
in evoluzione, come tratteggiato nei contributi di Pistelli
e Borioni.
Un’evoluzione segnata anche dall’ingresso
nella «piccola»
Unione dei 15 dei paesi dell’Europa ex comunista,
i quali sono
alle prese con una difficile fase di apprendimento della
democrazia
(Biagini-Carteny descrivono il caso della Romania).
Ripartire dalle ragioni di fondo che motivano l’integrazione
politica dell’Unione europea è condizione
fondamentale per
vincere la sfida delle riforme istituzionali, per superare
la diffidenza
e l’ostilità di larghe fasce di cittadini
europei, indipendentemente
dalle specifiche soluzioni giuridiche che verranno adottate
per aggirare le bocciature del Trattato costituzionale. |
|
|
 |
| |
| ©
copyright 1996, 2015
| FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI onlus |
cf 97024640589
|
| sede
legale, uffici amministrativi
|
ROMA VIA PORTUENSE 95c
|
tel. 0039 0683901670 fax 0039 0658157631 |
| segreteria,
archivi, biblioteca
|
ROMA VIA SEBINO 43a| tel. 0039 065806646 fax 0039 0658157631 |
|
|
|