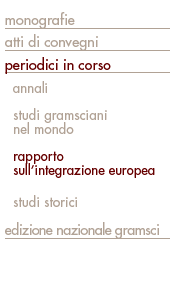|
 |

|
 |
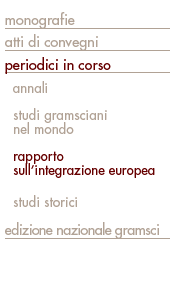

|
| RAPPORTO
SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA |
| <–
torna indietro |
Rapporto
2005 sull'integrazione
europea
della Fondazione Istituto Gramsci
DALLA CONVENZIONE
ALLA COSTITUZIONE
a cura di Giuseppe Vacca
Dedalo, Bari
2005
p. 328, € 15,00
ISBN 88-220-6283-3 |
 |
Presentazione
di Giuseppe Vacca
Questo terzo Rapporto sull’integrazione europea
venne progettato agli inizi del 2004, quando l’Europa
allargata e il «Trattato per la Costituzione»
non c’erano ancora. Oggi ci sono, la Costituzione
europea è stata approvata tanto dai governi dell’Unione,
quanto dal Parlamento europeo ed è in corso la
sua ratifica da parte dei parlamenti nazionali, accompagnata
in paesi importanti da referendum popolari. Scegliemmo
come tema della monografia Dalla Convenzione alla Costituzione
perché ritenevamo che, malgrado i contraccolpi
e le lacerazioni provocati dalla guerra irachena, l’allargamento
sarebbe andato in porto e la Grande Europa si sarebbe
data una Costituzione; cioè, pur in presenza delle
nuove sfide originate dall’unilateralismo americano
e dal conseguente mutamento della scena mondiale, riponevamo
fiducia nella forza e nell’autonomia del processo
di integrazione europea. Quindi scegliemmo questo tema
sia per mettere a fuoco il significato della Costituzione,
che ritenevamo sarebbe stata «partorita»,
sia per approfondire le novità dello strumento
prescelto per scriverla (la Convenzione). Avvertivamo
l’esigenza di seguire attentamente un percorso ricco
di novità, rispetto alle tappe precedenti dell’«avventura
europea», e analiticamente affascinante nella sua
non scontata progressione. Fra le maggiori incognite del
percorso vorrei ricordare il ruolo dei paesi ex socialisti
e le divisioni provocate dalla «dottrina Bush».
È relativamente agevole ricostruire quanto
abbia inciso, sul compromesso costituzionale raggiunto,
l’apporto dei «nuovi venuti », e nel
Rapporto lo si fa ampiamente. Molto più difficile,
invece, è stabilire quanto abbia pesato, durante
il travaglio del parto, l’incrinatura delle relazioni
euroatlantiche, la più grave dalla fine della Seconda
guerra mondiale. Verosimilmente le lacerazioni provocate
dalla «guerra preventiva» in Iraq non hanno
favorito la possibilità che l’Europa definisse
unitariamente la sua posizione nel mondo prendendo in
considerazione innanzitutto i costi umani inflitti alle
popolazioni irachene dalla guerra e dal dopoguerra. Non
hanno favorito, cioè, un percorso della Costituzione
che, sostenuto da una discussione aperta sulla missione
dell’Europa, ne approfondisse il ruolo di attore
globale in rapporto innanzitutto ai popoli più
colpiti dalle asimmetrie del mondo post-bipolare e dalla
nuova «dottrina» della Presidenza americana.
Ma il tema prescelto per la monografia mirava a rivolgere
lo sguardo all’intero percorso dell’unificazione
europea dopo il 1989-1991. Perciò essa è
orientata a individuare i problemi che la scelta di unificare
l’Europa a Venticinque attraverso un Trattato costituzionale
presentava, piuttosto che a enfatizzare i risultati raggiunti
o ad approfondire l’interpretazione del testo costituzionale.
Questa scelta costituisce il tratto distintivo del Rapporto
rispetto ad altre pregevoli pubblicazioni dedicate nel
frattempo alla Costituzione e alle architetture istituzionali
da essa disegnate.
La problematicità del percorso intrapreso e dei
risultati consegnati al testo costituzionale, aperto tanto
a sviluppi progressivi quanto a impasse di difficile soluzione,
è il focus del saggio introduttivo di Biagio de
Giovanni, un testo molto ricco, schietto e stimolante,
che va al cuore del problema: egli si domanda se e in
che misura la Costituzione abbia raccolto la sfida, che
l’integrazione europea affronta soprattutto dall’89,
di dar vita a una nuova forma di sovranità. De
Giovanni richiama così l’attenzione sul problema
fondamentale dell’Unione e, pur considerando aperte
le sue prospettive future, dal genere Costituzione, prescelto
come strumento di unificazione, e dal testo approvato
sembra vedere rafforzati i suoi dubbi radicali sulla possibilità
di dar vita a una nuova forma di sovranità. Le
sue obiezioni si concentrano sulla possibilità
di espungere dalla politica – come egli ritiene
che l’Unione europea abbia fatto finora –
la decisione sullo «stato d’eccezione»:
in altre parole, frapponendo fra la politica e la guerra
una distanza tale da far ritenere che la prima possa fare
a meno quasi del tutto della seconda. Il tema è
decisivo e andrebbe discusso a fondo nel suo nocciolo
filosofico. Ma non è questa la sede, né
è questo il taglio della monografia che de Giovanni
stesso ha scelto. Sul tema da lui posto mi limito quindi
a osservare che, ove mai ne faremo oggetto di indagine,
ci sforzeremo di inquadrare storicamente il nesso fra
politica e decisione sullo «stato d’eccezione»:
cioè, cercheremo di storicizzare le nozioni della
politica e della guerra, alle quali quella di sovranità
è connessa. E naturalmente, nell’esaminare
il nesso storico fra la politica e la guerra riconsidereremo
innanzitutto il sistema delle relazioni internazionali
originato dalla Seconda guerra mondiale, la nascita dell’èra
atomica, sempre più incombente, il mondo post-bipolare.
Sul piano etico non potremo avere altra opzione che quella
della evitabilità della guerra: una opzione non
solo normativa, ma storicamente fondata sul riconoscimento
delle risorse politiche di un mondo sempre più
uno e interdipendente. Ma, per tornare ai contributi del
Rapporto, le risposte agli interrogativi posti da de Giovanni
mi pare si muovano su sentieri analitici solidi e ben
circoscritti, ricchi di prospezioni ricavate da una conoscenza
approfondita dell’esperienza comunitaria. Esse sono
sottese dalla consapevolezza del carattere processuale
della costruzione della sovranità europea, storicamente
inedita ma comprovata dagli sviluppi della sovranazionalità
nell’èra bipolare e nella «struttura
del mondo» che ad essa è seguita. Ciò
significa aver chiaro che l’integrazione europea
è stata condizionata dalla capacità di rispondere
a sfide interne ed esterne al vecchio continente, e tale
sarà anche nell’avvenire. A tal fine vorrei
segnalare le indicazioni che si ricavano, ad esempio,
dai contributi di Maurizio Fioravanti e Andrea Manzella:
se il primo riformula le domande poste da de Giovanni
analizzando il nesso fra Costituzione e unificazione politica
dell’Europa, il secondo individua anche i meccanismi
istituzionali e le risorse politiche contenuti nella Costituzione,
grazie ai quali gli attori del processo di unificazione
potranno fare passi avanti significativi e raggiungere
nuovi traguardi nella costruzione della sovranità
sovranazionale europea.
Il problema affrontato da Fioravanti è se il Trattato
costituzionale abbia prodotto «una forma politica
europea». La domanda riassume un annoso dibattito
originato dalla considerazione che, partorita necessariamente
da un Trattato, la Costituzione non potrebbe produrre
un tale risultato poiché risulterebbe una Costituzione
senza popolo e senza sovrano. Com’è noto,
la Costituzione approvata stabilisce che l’Unione
europea è una unione di Stati nazionali che restano
distinti al suo interno; dunque, non dà vita a
uno Stato federale. D’altro canto, essa è
fonte primaria di un diritto comune europeo sovraordinato
a quello dei singoli Stati che, sottoscrivendo il patto
costituzionale, gli conferiscono obbligatorietà
e lo muniscono di sanzioni. Essa dunque dà vita
a una forma politica che è ben più di una
Confederazione di Stati. Resta fermo che il «Trattato
per la Costituzione» non genera la figura di un
sovrano nel senso della tradizione costituzionalistica
europea. Tuttavia, nelle sfere di regolazione convenute
dagli Stati contraenti, esso dà forma a una sovranità
sovraordinata. D’altro canto, nota Fioravanti, la
possibilità di convocare nei singoli Stati referendum
popolari per confermarla, le fornisce un fondamento che
travalica la figura internazionalistica dei Trattati (i
soggetti dei quali non sono i popoli, ma gli Stati) e,
aggiungerei, favorisce il processo di costruzione di un
«popolo europeo ». Pertanto, Fioravanti conclude
la sua analisi con una proposta suggestiva: la «forma
politica» disegnata dalla Costituzione, egli sostiene,
è quella di «una Federazione fondata su un
contratto costituzionale che lega tra loro gli Stati membri
con i rispettivi popoli e le rispettive Costituzioni».
Richiamo l’attenzione sulle considerazioni che seguono,
le quali enfatizzano il metodo seguito da Fioravanti:
analizzare il processo di unificazione europea determinandone
storicamente le particolarità e sviluppando una
consapevolezza sempre più avvertita della storicità
delle categorie ereditate dal costituzionalismo e dalla
filosofia politica moderni. Solo in questo modo si può
dare forma concettuale al novum, quando esso si produce.
Sicché, persuasivamente Fioravanti conclude: «Il
fatto che tale Federazione non si esprima in forma statale,
ovvero nella forma storicamente nota dello Stato federale,
deve essere considerato prima di tutto come il segno di
un tempo nuovo, che non è condannato come quello
trascorso ad esprimersi necessariamente nelle forme statali
e sotto il dominio del principio di sovranità».
Prevedo l’obiezione che proprio questo proverebbe
come non basti il processo di costituzionalizzazione a
generare una unione politica compiuta. Si può rispondere
che la Costituzione attuale è sia un punto di arrivo,
sia il punto di partenza di un processo che continua e
potrà proseguire verso forme più estese
e approfondite di sovranità sovranazionale man
mano che i popoli europei risponderanno alle nuove sfide
interne e internazionali che l’Unione dovrà
affrontare. In altri termini, l’Unione europea non
potrà che continuare ad essere una costruzione
«incrementale», come è stata finora.
È difficile dare forma concettuale preventiva alla
«forma politica» che essa assumerà
in futuro, o prevedere se e quando potrà dirsi
compiuta. Fra l’altro, si corre il rischio di qualificare
formazioni storiche nuove con concetti ereditati da esperienze
storiche passate. Proverei piuttosto a tradurre l’analisi
di Fioravanti nel linguaggio politico comune. Sottolineare
che il «tempo nuovo» non ha bisogno di esprimersi
nelle forme statali tradizionali non significa rimuovere
il problema della nuova forma di sovranità che
del resto il processo di integrazione europea sta generando
da tempo. Forse comprendiamo meglio la «forma politica»
europea se nel processo avviato dal Trattato di Roma,
piuttosto che la cessione di quote più o meno ampie
di sovranità da parte degli Stati contraenti, ravvisiamo
un recupero di sovranità che altrimenti, nel mondo
bipolare prima, e in quello della «globalizzazione
asimmetrica» poi, i paesi europei sarebbero stati
condannati a perdere del tutto. Il «recupero»
avviene nell’unico modo possibile, cioè attraverso
l’elaborazione di una sovranità condivisa:
una nuova figura della sovranità, che nel linguaggio
corrente si usa definire sovranazionale. Finora il processo
è giunto alla Costituzione, ma ciò non è
poco: l’Unione europea comincia ad essere percepita
come un attore politico globale anche da chi – come
la Presidenza degli Stati Uniti – fino a pochi mesi
fa si rifiutava di farlo. I modi in cui la Costituzione
ne articola competenze e obiettivi sono attentamente studiati
nel Rapporto ed esaminati puntualmente nei loro limiti
e nelle loro potenzialità.
Ad approfondire queste ultime mi pare particolarmente
utile il saggio di Andrea Manzella. Egli sottolinea molto
opportunamente che il criterio stabilito dalla Costituzione
per delimitare gli ambiti di iniziativa degli Stati, degli
enti subnazionali e dei cittadini che fanno parte dell’Unione,
è quello teleologico. Se ci fosse bisogno di una
conferma del carattere processuale della «forma
politica» dell’Unione, l’indicazione
in Costituzione dei suoi obiettivi come criterio di legittimazione
dell’iniziativa dei suoi membri è di palmare
evidenza. Essa definisce il carattere dinamico e aperto
al futuro dell’unificazione prodotta dalla Costituzione.
La più importante prova di ciò, scrive Manzella,
è il modo in cui sono regolate le «cooperazioni
rafforzate» e le «cooperazioni strutturate»
che, sebbene debbano essere deliberate da tutti gli Stati
membri, tuttavia autorizzano raggruppamenti più
circoscritti di Stati i quali, al fine di realizzare obiettivi
previsti dalla Costituzione, decidano di dar vita a forme
di cooperazione più approfondite fra loro. Manzella
osserva che le «cooperazioni rafforzate» e
quelle «strutturate permanentemente » sono
quindi destinate a favorire coalizioni di avanguardia
fra gruppi di Stati membri con un inevitabile trascinamento
verso gli altri Stati che inizialmente non li seguano.
Se si pensa che l’Unione economica e monetaria (cioè
l’euro) è una «cooperazione rafforzata»
e una «cooperazione strutturata permanentemente»
è prevista dalla Costituzione per la politica di
sicurezza e di difesa comune – in cui Francia, Germania
e Gran Bretagna stanno muovendo i primi passi significativi
– non si possono sottovalutare gli elementi di sovranità
sovranazionale già sanciti dalla Costituzione.
Il criterio teleologico, dunque, è forse il più
importante per individuare, nell’impalcatura della
Costituzione, i punti nodali dell’unificazione politica
da essa originata, e il saggio di Manzella è molto
ricco e puntuale in tale esercizio. Ma, piuttosto che
riassumerlo, seguendo il filo dell’argomentazione
che sto svolgendo qui mi preme insistere sulla sua utilità
per fare chiarezza sui veri attori dell’unificazione
europea: non sono tanto gli Stati – sebbene siano
essi a scandire le tappe del «processo costituente»
– bensì i popoli. Questo risulta evidente
dall’ampliamento, dalla intensificazione e dalla
omogeneità della cittadinanza europea stabilita
dalla Costituzione; dalle garanzie e dall’attivazione
degli organi di governo dell’Unione per iniziativa
dei cittadini, al fine di promuovere l’attuazione
della Costituzione; dalla sintesi di democrazia rappresentativa
e democrazia partecipativa che essa opera. Onde il modello
sociale europeo si caratterizza per un intreccio di regolazione
economica e regolazione politica riassunte nella significativa
innovazione del concetto di vita democratica. È
difficile ignorare come tutto questo, insieme all’unificazione
delle competenze, al valore generale degli obiettivi indicati
dalla Costituzione e alla gerarchia delle fonti giuridiche
da essa stabilita, rispecchi e metta in forma un rilevante
progresso della società civile europea. In realtà,
è ad essa che la figura politica dell’Unione
va per gradi corrispondendo. La conclusione a cui giunge
anche Manzella, quindi, è che il «Trattato
per la Costituzione» dà vita a una forma
originale di Federazione che «sottrae il concetto
di Costituzione al vincolo della statalità e lo
consegna al fenomeno moderno della sovrastatalità».
Il suo approccio richiama, forse meglio di qualunque altro,
la processualità della costruzione europea: pensarla,
nel rispetto del suo svolgimento storico, riesce tanto
meglio quanto più teniamo fermo che il suo teatro,
prima ancora degli Stati e dei governi, è la società
civile. L’integrazione europea è il risultato,
mai del tutto compiuto, dell’iniziativa delle culture
politiche e degli interessi antagonistici che la percorrono.
Così si è sviluppata finora la ricerca europea
di una forma politica originale che traesse fuori il vecchio
continente dall’abisso in cui l’avevano precipitato
le due guerre mondiali, ed è prevedibile che così
continuerà a svilupparsi nell’avvenire. L’integrazione
europea non avrebbe potuto originarsi se, nella «struttura
del mondo» generata dalla Seconda guerra mondiale,
essa non si fosse basata sulla formazione di una «società
civile sovranazionale» e non avesse cercato di darle
veste politica. Forse è persino ovvio che questo
processo assuma le forme della sovrastatalità e
si dispieghi come un’«opera aperta».
|
|
|
 |
| |
| ©
copyright 1996, 2015
| FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI onlus |
cf 97024640589
|
| sede
legale, uffici amministrativi
|
ROMA VIA PORTUENSE 95c
|
tel. 0039 0683901670 fax 0039 0658157631 |
| segreteria,
archivi, biblioteca
|
ROMA VIA SEBINO 43a| tel. 0039 065806646 fax 0039 0658157631 |
|
|
|