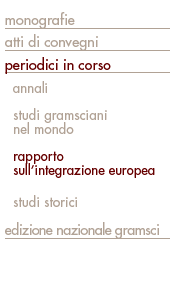|
 |

|
 |
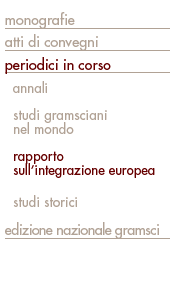

|
| <–
torna indietro |
Rapporto
2004 sull'integrazione
europea
della Fondazione Istituto Gramsci
IL DILEMMA EUROATLANTICO
a cura di Giuseppe Vacca
Dedalo, | Fondazione
Istituto Gramsci, Bari | Roma, 2004
p. 336, € 15,00
ISBN 88-220-6268-X |
 |
Presentazione
di Giuseppe Vacca
Presentando il primo Rapporto annuale della Fondazione
Istituto Gramsci
sull’integrazione europea, un anno fa, ne indicai
il principale obiettivo nell’intento
di offrire uno strumento di riflessione e di studio degli
avvenimenti che
ne scandiscono il processo, collocandoli in prospettiva
storica. Il 2003 è stato un
anno denso di eventi che hanno attraversato tutte e quattro
le aree di interesse del
Rapporto: le istituzioni (i lavori della Convenzione e
della conferenza intergovernativa);
l’economia (con particolare riferimento alla realizzazione
dell’allargamento);
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; la
politica estera e di difesa comune.
Quanto più significativi sono stati le novità
e talvolta i dilemmi incontrati nel
percorso, tanto più si è rivelato utile
inquadrare gli eventi nel medio periodo, collegandoli
alle vicende, ai progressi e ai problemi che l’Unione
europea ha vissuto
a datare dal 1991 (l’anno che, con la fine dell’Urss
e il Trattato di Maastricht, segnò
il suo «nuovo inizio»). Tale criterio risulta
ancora più efficace per il tema della
monografia, dedicata quest’anno al dilemma euroatlantico.
Già nell’autunno
del 2002 l’enunciazione della «dottrina Bush»
lasciava presagire che i principali
appuntamenti del 2003 sarebbero stati condizionati dal
coagularsi di una vera
e propria asimmetria fra l’unilateralismo dell’amministrazione
americana e il
multilateralismo dell’Unione europea: due modi diversi
e alternativi di intendere
il ruolo di attore globale dell’una e dell’altra
«potenza», le sfide della globalizzazione
e soprattutto le risposte da dare alla crisi della «globalizzazione
asimmetrica», cominciata nel 2000. Nel 2003 gli
sviluppi della vicenda irachena
hanno reso stridente quella asimmetria e provocato divisioni
e contrasti fra
i paesi europei che, se da un lato rendono più
chiari e distinti gli interessi e le
visioni che caratterizzano gli attori del processo di
integrazione – Stati, governi,
famiglie politiche, gruppi di interesse –, dall’altro
si annodano in un groviglio
che non sarà facile districare.
Nel tentativo di fare il punto sulle diverse strategie
che si sono confrontate sui
rapporti euroatlantici abbiamo avvertito l’esigenza
di ricostruire l’origine e lo sviluppo
delle più innovative: quella di Blair e soprattutto
quella di Bush. Se nel
primo caso è sufficiente la misura temporale dell’ultimo
decennio, per quanto
riguarda la destra americana è stato necessario
risalire agli anni Settanta del secolo passato: in particolare,
gli autori della monografia contenuta nel Rapporto
fanno risalire in buona misura l’origine della «dottrina
Bush» alla «nuova guerra
fred-da» di Reagan. A questa breve presentazione
non spetta il compito di riassumere
le analisi della politica internazionale degli Stati Uniti
da Nixon a G.W. Bush
contenute nella monografia. Giudicherà il lettore
se, come a me pare, esse siano
molto utili per intendere l’origine lontana e le
aporie attuali dell’unilateralismo
americano e il significato delle difficoltà incontrate
dall’Europa nel confrontarsi
con esso. Vorrei invece fermare l’attenzione su
alcuni luoghi comuni che caratterizzano
la percezione dell’uno e delle altre.
Il primo riguarda l’11 settembre: non avendo vissuto
quello shock sulla propria
pelle, si dice, gli europei non si renderebbero conto
delle nuove minacce rappresentate
dal terrorismo internazionale e per questo sarebbero contrari
alla teoria
della «guerra preventiva». È opportuno
ricordare che questa teoria non è nata
dopo l’11 settembre del 2001, ma dieci anni prima,
quando alcuni fra i più
influenti think tanks della destra americana cominciarono
a mettere a punto una
nuova strategia globale per gli Stati Uniti nel mondo
post-bipolare. In secondo
luogo, è bene tenere presente che la teoria della
«guerra preventiva» non è stata
assunta dall’amministrazione americana subito dopo
la distruzione delle due torri,
ma è diventata la «dottrina Bush» un
anno dopo; e fra il settembre 2001 e il settembre
2002 c’è di mezzo la catena degli iperbolici
scandali e crac che hanno travolto
alcuni colossi della finanza e dell’industria multinazionale
americana.
Inoltre, c’è stato un mutamento significativo
della politica economica dell’amministrazione
Bush. Infine, è utile ricordare che la risposta
iniziale americana all’11
settembre fu la costruzione della più ampia coalizione
internazionale che mai si
fosse vista prima, per muovere guerra all’Afghanistan
dei talebani; la guerra
all’Iraq, invece, è stata concepita, giustificata
e condotta fin dall’inizio in modo
unilaterale.
Sorge dunque il problema di ricostruire l’origine
della teoria della «guerra preventiva
»
e di inquadrarla negli svolgimenti della politica estera
americana dell’ultimo
trentennio: dalla crisi del blocco newdealista che portò
alla vittoria di
Reagan, fino all’elezione di G.W. Bush. Al notevole
scavo compiuto in questo
volume vorrei aggiungere qualche ulteriore tema di riflessione.
Ciò che colpisce
in questa strategia non è la definizione sempre
più unilaterale dell’interesse nazionale
americano. Certo, per la maggiore potenza mondiale questo
approccio segnala
una progressiva perdita di fiducia nelle proprie capacità
egemoniche; tuttavia,
potrebbe essere legittimo. Colpisce, invece, la definizione
dell’interesse nazionale
in termini di «sicurezza totale» che radicalizza
una visione posta già da Reagan a base del programma
di «guerre stellari», più volte fallito,
e ricorda le concezioni
della politica estera dei regimi totalitari europei degli
anni Trenta. Essa manifesta
un senso di ansia e di crescente insicurezza piuttosto
che, come si vorrebbe far
credere, di potenza. È sorprendente osservare come
gli Stati Uniti, protagonisti
dopo la Seconda guerra mondiale delle strategie politiche
e della costruzione
delle istituzioni sovranazionali che hanno favorito la
crescita dell’interdipendenza,
gli sviluppi della legalità internazionale e la
nascita di una sia pure inadeguata
governance mondiale, appaiano oggi così ostili
ad esse e ne provochino inopinate
lacerazioni. Inoltre, non vi è chi non veda come
questo modo di definire
l’interesse nazionale sia incompatibile con qualunque
idea di ordine mondiale
basato sulla legalità e capace di promuovere la
democrazia internazionale. Infine,
essa segna un ritorno alla concezione dell’inevitabilità
della guerra, e ciò evoca la
struttura del mondo dei primi quattro decenni del Novecento,
piuttosto che
quella dell’ultimo sessantennio.
Altrettanto aporetica è la percezione della minaccia
con cui la teoria della
«guerra preventiva»
si giustifica. Il terrorismo internazionale è certamente
una
minaccia inedita e globale (contro il genere umano, si
è detto dopo l’11 settembre,
replicando ai teorici del conflitto di civiltà).
Ma la percezione della minaccia
non coincide con l’identificazione del nemico. Innanzi
tutto, non si è riusciti
ancora a dare una definizione convincente e condivisa
del terrorismo internazionale,
e questo non dipende solo da difficoltà concettuali,
ma anche dalle divisioni
sedimentate nel pensiero strategico internazionale. Ma
soprattutto è bene avere
chiaro, come di recente ha ricordato Brezinzski, che il
terrorismo è un metodo di
guerra, non la figura di un nemico: è come se durante
la Seconda guerra mondiale,
egli ha aggiunto, avessimo considerato il nemico la Blitzkrieg
invece di
Hitler. La soluzione adottata dall’amministrazione
Bush appare dunque quanto
mai insoddisfacente: il nemico è individuato negli
«Stati canaglia», così definiti e
identificati, di volta in volta, in modo del tutto unilaterale.
A parte ogni altra considerazione,
può essere giusta una definizione del nemico non
vincolata al principio
di reciprocità? Per essere credibile una definizione
del nemico dovrebbe essere
sottoposta a quel principio (non posso definirti il mio
nemico se non è dimostrabile
che così tu definisci me); altrimenti appare fallace
e ingannevole, volta a
giustificare guerre di cui le ragioni vere non sono quelle
dichiarate. Altra cosa è la
giustificazione della guerra per «ingerenza umanitaria»,
che non sottostà al criterio
della reciprocità. Ma, non a caso, essa non è
classificabile come «guerra preventiva
»,
ed è giustificata dalla necessità, avvertita
dalle istituzioni sovranazionali, di ripristinare la legalità
internazionale violata: una realtà e un principio
che la
destra nazionalista americana sembra oggi disconoscere,
e che comunque ha apertamente
violato nella vicenda irachena e non solo.
Infine, ma non meno importante, nell’era atomica
una nozione della politica
basata sull’immagine del nemico è palesemente
anacronistica. Si potrebbe
obiettare che proprio l’era atomica è stata
caratterizzata dall’elevazione della coppia
amico-nemico a principio della politica mondiale: cos’altro
era il sistema della
guerra fredda se non un’organizzazione dicotomica
della politica mondiale basata
sull’immagine del nemico (comunismo contro capitalismo,
democrazia contro
totalitarismo, ecc.)? Ma, com’è noto, quella
era solo la rappresentazione condivisa
di una struttura del mondo consensualmente disciplinata
dalle due maggiori
potenze nella consapevolezza che il potere di distruzione
reciproca, di cui erano
entrambe dotate, ne condizionava la possibilità
di ricorrere alla guerra come prosecuzione
della politica con altri mezzi. I due nemici erano, in
realtà, i condomini
di un ordine mondiale sempre più interdipendente
e refrattario all’unilateralismo.
Detto in altri termini, entrambi i contendenti sapevano
che la guerra fredda
non era propriamente una guerra, poiché non poteva
essere vinta né dall’uno,
né dall’altro; e soprattutto, l’eventuale
«vincitore» non avrebbe potuto dettare le
sue condizioni al vinto perché si sarebbe trovato
a dover affrontare da solo i problemi
del mondo intero. Certo, anche la monografia che qui si
pubblica documenta
come fra la metà degli anni Settanta e i primi
anni Ottanta il sistema della
guerra fredda non fu più concepito in termini di
equilibrio: l’espansionismo sovietico
e la «nuova guerra fredda» di Reagan crearono
le premesse della sua fine, e la
definizione dell’Urss come «impero del male»
appare il vero antecedente della teoria
degli «Stati canaglia». Ma se, nella lunga
transizione post-bipolare, non si è
riusciti ancora a disegnare un nuovo ordine mondiale,
è realistico pensare di poterci
riuscire ricorrendo nuovamente al teorema di Von Clausewitz?
I temi a cui ho accennato non sono affrontati tutti nella
monografia. Ho voluto
farlo perché essi segnalano una novità impressionante:
con la «dottrina Bush»
la più grande democrazia del mondo propugna una
concezione delle relazioni
internazionali che contraddice i principi basilari della
democrazia. È una posizione
incommensurabile che tende a ridisegnare la figura della
destra internazionale
in modo inedito, regressivo e minaccioso. Per capire da
dove nasce e dove può
portare bisognerà «cercare ancora». |
|
|
 |
| |
| ©
copyright 1996, 2015
| FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI onlus |
cf 97024640589
|
| sede
legale, uffici amministrativi
|
ROMA VIA PORTUENSE 95c
|
tel. 0039 0683901670 fax 0039 0658157631 |
| segreteria,
archivi, biblioteca
|
ROMA VIA SEBINO 43a| tel. 0039 065806646 fax 0039 0658157631 |
|
|
|