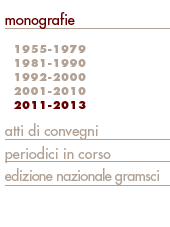|
Premessa
Gli scritti che qui si raccolgono in onore di
Biagio de Giovanni, pur
non volendo costituire un confronto diretto con tutte
le tematiche filosofiche
e politiche affrontate dal nostro maestro in alcuni
decenni di attività
culturale, sono, comunque, tutti in dialogo con tale
lunga e complessa
attività.
Il volume si apre con un gruppo di contributi che ricordano
e indagano
il magistero culturale e politico di De Giovanni o,
per usare categorie
che appartengono alla sua storia intellettuale, l’
oggettivarsi stesso della sua
“esperienza” nella ricerca e nella didattica.
Essi sono un omaggio al maestro
e un primo tentativo di ricostruire il suo lavoro. La
seconda parte è un
riconoscimento al De Giovanni “sconosciuto”
(o, almeno, meno noto): lo
studioso di storia dell’ arte. Attività
che egli, con qualche civetteria, giudica
la sua vera vocazione. La terza parte raccoglie scritti
che, percorrendo le
vicende della cultura moderna (dal Rinascimento a oggi),
di fatto si confrontano
con la sua ricerca teorica e con essa, a volte, si muovono
in “divergente
accordo”. In verità, è difficile
trovare un territorio della cultura filosoficopolitica
moderna che non sia stato toccato dal lavoro di Gino.
Lontana da
lui è l’ immagine dello studioso che dedica
la sua vita a un solo autore o
a un solo periodo storico. È questo uno dei tratti
più significativi del suo
lavoro: il non essersi mai chiuso in uno spazio culturale
limitato, ma l’ aver
percorso, tematizzato e analizzato la modernità
non per “lumi sparsi”, ma
“inseguendola” nella sua irriducibile multiformità.
Forse, l’ obiettivo della
sua ricerca è stato proprio questo: com-prendere
la complessità e la storicità
del moderno. Appunto: le forme e la storia del moderno.
Perciò, con la sua
ricerca ci si ritrova sempre a dover fare i conti.
Alcuni suoi allievi lo ricordano ancora, come docente
di Filosofia
morale, leggere e commentare i testi di Rousseau, di
Hegel e di Marx. Da
quelle lezioni sono nati i volumi su Hegel e il tempo
storico della società borghese
(1970) e La teoria politica delle classi nel “Capitale”
(1976). Scritti che,
li si voglia condividere o meno (ed egli stesso mostra
nei loro confronti qualche perplessità), hanno
segnato una stagione culturale. Ma, prima del
De Giovanni studioso di Hegel e Marx, v’ è
il De Giovanni studioso di
filosofia del diritto che offre ricerche, ancora oggi
additate come “classici”
dagli studiosi di quella disciplina. È il De
Giovanni autore di Fatto e valutazione
nella teoria del negozio giuridico (1958) e di La nullità
nella logica
del diritto (1964). E v’ è il De Giovanni
studioso del pensiero politico napoletano
(Filosofia e diritto in F. D’ Andrea del 1958
e La vita intellettuale a
Napoli fra la metà del Seicento e la restaurazione
del Regno del 1970). Da
questi lavori, al cui centro stanno sempre la figura
di Vico (De Giovanni
si è laureato discutendo una tesi su Vico) e
il tema dell’ esperienza culturale
nel suo farsi vita, mondo, nasce, forse, la sua passione
per la pittura del
Seicento (da Caravaggio a Salvator Rosa e a Luca Giordano),
quasi a voler
cogliere in essa l’ oggettivarsi stesso dello
spirito e della vita culturale del
tempo. L’ attenzione ai temi vichiani e le indagini
sullo storicismo tedesco
condotte in L’ esperienza come oggettivazione
(1962) non potevano che scaturire
da questa volontà di cogliere l’ esperienza
umana nel suo oggettivarsi
nella scienza e nella vita politica.
L’ interesse per Hegel e per il marxismo (Gramsci,
in particolare) non
viene meno negli anni ’80 del secolo scorso, ma
si complica e si ridisegna
entro un tentativo di rileggere la complessa e tortuosa
storia del mondo
moderno. Ed ecco, allora, emergere la necessità
non solo di ripensare le
origini del pensiero politico moderno (Machiavelli,
Bruno e, ancora, Vico),
ma anche le forme e le istituzioni della “democrazia
dei moderni”, le sue
ragioni costitutive, i suoi limiti, le sue fragilità.
Sotto la sua lente vengono
poste la storia e la cultura del comunismo (La nottola
di Minerva del 1989 e
Dopo il comunismo del 1990). Interventi teorico-politici
che, tuttavia, non lo
distraggono dall’ impegno nelle istituzioni universitarie.
È, infatti, dal 1987
al 1989 rettore dell’ Istituto Orientale di Napoli.
Eletto deputato al Parlamento europeo nel 1989 e riconfermato
nel
1994, diviene presidente della Commissione per gli affari
istituzionali.
Tuttavia, questo impegno politico non ne fa un uomo
“totus politicus”. Ad
essere indagate sono, ora, le ragioni del costituirsi
di un nuovo soggetto
politico: l’ Europa. Egli riesce a tenere in tensione
il suo lavoro istituzionale
con la sua attività di ricerca. L’ esperienza
diretta delle istituzioni europee gli
offre nuovo materiale per una rinnovata attenzione alle
teorie della democrazia
e delle costituzioni moderne. Perciò, una volta
ritornato all’ insegnamento
universitario, assumendo la cattedra “Jean Monnet”
sulla “Storia
dell’ integazione europea” presso l’
Istituto Orientale, è da quella esperienza
istituzionale che scaturiscono le riflessioni teoriche
contenute in L’ ambigua potenza dell’ Europa
(2002) e in La filosofia e l’ Europa moderna (2004),
quasi
a dimostrare, ancora una volta, che una “filosofia
rigorosa” non possa che
scaturire dall’ “esperienza”. Per
tornare, da ultimo, in A destra tutta (2009),
a interrogare la politica con quelle aspre e socratiche
domande che solo una
filosofia irriverente può formulare.
Sono queste, dunque, le coordinate entro cui si viene
svolgendo,
ancora oggi, un pensiero che non si acquieta e che incalza
gli amici e gli
allievi. Amici e allievi che quel pensiero – come
questo volume mostra –
non esitano a mettere in discussione, perché
esso stesso sollecita la discussione
e quasi esibisce i punti rimasti inesplorati, gli interrogativi
inevasi.
Perché, appunto, del maestro non è offrire
soluzioni ma mettersi in giuoco,
provocare discussioni e nuove ricerche. Per queste ragioni,
il volume non è
solo un omaggio al maestro ma a chi, ancora oggi, ci
pungola, mostrando
come nella ricerca non esistano scorciatoie e improvvise
intuizioni, ma solo
il rigore della filologia e la “fatica del concetto”.
Nello stesso tempo, questo
volume è testimonianza di quanto il suo magistero
e questo suo incalzarci
abbiano segnato tutti noi, anche se ognuno di noi ha,
poi, seguito il proprio
demone. |