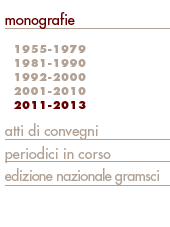Prefazione
di Luisa Mangoni
Militante e dirigente del Pci; membro del Comitato
Centrale e della Direzione
dal gennaio 1946 e, dal febbraio dello stesso anno,
responsabile per il
Mezzogiorno; eletto alla Costituente e da allora costantemente
presente nel
Parlamento italiano; ministro dell’Assistenza
postbellica e poi dei Lavori Pubblici
nel secondo e terzo governo De Gasperi; studioso e interprete
della storia
dell’agricoltura italiana, pensata come una delle
possibili strade per intendere
lo svolgersi della storia dell’Italia unita; convinto
assertore del ruolo dell’Urss
come guida del movimento comunista internazionale e
conseguentemente
strenuo difensore del suo primato culturale; occhiuto
e aggressivo responsabile,
dal gennaio 1948 all’aprile 1951, della Commissione
culturale del Pci e intensamente impegnato negli stessi
anni a promuovere in Italia il movimento dei
Partigiani della pace, Emilio Sereni sembra impersonare
una condizione politica
e culturale che non lo differenzia da gran parte della
classe dirigente comunista
italiana di quegli anni, se non forse nei termini estremi
in cui in lui si manifestava.
Ma un altro elemento potrebbe contraddistinguerlo: la
lucida consapevolezza
di cosa l’intreccio di tutti questi elementi significasse.
Il 2 marzo
1949, nel replicare ai dubbi della casa editrice Einaudi
circa la pubblicazione di
una sua raccolta di saggi, Scienza marxismo cultura,
testi in cui si rifletteva proprio
la sua attività di responsabile della Commissione
culturale e che toccavano
i più vari argomenti, Sereni sottolineava la
esplicita «intenzione» e l’implicito
«giudizio sulla cultura» che la raccolta
da lui proposta implicava. Una intenzione e un giudizio
che intendevano avere l’effetto di un «pugno
nello stomaco».
Era peraltro lo stesso Sereni che pochi mesi dopo, il
19 gennaio 1950, nell’accettare la proposta di
scrivere, per la Piccola Biblioteca Scientifico-letteraria,
sempre di Einaudi, una storia dell’agricoltura,
ricordava il suo impegno da anni
per un volume, Città e campagna nell’Italia
antica, incentrato soprattutto sulla Liguria preromana,
costruito su materiali «storici, linguistici,
archeologici, epigrafici
», e quanto questo lavoro di ricerca avesse implicato
per lui ripensamenti di
quella storia dell’agricoltura italiana, in epoche
più recenti, che negli ultimi 15-
20 anni aveva accompagnato ed era stata parte integrante
del suo lavoro politico.
Nel titolo che Sereni proponeva per il libro richiestogli,
Breve storia dell’agricoltura
e dei contadini d’Italia, si innestavano inoltre
anche le ricerche di «materiale
filologico o folcloristico» che era andato svolgendo
sui canti popolari, riletti
pionieristicamente come «fonte di storia»:
«si tratta di una storia del popolo italiano (dell’Italiano
Qualunque) nei suoi canti. Si tratta di mostrare in
maniera viva che l’Italiano Qualunque non è
un Uomo Qualunque, che è un uomo che non
è stato solo oppresso e sfruttato, che non ha
detto soltanto “Franza o Spagna purché
se magna”, ma ha lottato e combattuto».
Era, ancora, il Sereni che nell’ottobre 1951 offriva
infine il suo Comunità rurali dell’Italia
antica, opera di «ricerca erudita» che gli
stava particolarmente a cuore, sottolineandone ancora
una volta il legame, non solo «soggettivo e personale»,
con la Breve storia dell’agricoltura.
Filoni che venivano quasi naturalmente a congiungersi
nel famoso volume
sul paesaggio agrario, che Einaudi avrebbe dovuto pubblicare
nel 1955 e che sarebbe apparso solo nel 1961 per i tipi
di Laterza. In esso si presupponeva il riferimento a
Les caractères originaux de l’histoire
rurale française di Marc Bloch
e si rileggeva il paesaggio agrario come prodotto dell’uomo,
svolgimento delle
forme antiche dovuto all’azione operosa di quei
contadini italiani di cui Sereni
avrebbe voluto comporre le molteplici storie: ancora
il filo unitario che connetteva
la sua riflessione di storico e, insieme, una delle
intime matrici di una ormai
trentennale scelta politica.
Sono questi i lineamenti compositi che questa scelta
di lettere intende mettere
in evidenza, sia pure necessariamente per rapidi scorci.
Quello che si propone al lettore non è solo un
significativo contributo alla
valorizzazione dell’imponente patrimonio documentario
custodito dalla Fondazione
Gramsci. È anche il presentare, senza reticenze,
una figura che, nella già complessa genealogia
del Partito comunista, per le sue peculiari contraddizioni
ha spesso destato un senso di disagio. Un invito alla
riflessione sul passato,
accompagnato dalla implicita considerazione che non
si possono selezionare
a ritroso i propri ascendenti né occultare parti
della propria storia: ancor più
che opportuno, è doveroso comprenderne le vicende
in quello che ebbero di
comune e in ciò che fu proprio ad ognuno di essi.
La selezione delle lettere, su un arco cronologico che
va dal 1945 al 1956,
almeno nel termine a quo rispecchia comunque i limiti
del materiale documentario
conservato al Gramsci. Sono state però inserite
alla fine alcune lettere personali
che, pur risalenti a quegli stessi anni, impongono di
spingere lo sguardo
più indietro nel tempo.
Il 1° novembre 1945, alla madre e alla sorella in
Palestina, Sereni scriveva a
proposito della morte del fratello Enzo: «qualcosa,
davvero, si è rotto dentro,
non un’altra cosa, ma tutta una parte di me stesso
[…]. Si è rotta tutta la mia
vita, si è rotta come la mia gioventù».
Tuttavia c’era stata un’altra rottura che
nel settembre 1928 aveva diviso irreparabilmente la
storia dei due fratelli, quando
Emilio Sereni, nel comunicare a Enzo la sua decisione
definitiva di non raggiungerlo più in Palestina,
aveva usato, sia pure tra virgolette, un vocabolo rivelatore:
«Naturalmente, anche a me dispiace molto il non
poter più collaborare
con te, e l’averti dovuto “tradire”
in quelli che erano i nostri comuni piani».
La scelta per il comunismo, il distacco dal sionismo
facevano venir meno già
allora quell’unità di intenti cementata
da una sorta di simbiosi che andava oltre
l’essere fratelli.
Le due precedenti lettere di Enzo Sereni, dell’8
dicembre 1927 e del 4 febbraio
1928, le ultime di questo scambio, erano firmate non
con il familiare Enzo
o Chaim, ma per intero «Enzo Sereni». La
lettera di Emilio del 4 settembre
1928, quella in cui comunicava la sua scelta definitiva,
era firmata invece
Uriel Sereni, e il nome, prescelto al tempo dell’opzione
comune con il fratello
per il sionismo attivo, e il cognome sembravano elidersi
a vicenda, a confermare
un’immagine ormai dimidiata che lo stesso Emilio
Sereni doveva avere
di sé.
A questa lettera Enzo Sereni non rispose, ma se si vuole,
una risposta si trova
altrove. Nel 1931 in una delle sue corrispondenze dalla
Germania, Enzo Sereni
descriveva il quadro per lui desolante di una presenza
ebraica, diffusa ormai
in ogni strato della società, la cui assimilazione
era avvenuta al prezzo «dell’annullamento
delle qualità interiori»: «ebrei
in dissolvimento» nella cui vita
gli sembrava di cogliere tutto «il sapore amaro
della diaspora». E ripensando
agli anni dell’immediato dopoguerra, alla stagione
«eroica» del sionismo in
Germania, si soffermava su quei «perpetui cercatori»
che dal sionismo erano
passati al comunismo, sostituendo «- ad usum temporis
– il pathos rivoluzionario
vero del sionismo, che consiste nella formazione di
un nuovo ebreo, con
le scorie postbelliche, pseudomessianiche»: una
«assimilazione rossa», dunque,
che si era rivelata uno degli ostacoli più insidiosi
per il sionismo stesso, col creare
in molti «l’impressione che il sionismo
non possegga pathos rivoluzionario
e creatore in genere».
Difficile pensare che dietro queste parole non si proiettasse
l’ombra di
un’altra stagione, quella del sionismo italiano
tra il 1924 e il 1928, e della appassionata discussione
epistolare che lo aveva visto confrontarsi con il fratello
Emilio. La scelta per il sionismo militante era stata
allora una scelta «per non
morire», fondata sulla radicale convinzione che
fuori dalla Palestina non ci fosse
«salvezza per la vita ebraica». L’abbandono
di quella opzione che per sette
anni aveva segnato la vita e le scelte dei fratelli
Sereni, non poteva che avvenire,
come sembra aver colto Enzo Sereni nel 1931, in nome
di un analogo «pathos
rivoluzionario» e messianico: quello che Emilio
Sereni rivolse al comunismo
con uno spirito di totale sacrificio, la cui portata
può essere colta solo dalla
tragica testimonianza rappresentata dalle memorie postume
della moglie.
Verrebbe da aggiungere che l’identificazione con
la nuova causa doveva essere
tanto più totale quanto più il sottinteso
del «tradimento» del progetto in comune
col fratello lo imponeva; e imponeva, si vorrebbe dire,
la quasi impossibilità
di mettere in discussione ciò che, se si fosse
rivelato errato, avrebbe reso quel
tradimento insopportabile per chi lo aveva consapevolmente
compiuto. E del resto,
quando ancora era l’altra metà di Emilio,
Enzo aveva osservato che il suo
«ortodossismo» gli sembrava «una “precauzione
contro se stesso” che è ottima
cosa per il peccatore convertito che, raggiunta una
volta la verità pone “siepi intorno alla
legge” per non correre il pericolo di ricadere
in tentazione». E vale
la pena ricordare la lettera, immediatamente successiva
alla liberazione dal carcere, indirizzata da Emilio
Sereni alla cognata Ada. Vi si può cogliere,
anche se
sembra strano a dirsi, quasi un senso di leggerezza,
come se il prezzo che egli
stava pagando per la sua scelta comunista la autenticasse:
non una diserzione la
sua, ma una lotta diversa in nome di una scelta che
comportava costi altrettanto
alti, addirittura più alti e imprevisti.
La diffidenza e la delazione di compagni di partito
dovuta anche a rapporti
familiari di Sereni, come quello con Eugenio Colorni
e soprattutto con la suocera
Xenia Silberberg, con le conseguenze di rischio personale
e di isolamento
e condanna fu certo una esperienza sconvolgente: investiva
fra l’altro proprio
la persona che lo aveva particolarmente attratto e suggestionato,
come egli stesso
avrebbe riconosciuto nel 1957 alla morte di Xenia Silberberg.
Pur con qualche
residua riserva, Emilio Sereni ammetteva di doverle
«una influenza decisiva
e risolutiva a tutto l’orientamento della mia
vita», avendolo avvicinato
a quello che Lenin chiamava «lo slancio romantico
del rivoluzionario russo», e al
quale egli giustamente attribuiva un’importanza
così decisiva nella funzione d’avanguardia
del Partito bolscevico. Per me, allora, ed a tutt’oggi,
la mamma di Xenia fu come
l’incarnazione vivente di questo «slancio
romantico del rivoluzionario russo»:
Accettare e superare queste vicende, ancora in parte
da indagare16, che tanto
improntarono le ragioni stesse della sua militanza,
fu per Sereni un’esperienza
forse ancor più drammatica e dolorosa dell’arresto
da parte dei fascisti nel
giugno del 1943, della tortura, della condanna a morte.
Vanno rilette con attenzione, a questo proposito, le
pagine della introduzione di David Bidussa alle lettere
fra Enzo ed Emilio Sereni, in particolare l’analisi
colma di implicazioni che
egli propone dell’intervento di Sereni su «Paese
Sera» a proposito del film di
Citto Maselli, Il sospetto. Sereni aveva scritto il
15 marzo 1975:
Chi ha vissuto in quella illegalità non esiterà,
d’altronde, a riconoscere, nel film di
Maselli, l’assenza di ogni esagerazione o deformazione
in proposito. Ed i criteri di stretta funzionalità
ed essenzialità espressiva che caratterizzano
quest’opera valgono a sottolinearne – insieme
con la validità artistica – il notevole
valore documentario.
Bidussa commenta:
L’eroismo è scomparso e rimane solo la
dimensione del sospetto […]. Se il film è
ambientato nel 1934 è probabile invece che Sereni
lo abbia mentalmente collocato nel 1938, quando anch’egli
si è trovato sospettato in una rete che allora
gli sembrava plausibile e che ora si domanda se ne valeva
o meno la pena.
Nello stesso anno, il 13 maggio 1975, Einaudi scrisse
a Sereni:
La memorialistica comunista sta mostrando la ricchezza
e il valore di molte testimonianze personali su fatti
e avvenimenti ormai «storici» e tuttavia
ancora operanti attraverso conseguenze e sviluppi successivi.
Sono certo che tu pure avresti molto da dire, non tanto
per arricchire un’aneddotica interessante, ma
di scarso significato, quanto per dare un contributo
alla conoscenza del passato, che non può essere
consegnato, per troppe ragioni agli archivi. Vuoi riflettere
su questa tua possibilità di «memorialista
» e dirmi che cosa ne pensi?.
Non mi risulta una risposta. Forse Sereni stesso avrebbe
avuto qualche difficoltà,
negli ultimi anni di solitudine e amarezza, a ricomporre
una memoria
unitaria del suo frastagliato passato.
|