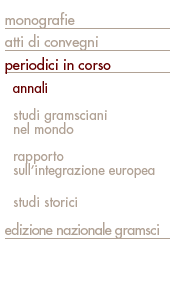|

|

|
 |
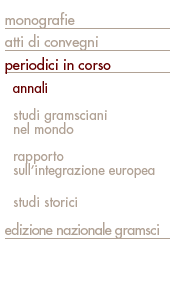

|
| <–
torna
indietro
|
ANNALE
XVII
Luigi
Squarzina. Il teatro e la storia
a cura di Elio Testoni
Roma,
Carocci, 2012
pp. 331, 2 €
34,00
ISBN 978-88-430-6658-2 |
 |
Introduzione
di Elio Testoni
Luigi Squarzina (1922-2010) è stato
drammaturgo e regista di teatro di prosa e di teatro lirico,
regista televisivo e radiofonico, autore di radiodrammi
e di originali televisivi, di poesie e di racconti, di
articoli e di saggi sul teatro, curatore di traduzioni
e di adattamenti e docente uni¬versitario, direttore
di strutture teatrali private e di stabili pubblici e
libero professionista1.
La molteplicità delle attività e la pluridirezionalità
dei suoi interessi sono state alimentate dalla costante
esigenza di una profonda integra¬zione tra la regia,
la scrittura drammaturgica e lo studio, tra la riflessione
critica e l’insegnamento sulle tematiche e sugli
autori messi in scena, tra la storia e la teoria teatrale
e la sua pratica di palcoscenico.
La felice combinazione di «competenze e attitudini
malauguratamente divise negli altri studiosi o registi
o scrittori o storici del teatro» fa di Squarzina
«un caso unico ed eccezionale» nella storia
del teatro nazionale.
La selezione degli scritti di Squarzina proposti nel volume
ha pertanto seguito il criterio della periodizzazione
che consente di definire le connotazioni fondamentali
delle diverse fasi e delle diverse forme della molteplicità
delle sue dimensioni intellettuali, di cui gli scritti
sono espressione.
La prima fase, che va grosso modo dal 1941-42 al 1951-52,
è connotata da un forte impegno letterario, dalla
formazione professionale nell’Accademia d’arte
drammatica, dal successivo apprendimento del mestiere
sul campo, dalla prima scrittura drammaturgica e dall’“esperienza
americana”.
E proprio il primitivo grande interesse letterario può
essere considerato premessa non secondaria all’acquisita
“dimensione culturale”3 della produzione del
“regista professore”4.
Il giovane Squarzina, tra i diciassette e ventun’anni,
scrive poesie che sono già d’autore, musicali
ed eleganti nel verso, espressioni di una maturità
creativa e di una serietà di impegno confermate
dalle sue riflessioni sulla poetica, sulla drammaturgia
e sulla filosofia dei grandi autori e dalle sue specifiche
considerazioni sulla poesia, corredate da esemplificazioni
e confronti nell’ambito della storia della letteratura
italiana, presenti negli appunti diaristici di quel periodo.
Dunque il far poesia è un momento significativo
della vita di Squarzina, perché gli consente di
fissare in immagini poetiche le sue sensazioni, le sue
emozioni, le sue riflessioni, non altrimenti esprimibili,
nel clima di grande tragedia della Seconda guerra mondiale.
E la poesia, per Squarzina, ha una sua dimensione autonoma,
una sua costanza temporale, quattro-cinque anni, e protrae
la sua risonanza nel tempo a venire. Nella messinscena
di Detective story, nel 1951, egli fa recitare a Albertazzi
i versi di Walt Whitman, da lui tradotti circa dieci anni
prima; nel suo Tre quarti di luna, rappresentato nel 1953,
i giovani protagonisti, Elisa e Mauro, recitano due poesie.
Egli stesso ritorna, talvolta, a scrivere poesie negli
anni Sessanta e perfino negli anni Novanta. Perciò
nel volume sono proposte due delle trenta poesie, tutte
inedite, che, oltre all’amore, toccano tematiche
esistenziali e sociali, filoni che avrebbero poi connotato
tutta la sua produzione. Le poesie scelte sono Liturgia
al tramonto, scritta nel 1942, e A Iuna, composta nel
1943. La prima è una riflessione poetica sulla
condizione umana, sulla precarietà e sull’ansia
del vivere cui fa da contrappunto la placidità
della natura nell’alternarsi delle stagioni, da
cui il bisogno dell’uomo di serenità e di
amore. La seconda è una poesia d’amore, di
struggente nostalgia per un amore “remoto”
che il tempo e la lontananza portano via senza cancellare;
qui i paesaggi, le cose e i luoghi scorrono e si confondono
con gli stati d’animo del poeta.
L’interesse per la poesia è integrato e seguito
da quello per la narrativa, che per qualche anno si affianca
all’impegno scolastico in Accademia e ai primi esercizi
registici. D’altra parte la scrittura di racconti,
come Squarzina stesso ha dichiarato, significava per lui
sentirsi libero e poter contrapporre alla realtà
della guerra e all’esperienza esterna, che i suoi
amici Gassman e Salce stavano vivendo perché chiamati
alle armi, una propria esperienza interiore che egli si
convinceva a considerare equivalente. Per altro verso
la scrittura di racconti, a volte solo come appunti, gli
consentiva di verificare le sue possibilità di
tradurre in una forma letteraria dignitosa il suo bagaglio
culturale e il suo vissuto, così come le sue prime
regie degli anni Quaranta gli permettevano di testare
il suo apprendimento scolastico in Accademia e la sua
sensibilità artistica. La fase letteraria si intrecciava
significativamente con la successiva dimensione drammaturgica
e registica.
Di questa complementarietà sono espressioni il
racconto Zim, scritto tra la fine del 1944 e l’inizio
del 1945, e Quelli a cui importa, composto tra il 1946
e il 1947 e classificato al secondo posto al Premio Riccione
per il Teatro 1947. Quest’ultimo lavoro, in cui
ancora una volta Squarzina manifesta la sua predilezione
per la poesia recitata da uno dei personaggi, segna la
ormai acquisita coscienza politica, raccontando di uomini
che, ideologicamente e politicamente confusi, progettano
un velleitaristico generale rinnovamento spirituale che
impone innanzi tutto l’assassinio dell’«uomo
con gli occhiali». Straordinaria preveggenza di
artista perché l’«uomo con gli occhiali»
altri non era che Togliatti il quale, l’anno dopo,
nel luglio 1948, fu vittima di un grave attentato. Quelli
a cui importa già si coniuga con il teatro squarziniano:
diventa infatti un radiodramma trasmesso il 26 ottobre
1960 dal Terzo Programma della rai con il titolo Vicino
è difficile, diretto dall’autore.
Zim, invece, non è mai stato pubblicato finora
e nel 1998 ha vinto il premio letterario Arcangela Todaro-Faranda
per la narrativa inedita. Lo proponiamo in questo volume:
è il primo racconto lungo di Squarzina e si apparenta
al neorealismo, traendo ispirazione da un fatto tragico
realmente accaduto che coinvolse lo stesso autore. C’è
una grande attenzione per la dimensione sociale e politica
sia nella struttura narrativa, che pone in primo piano
personaggi socialmente ed economicamente emarginati in
una Roma “città aperta”, sia nell’ambientazione
– che presenta due squallide stanze, senza luce,
senza mobili, con brande e materassi per terra e topi
in circolazione –, sia ancora nella configurazione
dei personaggi, fragili, impotenti, nevrotici, frustrati,
del tutto privi di aspettative, tranne Mina, che si aspetta
una vita migliore quando il suo compagno impegnato nella
Resistenza ritornerà da lei.
Il protagonista Zim era nella realtà Zimmer Traldi,
un amico di Squarzina che lavorava nel cinema. Una sera
di luglio del 1944 morì cadendo da una finestra
della casa in cui Squarzina, insieme con i suoi amici
dell’Accademia, stava festeggiando il successo del
suo saggio di regia Uomini e topi. Nella realtà
la dinamica dell’evento non fu mai accertata, ma
Squarzina, che rimase fortemente scosso, immagina che
si fosse trattato di omicidio e che a uccidere Zimmer
fosse stato un suo amico, anch’egli ospite alla
festa, che a sua volta, nel racconto, viene ucciso allo
stesso modo, buttato giù dalla finestra dalle amiche
di Zim. La cruenta soluzione finale è l’acme
di un crescendo narrativo condotto con un ritmo incalzante,
almeno a partire dall’indagine dei tre amici, e
con un linguaggio asciutto, essenziale.
Anche questo racconto ha agganci precisi con il teatro
di Squarzina. A parte il quadro reale d’ispirazione
– la festa per una messinscena teatrale –,
la struttura compositiva di Zim presenta analogie con
quella del primo lavoro teatrale di Squarzina rappresentato,
Tre quarti di luna: in entrambi c’è un “protagonista
occulto” – Zim nel racconto, Enrico nella
commedia – e in entrambi a un certo punto scatta
un meccanismo di indagine poliziesca a opera di amici
o di congiunti del protagonista occulto.
I racconti brevi, invece, presentano un loro interesse
per la vena di fantasia, la maturità narrativa
e lo stile. Si va dall’incompleto Marco Riordi,
che rievoca le esperienze forlivesi e quelle liceali a
Roma in una forma letteraria elegante e garbata, a Clara,
in cui sono descritti con sottile ironia gli stati d’animo
di un giovane che, abbandonato dalla sua compagna, passa
dalla disperazione all’indifferenza nel giro di
dodici ore; da Il cercatore di targhe, anch’esso
fortemente ironico, a La venditrice.
Quest’ultimo, inedito, è stato inserito nella
raccolta di scritti presenti in questo volume. La venditrice
è il più interessante dei racconti brevi
squarziniani perché, scritto nel periodo delle
sue esercitazioni registiche, esprime pienamente, in forma
letteraria, il conflitto in atto tra la generazione dei
giovani registi, di cui Squarzina fa parte, e gli attardati
nelle vecchie consuetudini teatrali, tra coloro che si
battono per il rinnovamento del teatro italiano e quelli
che ne vogliono conservare il modello.
Tutto questo riflette l’incontro-scontro tra il
giovane scrittore senza nome che vuole far pubblicare
il suo racconto e l’anziano affermato scrittore
Barzilai che lo respinge con pretestuose motivazioni.
Ma nella Venditrice c’è anche un riferimento
preciso all’amato Ibsen, di cui il giovane senza
nome difende la poetica mentre Barzilai lo considera un
drammaturgo superato; è questo un aggancio diretto
e attuale con il teatro di Squarzina, che proprio in quel
periodo del drammaturgo norvegese metteva in scena, con
la compagnia Ricci, Un nemico del popolo al Carignano
di Torino, il 16 novembre 1948, e Il costruttore Solness,
al Teatro Nuovo di Milano il 21 gennaio 1949.
E proprio su Ibsen si sofferma il saggio di Squarzina,
che qui ripubblichiamo, già edito da ultimo nel
1988 con il titolo Attualità di Ibsen nel volume
Da Dioniso a Brecht. Il saggio ha una rilevanza particolare
perché Ibsen, in un primo periodo, è stato
fondamentale per la cultura teatrale e per la formazione
professionale di Squarzina. Già nei suoi appunti
giovanili dei primi anni Quaranta, ne lodava senza riserve
la drammaturgia; successivamente, negli anni Cinquanta,
nella redazione della voce Drammaturgia per l’Enciclopedia
dello Spettacolo definiva Ibsen il più grande drammaturgo
dell’Ottocento, e al norvegese sembra essersi ispirato
per l’adozione di una metodologia analitica nella
messinscena di Detective Story, nella costruzione della
scena e nella struttura compositiva di La sua parte di
storia e nella configurazione di alcuni aspetti del preside
Piana in Tre quarti di luna ... |
|
|
 |
| |
| ©
copyright 1996, 2015
| FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI onlus |
cf 97024640589
|
| sede
legale, uffici amministrativi
|
ROMA VIA PORTUENSE 95c
|
tel. 0039 0683901670 fax 0039 0658157631 |
| segreteria,
archivi, biblioteca
|
ROMA VIA SEBINO 43a| tel. 0039 065806646 fax 0039 0658157631 |
|
|