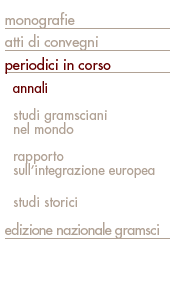Nota
ai testi
di Maria Luisa Righi
I documenti qui pubblicati fanno parte della serie verbali
della direzione comunista (1944 e seguenti) consultabili
in copia presso la Fondazione Istituto Gramsci, che
è depositaria degli archivi del Pci anche per
il periodo precedente. La decisione dell’allora
partito comunista di aprire i propri archivi alla consultazione
degli studiosi fu resa pubblica nel marzo del 1988 nel
corso di una conferenza stampa alla quale parteciparono
Giuseppe Chiarante a nome della direzione del Pci, Giuseppe
Vacca per la Fondazione Istituto Gramsci e Gastone Gensini
responsabile degli archivi della direzione, accompagnati
da Paolo Spriano, Giuseppe Boffa e Valentino Gerratana.
Sebbene la scelta fosse stata assunta dal Pci già
due anni prima, trascorse tempo perché si formalizzassero
i termini per la consultazione e la decisione diventasse
operativa. Venne stabilito di rendere consultabili presso
la Fondazione Istituto Gramsci innanzitutto i verbali
della direzione dal 1944 in poi, quando fossero trascorsi
trent’anni dalla produzione della documentazione
a differenza dei quarant’anni previsti dalla norma
che regola i versamenti delle carte del l’amministrazione
statale all’Archivio di Stato. Di conseguenza
al momento i verbali di direzione sono consultabili
sino al 1961.
I nuovi versamenti si aggiungevano ad altri consistenti
fondi riguardanti il Pci nel dopoguerra (congressi,
conferenze di organizzazione, consigli nazionali dal
1943 al 1990, materiale delle federazioni e dei comitati
regionali, commissione culturale, e carte di singoli
dirigenti) già presenti negli archivi dell’Istituto
e liberamente consultabili. Successivamente l’archivio
della direzione del Pci, poi Pds, ha provveduto a inviare,
in base a specifiche richieste dei ricercatori, anche
i verbali delle riunioni del Comitato centrale 1946-48,
del gruppo parlamentare 1945-48, nonché materiale
vario relativo a: ufficio organizzazione 1946-48; scuole
di partito e ufficio quadri 1944-56; commissione agraria
1945-54; ufficio editoriale («l’Unità»,
«Vie Nuove») 1946
Contemporaneamente all’inizio del versamento,
sulla rivista «Critica marxista» (1988,
n. 3-4) venne pubblicata una prima selezione dei verbali
relativa agli anni 1944 e dal 1988 a oggi i verbali
sono stati consultati e utilizzati da numerosi studiosi.
In seguito una parte dei verbali, insieme ad altro materiale
documentario, fu pubblicata su «l’Unità»
a cura di Aldo Agosti. Nel presentare quella scelta
di inediti, Giuseppe Vacca annunciava anche la pubblicazione
della «raccolta completa dei documenti inediti
della direzione del Pci dal V al VI Congresso»
negli «Annali» 1990 che vedono oggi la luce
L’ordine attuale dei verbali della direzione presso
la Fondazione Istituto Gramsci è il seguente:
fascicoli contenenti il materiale relativo a un singolo
anno; sottofascicoli dedicati ai verbali relativi a
ciascuna riunione di direzione o, in alcuni casi, a
singole sedute di riunioni organizzate in più
giornate. Tutti i documenti presentano un numero d’ordine
progressivo per anno. Va precisato che questa non è
la collocazione fisica che gli originali hanno nell’archivio
del Pci conservato presso la direzione del Pds; collocazione
che riflette la peculiare storia di quell’archivio.
Come è noto, le carte d’archivio del Pci
per il periodo del dopoguerra (compresi i verbali della
direzione) erano in parte state inviate presso l’Istituto
del marxismo-leninismo di Mosca, mentre la parte più
consistente in termini di volume, era rimasta nella
sede nazionale. Solo alla fine degli anni sessanta,
presso l’archivio del Pci, diretto allora e fino
al 1981 da Giovanni Aglietto, si provvide a un riordino
e a una sistemazione generale delle carte, predisponendo
una classificazione per l’archiviazione del materiale
corrente e per il recupero di quello storico, analoga
al sistema di codificazione decimale Dewey, applicata
alla struttura organizzativa stabilita dallo statuto
del partito. Inoltre, grazie a una serie di apparati
documentari si cercò di ridefinire l’organizzazione
dell’archivio di segreteria e, attraverso ricostruzioni
più propriamente storiche (specialmente per il
calendario delle riunioni e per la composizione degli
organismi dirigenti), anche di impostare il lavoro di
recupero e di integrazione del materiale documentario.
Si provvide inoltre al recupero del materiale depositato
a Mosca (questo, infatti, rimaneva di proprietà
esclusiva del Partito comunista italiano ed era soggetto
all’autorizzazione della segreteria del Pci),
prima in copie su microfilm e successivamente in originale.
Venne mantenuta pertanto la disposizione assunta dalle
carte nei depositi sovietici, provvedendo al contempo
alla loro inventariazione come per l’archivio
corrente Nell’inviare la documentazione all’Istituto
Gramsci, l’archivio della direzione del Pci, e
oggi del Pds, ha tenuto conto dell’ordinamento
assunto nella classificazione e non della collocazione
fisica degli originali, ritenuta, per i motivi suesposti,
scarsamente significativa.
La precisazione ci è parsa importante per due
ordini di motivi: il primo relativo all’individuazione
(e quindi all’eventuale consultazione) dei singoli
documenti; il secondo relativo alla documentazione presente
in allegato.
Il primo aspetto riguarda il numero d’ordine assunto
dai documenti nella collocazione presso gli archivi
della Fondazione Istituto Gramsci. Questo numero, che
è indicato nella nota introduttiva ad ogni verbale,
rappresenta, come si è detto, il numero del sottofascicolo
all’interno dell’anno ed è quello
che individua il documento. Non si fornisce invece l’indicazione
del numero di fascicolo/microfilm, che rappresenta l’ordinamento
fisico delle carte nel fondo Pci presso l’archivio
del Pds, e che alcuni studiosi hanno citato in pubblicazioni
precedenti la presente, poiché tale numero oltre
a essere irrilevante per la consultazione del materiale,
non pare indicare un qualche criterio significativo
di suddivisione. Comunque gran parte dei verbali (sia
del 1946 che del 1947) proviene da un unico fascicolo
(il Mf 272) e solo pochissimi da un altro più
piccolo (il Mf 213).
Per quanto riguarda gli allegati il lettore deve essere
avvertito delle difficoltà di individuare quanto
era in modo certo originariamente allegato ai singoli
verbali (cioè, quanto fu effettivamente letto
e discusso nel corso delle riunioni) da quanto fu aggregato
successivamente con un criterio tematico. A volte gli
allegati originali, espressamente richiamati nei verbali,
sono andati dispersi; altre volte si trovano allegati
prodotti posteriormente (è il caso di alcune
risoluzioni, che pur essendo approvate nel corso di
determinate riunioni sono allegate a verbali precedenti,
in base al criterio dell’oggetto di discussione
e non della loro formale approvazione). In questo volume
pubblichiamo integralmente i verbali e i relativi allegati
così come si presentano, segnalando in nota se
la documentazione richiamata nel testo è assente,
e se quella presente appare incoerente.
Le uniche eccezioni a questo criterio riguardano la
discussione sul risultato amministrativo del 1946 e
un fascicolo denominato Apc, Verbali della direzione,
«Allegati 1947».
Nel primo caso (per il quale si vedano le note introduttive
alle riunioni del 9-10 e 14 aprile 1946) l’eccezione
è duplice. Poiché sono presenti due copie
della stessa risoluzione, si è scelto di presentarla
come allegato alla riunione che l’ha approvata
(quella del 14). Della riunione del 9-10 esiste inoltre
un riassunto destinato ai membri del Comitato centrale
e ai segretari federali. Pur essendo collocato nel fascicolo
con una numerazione autonoma, si è scelto di
riprodurlo come allegato al verbale originale e solo
per la parte relativa alla relazione di Secchia e all’intervento
di Togliatti, mentre vengono segnalate tra parentesi
angolari le parti del dibattito omesse nella versione
riassunta.
Non pubblichiamo invece – ed è la seconda
eccezione – il fascicolo Verbali della direzione,
«Allegati 1947», poiché non allegato
ad alcuna riunione particolare. Pur essendo di grande
interesse – riguardando per lo più la costituzione
del Cominform e il dissenso espresso in merito da Terracini
– si è ritenuto di non pubblicano (se ne
fornisce comunque un elenco sommario in nota al verbale
del 7-10 ottobre 1947), perché allo stato attuale
delle informazioni non è possibile stabilire
quali dei documenti in esso contenuti fossero noti ai
membri della direzione e in quali date oggetto di discussione,
tant’è che gli stessi archivisti non hanno
ritenuto di doverli aggregare, come di norma, alle singole
sedute, ma di creare un fascicolo a parte, il quale
a sua volta integra la documentazione sullo stesso tema
con tenuta nel fascicolo allegato al Comitato centrale
del novembre 1947. I documenti più rilevanti
di entrambi i fascicoli sono comunque noti grazie all’ampia
scelta curata da Aldo Agosti.
Ma cosa sono esattamente i verbali della direzione e
come venivano prodotti? Quando venne annunciata la loro
imminente pubblicizzazione, Massimo Caprara ne diede
una testimonianza tanto interessante, quanto colorita.
Come segretario di Togliatti era stato lo stesso Caprara
l’autore materiale dei verbali dal 1944 agli inizi
del l953 Sebbene il nome di Caprara non compaia mai
in questi verbali, ciò non smentisce questa testimonianza:
i resoconti, infatti, quasi tutti dattiloscritti, precisano
raramente chi ne sia l’estensore, e probabilmente
lo segnalano solo nei casi di eccezioni alla prassi.
Come venivano dunque redatti i verbali? Scrive Caprara:
«Tutti i verbali [...] furono redatti da me: a
matita pastello con punta morbida e acuminata, su un
taccuino di media grandezza a quadretti, la data in
alto a destra, la sigla E (Ercoli, ossia Togliatti)
in calce al foglio.
«Le correzioni vennero da lui sovrapposte a penna,
con inchiostro verde Pelikan, solo con l’intento
di interpretare meglio passaggi oscuri o male esposti,
mai per manipolare i testi degli interventi e tanto
meno le conclusioni, sovente adottate a maggioranza
con la dizione “Ercoli si riserva” (il che
vuol dire che contava di fare di testa sua).
«Una volta approvati dal segretario del partito,
provvedevo a far battere a macchina i verbali da Sonia
[Fratoni] la ragazza di via Marmolada alla Piramide,
solerte e vivace, addetta alla segreteria, la sola a
conoscenza di testi riservati, in prima stesura, articoli
e discorsi pubblici che Modola, lo stenografo meridionale,
taciturno e impenetrabile [...] provvedeva a riprendere
ed ordinare»
I verbali ora pervenutici sono per lo più proprio
questi dattiloscritti, che Caprara stesso si premurava
di curare nella versione definitiva, e non gli «autentici
manoscritti d’epoca e d’autore», che
a suo avviso sono gli unici documenti attendibili. Si
può a ragione ritenere che i verbali manoscritti
rappresentino solo una fase del processo di lavorazione
del documento, non necessariamente la più completa,
e che il fatto di poter disporre dei dattiloscritti
non rappresenti uno svantaggio: alcuni elementi (la
numerazione autonoma dei dattiloscritti delle relazioni
di Togliatti, o annotazioni come «Manca l’intervento
di Longo che preparerà» o simili) ci fanno
intuire come gli appunti del verbalista venissero poi
comunque integrati con altri documenti, forse meno immediati,
ma certo più meditati e ampi. L’unico verbale
che corrisponde alla descrizione fattane da Caprara
è quello del 3 gennaio 1948. La riunione, svoltasi
all’immediata vigilia del VI Congresso (apertosi
il 4), dovette tenersi presumibilmente a Milano; e questo
spiegherebbe perché il verbale non venne trascritto
a macchina e sia rimasto alla fase di manoscritto, esattamente
«a matita pastello», «su un taccuino
di media grandezza a quadretti» (e senza il visto
di Ercoli). È vero, però, che per gli
anni successivi i manoscritti di Caprara sono più
frequenti che per il periodo qui considerato.
Il dibattito sull’«attendibilità»
di questi documenti – svoltosi più in sede
giornalistica all’epoca dell’apertura degli
archivi che non sulla base di appropriati studi storico-documentari
– manifestava il sospetto che il materiale oggi
a disposizione degli studiosi sia, come si espresse
io stesso Caprara, «una versione addomesticata
da lunghi sofferti anni di ripensamenti, adattamenti,
sapienti arrangiamenti del dopo» e non quella
effettivamente prodotta all’epoca. Ci sembrava,
invero, una discussione per la quale al momento non
sussistano gli elementi: per affermare che in tempi
recenti si sono operate delle manipolazioni bisognerebbe
conoscere la reale consistenza della documentazione
originariamente conservata e quale e perché sia
pervenuta sino ad oggi, mentre la Fondazione Istituto
Gramsci, di prassi, riceve il materiale senza poterne
verificare il contesto documentario. Nel caso dei verbali
qui pubblicati comunque tale verifica è stata
compiuta, sia per il testo dei singoli verbali, sia
per la consistenza dei fascicoli nei quali sono raccolti
gli originali (Mf 272 e 213).
Merita invece in questa sede sottolineare la particolarità
della documentazione. Un verbale, infatti, qualsiasi
stesura si voglia privilegiare, rappresenta sempre una
sintesi di quanto viene detto in una riunione. La sommarietà
di questi verbali è evidente, ad esempio, in
certe asimmetrie tra quanto un dirigente sostiene e
quanto un altro, magari polemizzando, attribuisce al
primo. Sta allo studioso valutare i motivi delle insufficienze;
nella cura di questa pubblicazione si è comunque
cercato di segnalare in nota le discrasie più
evidenti (riferimenti a interventi non verbalizzati
o in un ordine diverso da quello che si evince dal dibattito,
ecc.). Ma in quanto sintesi il verbale è anche
scelta, ed è quindi fortemente condizionato da
quanto chi stendeva o approvava il verbale riteneva
all’epoca meritevole, e opportuno, di «passare
alla storia». Certi argomenti sono trattati con
palese reticenza: si veda ad esempio il verbale del
18 marzo 1946. In esso, presentato integralmente come
gli altri, si legge soltanto «Si approva l’informazione
del compagno Reale sul suo lavoro», senz’altro
aggiungere e specificare.
Se i limiti propri della verbalizzazione potranno forse
essere superati per gli anni più recenti con
il ricorso alle registrazioni audio (inesistenti per
tutto il periodo aperto alla consultazione), continuerà
a rimanere aperto per gli studiosi il problema di definire,
attraverso la pluralità delle fonti, il percorso
reale dei processi di decisione, non perfettamente coincidente
con quello stabilito dalle norme statutarie. Su una
questione, ad esempio, non certo irrilevante come la
definizione del programma di governo dei comunisti dopo
le elezioni per la Costituente, discussa nella riunione
del 20-22 giugno 1946, l’allora ministro dell’Agricoltura
e foreste, Fausto Gullo, ricorse a un canale del tutto
informale – una lettera a Togliatti che pubblichiamo
in Appendice – per esprimere il suo giudizio in
merito perché «non [lo] potetti fare a
voce, sia per l’ora tarda e sia per lo stato di
stanchezza che tutti ci vinceva».
Nel pubblicare i verbali dal V al VI Congresso si è
scelto di riportare integralmente i fascicoli «1946»,
«1947», e il verbale n. 1 del «1948»,
nell’ordine con il quale si presentano. Il titolo,
comprendente la data e l’oggetto della discussione,
è redazionale. In alcuni casi si è ritenuto
opportuno aggregare sotto uno stesso titolo alcuni sottofascicoli
relativi a singole sedute, identificabili come riunioni
unitarie articolate in più giorni (la collocazione
originale è comunque segnalata).
Precede le note al testo una nota non numerata, contenente
il numero del sottofascicolo all’interno dell’anno;
tra virgolette il titolo originale del documento (ed
eventuali numerazioni dattiloscritte sul documento);
i fogli di cui si compone; se manoscritto. Inoltre in
essa si segnalano gli ordini del giorno, così
come sono riportati nella scheda archivistica predisposta
dall’archivio della direzione, che in alcuni casi
ha integrato le informazioni desumibili dai verbali
con quelle ricavate dalle convocazioni. Le eventuali
difformità tra odg previsti e quelli discussi
vengono, comunque, segnalate. Infine, la nota contiene
i riferimenti bibliografici relativi alle risoluzioni,
ai comunicati, prodotti al termine della riunione, e
altri elementi utili alla collocazione e alla lettura
del verbale dal punto di vista documentario: precedenti
documenti della segreteria e del Comitato centrale,
segnalazione delle riunioni di cui manca il verbale,
ecc. Sono invece escluse da questa nota elementi di
inquadramento storico.
Quando il nome di coloro che intervengono non figura
tra i presenti è stato aggiunto tra quadre. «L’Unità»
quando non specificato è l’edizione di
Roma.
Pur volendo fornire un documento integrale e filologicamente
corretto, si è cercato, attraverso l’apparato
critico, di rendere questi testi leggibili anche per
un pubblico più vasto di quello degli specialisti.
Pertanto, nei limiti di note al testo, si sono fornite
le notizie indispensabili per orientare il lettore nello
svolgersi degli avvenimenti e di chiarire, soprattutto,
i riferimenti alle cronache quotidiane.
Nella trascrizione del testo, collazionato sugli originali,
sono stati rispettati la grafia, i dialettismi e la
punteggiatura, gli errori (ad eccezione di quelli meramente
di dattiloscrittura). All’errore sintattico, grammaticale,
o ortografico è stato fatto seguire un sic, senza
tuttavia abusarne, scegliendo in alcuni casi di intervenire
sul testo, segnalandolo comunque con parentesi quadre
(eventuali punti di sospensione tra quadre sono da leggersi
non come omissioni del contenuto del testo, ma, anch’essi,
come tagli di erronee ripetizioni nella trascrizione).
Anche gli eccessivi spazi bianchi nel testo vengono
segnalati, perché paiono indicare il più
delle volte l’incomprensione dell’estensore
del dattiloscritto nel trascrivere il manoscritto originario.
Sono state unificate le maiuscole e le grafie errate
dei nomi più noti (Ingrao che nei documenti è
sempre scritto Ingrau; Pajetta, che a volte è
Paietta, Iotti a volte Jotti, Gian Carlo Pajetta e non
com’è più frequente Giancarlo).
Negli altri casi l’indicazione corretta segue
tra quadre (nell’indice dei nomi compaiono solo
nella forma ritenuta corretta).
Quando il nome era abbreviato o tronco è stato
messo per esteso (Pajetta Giu. e G. C., Montagnana R.
e M. sono rispettivamente Giuliano, Gian Carlo, Rita
e Mario). Quando non è segnalata alcuna abbreviazione
gli estensori dei verbali intendono, senza ambiguità,
Gian Carlo Pajetta e Rita Montagnana, sicché
non si è intervenuti neppure in sede redazionale.
I nomi stranieri sono traslitterati con la grafia internazionale,
mentre negli originali si segue una traslitterazione
dei nomi russi simile a quella francese (ad esempio
Zdanov è sempre scritto Jdanov).
Quando non espressamente citato altrimenti, i fondi
consultati sono quelli presenti negli archivi della
Fondazione Istituto Gramsci, per cui si è omessa
la sigla dell’archivio di provenienza. In particolare
vengono citati:
Carte Sereni, Scritti e discorsi
Carte Togliatti raccolte da Ferri e Amadesi, citate
solo come Carte Togliatti, Scritti e discorsi
Carte Togliatti, Scrivania
Archivio partito comunista, Verbali gruppo parlamentare
Archivio partito comunista, Direzione, Allegati 1947
Archivio partito comunista, Materiale delle federazioni
Archivio partito comunista, Verbali del Comitato centrale
Archivio partito comunista, Conferenza d’organizzazione
Materiale sulla cooperazione dal 1946
Non sarebbe stato possibile sciogliere molti interrogativi
e reperire informazioni senza il paziente contributo
di molti, tra cui voglio ricordare in particolare: Antonio
Agosta del ministero degli Interni, David Bidussa della
Fondazione Feltrinelli, Maria Grazia Camilletti dell’Istituto
storico della Resistenza delle Marche, Giuseppe Garelli
dell’Archivio della federazione Pds Torino, Monsignor
Giuseppe Garneri, Renata Yedid Levi Jodice dell’Istituto
Gramsci piemontese, Adolfo Mignemi dell’Istituto
storico della Resistenza di Novara, Michele Pistillo,
Gastone Predieri della cineteca dell’Associazione
Italia-Urss, Claudio Silingardi dell’Istituto
della Resistenza di Modena, e inoltre il personale degli
archivi della Curia arcivescovile di Torino e di quella
di Milano, il personale dell’Istituto Gramsci
siciliano, della Biblioteca della Cgil nazionale, della
Biblioteca universitaria di Sassari, dell’Istituto
Luigi Sturzo.
Fondamentale è poi stato il contributo fornito
da tutto il personale della Fondazione Istituto Gramsci,
in particolare della biblioteca, degli archivi e del
servizio tecnico, nonché dell’archivio
della direzione del Pds, sempre disponibile a ogni sollecitazione
e richiesta. A Ovidio Martini va il merito della revisione
redazionale, che ha condotto con lo scrupolo e l’esperienza
che gli sono propri.
Un ringraziamento particolarissimo va ad Albertina Vittoria
che con pazienza e attenzione ha letto tutto il testo,
fornendo preziosi consigli e utili indicazioni, e mi
ha sostenuto nei momenti di indecisione e di sconforto.
|