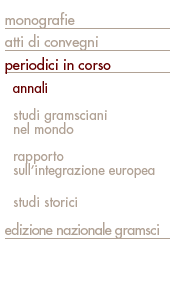|

|

|
 |
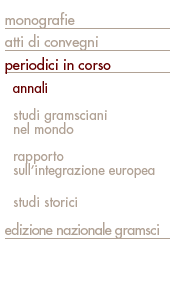

|
| <–
torna
indietro
|
ANNALE
I
Bibliografia gramsciana
1922-1988
a cura di John M. Cammett
Roma, Editori Riuniti,
1991
p. 457, L. 75.000
ISBN 978-88-359-3451-6 |
| |
Prefazione
di Nicola Badaloni
A Formia, nell’ottobre del 1989, nel corso di un
importante convegno dedicato a «Gramsci nel mondo»,
al quale hanno partecipato noti studiosi italiani e stranieri,
è stata presentata la proposta di costituire una
«Associazione internazionale “Antonio Gramsci”».
La motivazione di tale proposta è stata apprezzata
e anche resa più chiara non solo dai temi trattati
nelle relazioni, ma anche dalla vasta documentazione che
già risultava dal primo abbozzo della Bibliografia
gramsciana, pubblicata in stampa provvisoria, che offriva
un quadro imponente d’interesse pressoché
mondiale. Un altro anno di lavoro ci ha permesso ora di
dare alla luce, in forma definitiva e quanto più
completa possibile, un rendiconto bibliografico di tale
interesse suscitato nel mondo da questo figlio della Sardegna,
dirigente e teorico politico, filosofo moderno e rinnovatore
del marxismo. Come tutti sanno, l’accademia in cui
egli ha affinato e condensato il suo pensiero e il suo
impegno pratico, è stato il carcere. La sua sorte
non è stata in ciò difforme da quella di
tanti innovatori italiani e stranieri che hanno saputo
in passato affrontare esili, rischi, sofferenze e anche
la morte. I Quaderni del carcere (come è accaduto
per gli scritti di molti di questi «martiri»)
non cessano di essere studiati e continuano a dare un
importante contributo ad una ripresa e ad un aggiornamento
del pensiero di Marx. Avvertiamo in modo particolare l’importanza
di tutto ciò, proprio nel momento in cui il primo
tentativo storico di trasfondere in nuove forme di vita
quelle interpretazioni e volgarizzazioni del marxismo,
che Gramsci criticava, è rovinosamente fallito.
Gli interessi di Gramsci, pur radicati nella cultura italiana,
come ben sanno gli studiosi specialisti, i cui lavori
sono menzionati nella Bibliografia, e i molti lettori
non specialisti, hanno spaziato ben oltre il materialismo
dialettico nella sua forma volgare. Aveva perciò
ragione Palmiro Togliatti quando nel 1964, recensendo
una ricca antologia gramsciana, aveva sostenuto che l’elaborazione
teorica e le innovazioni di vita e di cultura proposte
da Gramsci non erano solo proprietà riservata di
un partito politico, seppur questo, in Italia, a esse
complessivamente si ispirasse, ma della intera nazione
italiana. Questa Bibliografia dimostra però che
anche tale giudizio era limitato e che Gramsci ha contribuito
a riavvicinare la cultura della sua terra a quella europea
e a quella mondiale. E’ sufficiente leggere solamente
i titoli dei saggi segnalati in questa raccolta bibliografica,
infaticabilmente realizzata da un gruppo di studiosi statunitensi,
per avvertire l’ampiezza della «fortuna»
di Gramsci.
Di essa, a me sembra, si possono dare quattro motivazioni
principali.
La prima è la critica approfondita del materialismo
dialettico nella versione dogmatica unilaterale che si
è affermata nel «comunismo reale»,
imponendo verità storiche e sociologiche distaccate
dal sentire delle masse. In alternativa Gramsci ha proposto
una sua teoria della società moderna antielitaria
ma non rozzamente egalitaria, attenta al pensiero implicito
nei modi di sentire e di vivere degli uomini, fortemente
simpatetica verso tutte le forme di aggregazione comunitaria
e ai germi di una nuova visione delle relazioni umane
che apparivano in esse, e che egli avvertiva come vie
possibili per far riemergere storicamente il socialismo.
La seconda è l’analisi spregiudicata della
storia d’Italia, vista nel complesso come egemonia
di una classe dominante, chiusa nel suo egoismo e pur
capace di avvertire il divenire storico nella forma di
rivoluzioni passive. Di contro sta il rilievo dato alla
capacità di resistenza di grandi masse umane, nelle
diverse caratterizzate forme di aggregazioni politiche
e di spirito di «scissione» dalle ideologie
dominanti, che tali masse avevano acquisito. I limiti
stavano nella debole forza espansiva dovuta alloro settarismo,
nella estraneità e nel conformismo dei ceti e dei
gruppi politici e intellettuali (fatte le debite eccezioni)
che potevano dirigerle e conferire loro autorità.
Di qui la rottura di Gramsci con quelle filosofie idealistiche
che avevano coscientemente rotto con il marxismo storico,
accettando l’elitarismo come ideologia della conservazione.
Ciò aveva facilitato il trasformismo di piccoli
gruppi prima e di masse più ampie in seguito, quando
il paese si era piegato alla nuova forma di reazione antipopolare
rappresentata dal fascismo. La polemica con Croce, con
Gentile, con Pareto, con il pragmatismo italiano, ha come
motivazione principale il rifiuto di queste pur grandi
menti a proporre una «catarsi» intellettuale
e morale tale da trasformare lo spirito di sottomissione
in lotta liberatrice.
La terza motivazione è la sua capacità di
spaziare nella situazione europea e mondiale dalla Francia
agli Usa, ai paesi di lingua spagnola fino al gandhismo
e al tolstoismo. Sempre attento alla specificità
dei caratteri di ciascun popolo e alle possibilità
che le diverse situazioni storiche aprono, Gramsci cercava
ovunque spinte e stimoli a creare nuove forme vitali.
Accanto ai fenomeni storici di vasta portata emergono
quelli minuti, quasi folkloristici, tuttavia sempre valutati
col suddetto metro e, come contrappunto, la responsabilità
degli intellettuali, considerati non soltanto come portavoce
di interessi di classe, ma anche come artisti, come scienziati,
come politici, grandi comunicatori di idee. Queste ultime,
pur nate in contesti diversi, possono essere trasferite
e tradotte in altri. Un esempio tipico è l’abbozzo
della sua teoria della funzione delle scienze, ma anche
i suoi significativi accenni alla non violenza legati
appunto al gandhismo, al tolstoismo, e alla prima fase
del Cristianesimo. Non mancano i limiti d’analisi,
ma il fatto stesso che questi tre fenomeni siano avvicinati,
dimostra come ciò che egli chiama «storicismo
assoluto» sia nella realtà una filosofia
della prassi, che implica capacità di analizzare
situazioni storicamente diverse, idee passate che possono
essere riattualizzate dando forma universale a esperimenti
ideali nati localmente.
La quarta motivazione è il rinnovamento gramsciano
del marxismo, che è rivalutazione del lato attivo
dei comportamenti umani. Gramsci ha potuto leggere e quindi
riflettere intensamente su La Sacra Famiglia (testo in
gran parte opera di Marx) a lui assai caro (e che compensa
in parte l’impossibilità di accedere ai Manoscritti
del 1844 e alla Ideologia tedesca). Partendo da quel testo
a lui noto, Gramsci ha preso atto che la rigida interpretazione
de Il Capitale in senso economistico e deterministico
dovuto agli epigoni della Seconda e della Terza Internazionale,
avrebbe avuto bisogno di essere rovesciata. È vero
che la Rivoluzione contro il Capitale, scritta negli anni
giovanili, si trasforma, col passare del tempo, in una
considerazione e comprensione più attenta dei testi
di critica dell’economia politica, ma anche in una
loro interpretazione antidogmatica che abbassa a suggestioni
metaforiche i residui metafisici di essa. L’espressione
Anatomia della società, ripete più volte
Gramsci, deve essere interpretata come una «metafora»;
il passo della Prefazione del ’59, che gli sta tanto
a cuore, sulle potenzialità di sviluppo delle forze
storiche e sulla loro maturazione in contesti reali è
per lui un criterio di metodologia dell’agire storico.
Nel complesso le quattro motivazioni qui indicate (aggiunte
all’acutezza e severità di giudizi sulle
culture e sui comportamenti umani) divengono un approccio
realistico e moderno a possibili forme di liberazione,
niente affatto garantite, ma raggiungibili ove sorgano
e si aggreghino volontà riformatrici rivoluzionarie
di ampia portata. La storia è drammaticamente carica
di sofferenze, in particolare quelle imposte alla borghesia,
della cui formazione come classe Gramsci dà una
spiegazione tutta fondata su nuove condizioni sociali
connesse ad atti ripetitivi e conformismi psicologici,
anziché su leggi, ma di cui non nasconde lo spietato
cammino. Tragica è stata la vita di Gramsci, tragico
il succedersi degli eventi nelle sinistre italiana ed
europea. Nei Quaderni del carcere, tuttavia, i temi delle
libertà umane e politiche hanno il posto centrale
e il passo su Machiavelli (coi suoi riferimenti al Moderno
Principe) hanno questa stessa finalità, seppure
in tali pagine lo «stare in situazione» coincide,
nel linguaggio e talvolta nella sostanza, con forme di
analisi datate. Non è un caso però che nel
capitoletto intitolato Freud e l’uomo collettivo
Gramsci integri i rigori della riforma intellettuale e
morale con quelli della filosofia come strumento terapeutico.
Egemonia e consenso non sono per Gramsci mezzi di sottomissione,
ma di liberazione in una situazione data. L’egemonia,
entro la società civile, non fissa le forze portatrici
di progresso, ma le problematizza in relazione alle questioni
oggettive che si pongono come primarie. Di qui il pluralismo
che implica la modificazione della concezione delle forze
storiche progressive, la necessità di un loro spaziare
con scelte diverse di fronte ad emergenze differenti.
Potenzialmente siamo di fronte ad una della forme di più
radicale antidogmatismo che la filosofia del nostro secolo
abbia saputo darci. Se si accetta come presupposto che
le cose così come stanno creino accanto a bisogni
spesso artificiali anche sofferenze e disagio, e quindi
debbano essere mutate, allora Gramsci è un protagonista
del nostro tempo. In gran parte gli autori, i cui nomi
sono raccolti in questo volume, hanno letto e apprezzato,
pur criticamente, le sue opere. Una così straordinaria
«fioritura» non può essere casuale
e neppure isolata. Alla solitudine disperata del carcere,
aggravata dalla precedente polemica col gruppo dirigente
emergente in Urss e dall’incomprensione di una parte
dei suoi stessi compagni di partito, si contrappone idealmente
il vasto interesse di studiosi e critici del suo pensiero,
qui documentato.
La «Fondazione Gramsci», che ha cooperato
attivamente a pubblicare in edizione critica quasi tutte
le sue opere, è lieta di poter fornire anche questo
nuovo strumento di lavoro ed esprime la speranza che esso
possa servire sia come approccio a una storia sull’influenza
della figura di un autore così ampiamente e variamente
studiato sia a sviluppare nuove riflessioni su di lui.
Il pensiero di un «classico», come ormai dev’essere
considerato Gramsci, è fecondo nella cultura sia
quando suscita adesione sia quando è oggetto di
critiche.
Un ringraziamento particolare per la realizzazione di
questa Bibliografia va all’autore, lo studioso americano
John M. Cammett, docente di storia al John Jay College
di New York. Preziosa è stata però anche
l’opera di aggiornamento ed integrazione della équipe
della «Fondazione Gramsci» coordinata da Guido
Liguori, alla quale hanno collaborato con felici risultati
Patrizia Gabrielli, Maria Luisa Righi e Valeria Vitale. |
|
|
 |
| |
| ©
copyright 1996, 2015
| FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI onlus |
cf 97024640589
|
| sede
legale, uffici amministrativi
|
ROMA VIA PORTUENSE 95c
|
tel. 0039 0683901670 fax 0039 0658157631 |
| segreteria,
archivi, biblioteca
|
ROMA VIA SEBINO 43a| tel. 0039 065806646 fax 0039 0658157631 |
|
|