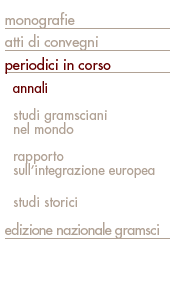|

|

|
 |
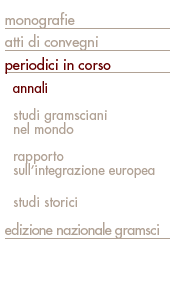

|
| <–
torna
indietro
|
ANNALE
I
Bibliografia gramsciana
1922-1988
a cura di John M. Cammett
Roma, Editori Riuniti,
1991
p. 457, L. 75.000
ISBN 978-88-359-3451-6 |
| |
Introduzione
di John M. Cammett
Quando tornai ad occuparmi qualche anno fa di studi gramsciani,
e iniziai a raccogliere i titoli delle ultime opere apparse
in questo campo, mi meravigliai molto nell’apprendere
che nessuno aveva anche solo provato ad organizzare questo
materiale, e nemmeno era stato portato avanti lo straordinario
lavoro iniziato da Elsa Fubini e pubblicato per l’ultima
volta nel 1977. Nel frattempo, a New York, un piccolo
gruppo di appassionati gramsciani avevano intrapreso una
raccolta di materiali in inglese sulla vita e il pensiero
di Gramsci. Sulla base di questo sforzo decisi di iniziare
l’opera di aggiornamento della bibliografia su Gramsci
nel maggior numero di lingue possibili.
Un anno dopo, durante l’estate del 1987, sottoposi
una prima stesura dei dati raccolti ad Elsa Fubini, Antonio
A. Santucci ed altri colleghi dell’Istituto Gramsci.
Decidemmo allora che in un modo o nell’altro la
bibliografia sarebbe stata pubblicata. Nel 1988, dopo
aver presentato una seconda versione più completa
e meglio organizzata, decidemmo che il mio lavoro avrebbe
occupato per intero il primo numero di una nuova pubblicazione,
gli Annali dell’Istituto Gramsci, che contavamo
di presentare al convegno internazionale su «Gramsci
nel mondo» da tenersi a Formia nell’ottobre
1989. Nel 1989 furono preparate due versioni della bibliografia,
la prima in maggio, la seconda in luglio.
In questa nota introduttiva mi propongo di illustrare
la natura, gli scopi e i limiti di questo lavoro così
come si è andato configurando. Anche solo dieci
anni fa, una bibliografia di queste dimensioni, comprese
le appendici e gli indici, non sarebbe stata possibile.
I progressi nella tecnologia dei personal computers e
la disponibilità di programmi non troppo costosi
permettono a chiunque abbia una conoscenza di base del
trattamento testi, della struttura di una banca dati,
e di come accedere a fonti d’informazione elettronica,
di creare bibliografie di questo genere. Senza bisogno
di perdersi nei noiosi dettagli tecnici di questo lavoro,
tutto ciò che serve è un computer abbastanza
veloce dotato di un’apparecchiatura modem, tre programmi
di software: 1) un programma per creare banche dati; 2)
un programma applicativo per includere i circa 120 caratteri
speciali e accenti necessari in una bibliografia multilingue;
3) un programma di comunicazione per avere accesso a più
banche dati elettroniche.
L’uso del computer e di banche dati su linea non
può ovviamente sostituire del tutto il tipo più
tradizionale di ricerca bibliografica. Queste banche dati,
infatti, includono per lo più solo gli anni più
recenti (di solito a partire dal 1980), e comunque anche
per questi anni non sono certo completi: contengono infatti
pochissime voci riguardanti le lingue meno comuni o tratte
da riviste minori e quotidiani. È stato per questa
ragione che abbiamo creato la banca dati a partire dalle
voci contenute nei precedenti indici bibliografici e nelle
bibliografie su Gramsci già disponibili, primi
fra tutti quelli di Elsa Fubini del 1967 e del 1977. Scoprimmo
allora che quasi tutti i libri ed articoli su Gramsci
pubblicati contenevano almeno una voce che non appariva
da nessuna altra parte! Qualsiasi fosse la loro fonte,
però, una volta che questi titoli erano divenuti
parte della nostra banca dati, diventavano più
utili e più flessibili dal punto di vista dell’«informazione».
La costruzione di una bibliografia computerizzata, del
resto, è ben lungi dall’essere un processo
automatico il computer non è che un «idiota
veloce», estremamente efficiente ma completamente
privo di immaginazione! Quindi, nel corso di questi tre
anni si è dovuto fare e rifare praticamente tutto,
a partire dalla strutturazione dei «campi»,
che costituiscono il contenuto di ciascuna voce, al tipo
di indicizzazione e il «formato di stampa»
che determina il modo in cui l’informazione viene
presentata. Siamo arrivati in questo modo ad un totale
di oltre 7000 pubblicazioni (dal 1920 al 1988) in ventotto
lingue. Pur avendo controllato e ricontrollato molte delle
voci, vi saranno sicuramente errori, come anche, certamente,
non avranno trovato posto in questa bibliografia alcune
pubblicazioni su Gramsci. Rimane però il fatto
che uno dei grandi vantaggi di una bibliografia computerizzata
è che la si possa facilmente correggere e aggiornare.
Per far questo contiamo sul contributo di tutti gli studiosi
di Gramsci del mondo.
Le voci incluse nella bibliografia sono elencate in ordine
alfabetico, secondo il nome degli autori, ma con due eccezioni,
entrambe all’inizio: gli scritti anonimi (dalla
voce l a 181) vengono indicati con due asterischi («**»
); le raccolte con saggi di più autori (da 181
a 264) sono disposte in ordine alfabetico secondo il titolo
della raccolta. Sarebbe stato estremamente facile convogliare
le due serie nell’ordine alfabetico generale, ma
se non lo abbiamo fatto è perché i vantaggi
del sistema adottato sono molto maggiori. Le 181 voci
che si riferiscono a lavori anonimi sono elencate in ordine
cronologico, e sono quindi più facili da trovare,
così come è più facile trovare le
raccolte di saggi su Gramsci elencate insieme.
Naturalmente, dato che la bibliografia è interamente
computerizzata, si potevano scegliere diversi modi per
realizzarla, ordinando le voci per anno di pubblicazione,
lingua, temi o argomenti. Nessuna di queste alternative,
però, offre vantaggi maggiori, nella consultazione,
rispetto a una bibliografia ordinata secondo il cognome
dell’autore.
L’informazione indispensabile resa più accessibile
da questi altri modi può facilmente essere fornita
con sistemi molto più rapidi, come abbiamo cercato
di fare con le appendici. Per prima cosa si possono fornire
quante più informazioni utili possibili a partire
dai documenti stessi, oppure si possono indicare, seppur
implicitamente, strategie per ulteriori ricerche, che
rendano più completa ed accurata una successiva
edizione della bibliografia.
La prima sezione riassume la produttività «annua»
delle pubblicazioni su Gramsci. A nostro avviso si può
imparare molto, e si possono trovare molte conferme, a
partire da questi dati. Come risulta chiaramente, infatti,
prima del 1937 Gramsci era pressoché sconosciuto
nel movimento comunista internazionale e perfino poco
noto ad alcuni membri del suo stesso partito, tanto che
viene citato in appena 44 pubblicazioni. Ciò non
era dovuto soltanto alla discrezione di Gramsci, ma anche
alla natura egualitaria dei partiti comunisti in quegli
anni e alla natura marginale, semiclandestina, del PCd’I
negli anni in cui Gramsci era il capo. Il gran numero
di pubblicazioni che apparirono immediatamente dopo la
sua morte tra il 1937 e il 1938 uscirono ben 75 lavori
su Gramsci testimoniano la forza della sua personalità
e l’effetto del modo in cui guidò il partito.
A partire da allora la sua influenza ha trovato notevoli
conferme in centinaia di «testimonianze» che
continuano ad uscire ancora oggi (vedi nell’Indice
le voci riportate sotto «memoirs»). All’interruzione
dovuta alla Seconda Guerra Mondiale vi sono solo undici
voci per gli anni che vanno dal 1939 al 1944 fece seguito
la pubblicazione da parte dell’editore Einaudi fra
il 1947 e il 1951 delle Lettere dal carcere e dei Quaderni
del carcere. A questo proposito appare sorprendente come
un numero tutt’altro che esiguo di studiosi ed intellettuali,
tra cui molti italiani, non sembrano essere consapevoli
dell’importanza di quest’opera.
In media, dal 1947 a tutto il 1952 sono usciti più
di cinquanta lavori su Gramsci ogni anno. In quegli anni
di guerra fredda, forse non di «ferro e fuoco»
come erano stati gli anni Trenta, ma segnati comunque
da uno sterile scontro tra due «diversi sistemi
sociali», il Pci fu l’unico partito comunista
del mondo ad avere il coraggio di ridiscutere i fondamenti
del marxismo e la sua realizzazione nel passato e nel
mondo contemporaneo. Ovviamente, solo il Pci aveva un
Antonio Gramsci e, va aggiunto, un Palmiro Togliatti,
il quale aveva spinto perché venissero pubblicati
i Quaderni. È vero che ci sono stati dei «tagli»
nella preparazione dei Quaderni, e si può sempre
contestare il valore delle suddivisioni tematiche di quei
volumi. Tuttavia, come ha notato Valentino Gerratana,
l’ordine tematico usato nella prima edizione dei
Quaderni era «una scelta possibile che Gramsci stesso
avrebbe potuto fare se avesse deciso di dare una forma
definitiva alla sua opera». Ciò che è
fuori discussione, anzi è fin troppo evidente,
è che la fama nazionale ed internazionale di Gramsci
cominciò proprio in quegli anni.
Il successivo cambiamento quantitativo, un vero e proprio
«salto in avanti», si ha nel 1966: da quest’anno
in poi la «produzione annuale» non scende
mai sotto le 100 pubblicazioni. Particolare attenzione
va data alle ragioni cui è dovuto questo cambiamento
improvviso in cui sicuramente entrano in gioco diversi
fattori politici, sociali, economici e culturali. Per
facilitare il lavoro, abbiamo incluso liste per anno e
per numero della voce a tutti i contributi. Un incremento
simile, seppur forse meno evidente e continuo, si registra
nel 1974. Da quest’anno, e fino al 1980, appaiono
più di 200 titoli l’anno. Questo aumento
considerevole è da collegarsi probabilmente ai
successi elettorali riportati dal Pci in quegli anni ed
al fenomeno dell’«eurocomunismo». Il
numero delle pubblicazioni nel corso degli anni Ottanta
non è andato oltre una media di 150 per anno, ma
questa media è pur sempre di molto superiore rispetto
alla media degli anni precedenti. Da ultimo, non si può
non sottolineare la straordinaria produzione negli anni
1977 e 1987, che hanno segnato, rispettivamente, il 40°
e il 50° anniversario della morte di Gramsci. Per
quegli anni abbiamo un totale di 1275 voci, quasi il 20
per cento dell’intera bibliografia!
Le 2738 voci non italiane rappresentano circa il 38 per
cento del totale della bibliografia. Di queste, 909, circa
il 13 per cento del totale, sono state pubblicate in lingua
inglese. Ma il nostro lavoro in quest’area è
lungi dall’essere completo! Altre lingue ben rappresentate
nella bibliografia, anche se non ancora in modo completo,
sono il francese, il tedesco, il greco, il polacco, il
russo e l’ungherese, e le diverse lingue jugoslave.
In altri casi abbiamo delle serie lacune: vi è
molto poco per quanto riguarda le lingue di paesi dell’Est
quali la Bulgaria, la Cecoslovacchia e la Romania. Voci
in spagnolo e portoghese sono abbastanza ben rappresentate,
ma solo per quanto riguarda pubblicazioni dell’America
Latina e non quelle della Spagna e del Portogallo. Considerevoli
vuoti esistono nelle voci scandinave ed olandesi; e, infine,
non abbiamo quasi nulla per le lingue africane ed asiatiche.
Speriamo che queste lacune vengano colmate nei prossimi
supplementi a questa bibliografia: contiamo sugli specialisti
di Gramsci di tutto il mondo affinché inviino le
loro pubblicazioni e le loro bibliografie alla Fondazione
Istituto Gramsci a Roma. Nel frattempo, nell’Indice
delle lingue tutti i contributi (eccetto quelli in italiano)
sono elencati numericamente secondo la lingua in cui sono
state pubblicate. Per chi fosse interessato ad una particolare
lingua, bastano pochi minuti per controllare l’accuratezza
e la completezza di quella lista.
Senza l’aggiunta indispensabile dell’Indice
dei nomi di curatori e traduttori e dei soggetti la bibliografia
non sarebbe che un elenco di pubblicazioni disposto in
ordine alfabetico secondo il cognome degli autori. In
questo modo, invece, costituisce la base per una ricerca
scientifica su una gran numero di soggetti. L’Indice,
ovviamente, accanto ai pregi ha anche dei difetti. Non
tutte le voci sono state in esso elencate con la stessa
cura; in molti casi, le stesse pubblicazioni non erano
disponibili al momento di prepararlo; in altri casi, sono
state ripetute troppe volte alcune parole-chiave generali.
Forse il suo maggior pregio sta nell’inclusione
di nomi ed eventi trattati nelle voci (come Dante o Rosa
Luxemburg e PCd’I o Convegno di Imola). Per quanto
riguarda i concetti più generali, alcuni sono abbastanza
specifici da fornire una guida sicura per gli studiosi:
ad esempio, Anarchism, Fascism, Historical bloc, Risorgimento.
In alcuni casi, però, la molteplicità di
riferimenti di alcune categorie usate più di frequente
limita la loro utilità: a cominciare da Consigli,
Egemonia, Intellettuali e Letteratura, etc., che vanno
sostituiti con sottocategorie più specifiche.
Alcuni dei soggetti-nomi contenuti nell’Indice richiedono
una spiegazione. La categoria Memoirs include testimonianze,
commenti fatti da un curatore su lettere ed articoli di
Gramsci pubblicati separatamente, ed altre fonti primarie
(o quasi) per la sua vita e il suo pensiero. Per quanto
vi siano più di 400 voci elencate in questa rubrica,
siamo convinti che Memoirs costituisca uno degli aspetti
di maggiore utilità nella bibliografia, e che dovrebbe
essere usata unitamente ad un’altra voce, quella
di PCd’I, che contiene riferimenti a pubblicazioni
che si concentrano sulla storia del partito fino al tempo
della condanna definitiva di Gramsci più che sulla
sua vita e sulla sua opera.
Vorrei finire ribadendo che in questa bibliografia non
sono incluse opere di Gramsci, in italiano o tradotte,
anche se essa comprende le prefazioni e le introduzioni
di altri ad esse. Allo stesso modo, essa non comprende
gli scritti sulla vita e il pensiero di Gramsci pubblicati
dopo il 1988. La Fondazione Istituto Gramsci ha in programma
di dedicare parte del prossimo numero degli Annali ad
una bibliografia degli scritti su Gramsci apparsi nel
1989. Infine, in occasione del centenario del 1991, ha
intenzione di pubblicare una estesa bibliografia delle
edizioni delle opere di Gramsci in lingua straniera.
New York, 18 agosto 1989 |
|
|
 |
| |
| ©
copyright 1996, 2015
| FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI onlus |
cf 97024640589
|
| sede
legale, uffici amministrativi
|
ROMA VIA PORTUENSE 95c
|
tel. 0039 0683901670 fax 0039 0658157631 |
| segreteria,
archivi, biblioteca
|
ROMA VIA SEBINO 43a| tel. 0039 065806646 fax 0039 0658157631 |
|
|