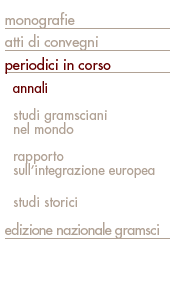|
Prefazione
di Giuseppe Vacca
Guerra antifascista e nazionalizzazione dei partiti
comunisti
«Bisognerebbe far diventare i partiti
comunisti assolutamente autonomi, e non sezioni dell’IC.
Essi devono trasformarsi in partiti comunisti nazionali
con diverse
denominazioni [...]. L’importante è che
[...] si radichino nel proprio popolo e si
concentrino sui propri specifici compiti [...] ma non
con lo sguardo rivolto a Mosca;
che risolvano autonomamente i compiti concreti che stanno
dinnanzi a loro,
[che] nei differenti paesi sono del tutto diversi».
Stalin pronunciò queste parole
nella notte del ?? aprile ????. Percepiva l’imminenza
dell’aggressione hitleriana e
si preparava alla “guerra patriottica”.
Il giorno successivo Dimitrov pose a Togliatti
e a Thorez il problema dello scioglimento del Comintern,
ricevendone un
assenso convinto?. Subito dopo l’invasione dell’URSS
Togliatti venne reintegrato
nel vertice dell’Internazionale e addetto alle
trasmissioni radio per l’Italia?. Nei
suoi messaggi radiofonici egli cominciava a inserire
riferimenti sempre più ampi
alla storia d’Italia per dare basi più
solide alla nuova politica del partito. È un
terreno sul quale egli si trovava a suo agio: su una
reinterpretazione della storia d’Italia si era
basato il nuovo orientamento del PCI nel ????-?? e Togliatti,
che ad esso aveva contribuito, farà di quel nuovo
inizio il tratto distintivo della “tradizione”
del partito?. Fra il ???? e il ???? egli aveva già
avuto modo di studiare i manoscritti
dei Quaderni del carcere e ad essi attingerà
costantemente?. Via via che il
movimento comunista si posizionava nella «guerra
antifascista», prendeva corpo
la prospettiva delle «guerre di liberazione nazionale»,
già individuata nel rapporto
al VII Congresso dell’Internazionale come possibile
risposta alla «guerra totale»
di Hitler?. Gli sviluppi della guerra fra il ???? e
il ???? legittimavano un orienta-
mento strategico di cui Togliatti era convinto da tempo?.
Ma furono soprattutto
la caduta del fascismo e la costituzione della Grande
Alleanza a consentirgli di approfondire i temi della
«guerra di liberazione in Italia» che lo
persuasero a scommettere sulla tenuta della coalizione
antifascista come nuova cornice delle relazioni internazionali,
nella quale l’antifascismo avrebbe potuto essere
un’opzione stabile del moimento comunista?. Con
l’inizio della guerra fredda Stalin accantonò
quella prospettiva e si tornò ai vecchi schemi.
Ma la collocazione dell’Italia nella sfera di
influenza occidentale consentiva a Togliatti di non
rinunciarvi e questo si riverberò anche sugli
sviluppi della sua riconsiderazione della storia d’Italia.
Rispetto alla definizione molto densa che ne avevano
dato le Tesi di Lione, la seconda guerra mondiale diede
il via a innovazioni significative. Le più rilevanti
si
collocano nel periodo della guerra di liberazione e
della nascita della Repubblica.
Ciò non può sorprendere, poiché
in quegli anni mutarono il ruolo del comunismo
nella politica mondiale, quello della classe operaia
e del PCI nella politica italiana.
La politica estera dell’Italia. Linee di mutamento
della cultura politica del PCI
Si può fissare come punto di partenza
il momento in cui le principali innovazioni
della politica di Togliatti, la democrazia progressiva
e il partito nuovo, sono ormai
delineate, il PCI si accinge a entrare nel governo Badoglio
e la “politica di unità nazionale”
è garantita dalla Grande Alleanza. Nel rapporto
ai quadri dell’organizzazione comunista napoletana
(?? aprile ????) sono presenti riferimenti significativi
alla storia della politica estera italiana, miranti
a «giustificare» la politica estera futura?.
Ma la sede in cui i riferimenti alla storia d’Italia
sono sviluppati con maggiore ampiezza è il rapporto
al V Congresso del partito (?? dicembre ????). In esso
la storia d’Italia dalla Rivoluzione francese
in poi è ricapitolata nelle sue linee
essenziali e il metodo storico è posto a fondamento
di una politica nazionale:
Quando ora guardiamo il punto cui siamo arrivati non
possiamo staccare gli occhi da tutto questo passato.
Scusate dunque – egli dice rivolgendosi ai delegati
– questo richiamo alla nostra storia. Credo sia
necessario, anche perché il nostro partito non
potrà adempiere bene alla propria funzione nazionale
se i nostri quadri dirigenti non saranno bene orientati
su tutti i problemi della vita della nazione e la radice
di questi problemi sta nel passato?.
La nuova strategia del PCI presuppone uno sviluppo e
un’articolazione dell’interpretazione della
storia d’Italia condensata nelle Tesi di Lione.
Non sorprende che essi si focalizzino innanzitutto sulla
storia della politica estera: il PCI è legato
a una delle potenze vincitrici che decideranno insieme
il futuro dell’Italia, fa parte del governo e
Togliatti mira a riplasmarlo come “partito di
governo”. Nel periodo precedente non si può
dire che il PCI avesse sviluppato una politica estera,
né che avesse approfondito la storia della politica
estera dell’Italia. Nelle Tesi di Lione i riferimenti
al tema sono scarsi: il primo è al governo Crispi,
iniziatore di una politica estera imperialistica;
il secondo riguarda il fascismo, il cui velleitario
«espansionismo» era destinato
a fare dell’Italia «uno strumento nelle
mani di uno dei gruppi imperialisti
che si contendono il dominio del mondo»??. In
questa scia, indicata da Gramsci, si
era mosso in seguito anche Togliatti, inserendo la politica
estera del fascismo nella
«tradizione» della politica estera dell’Italia,
denunciando il «revisionismo» fascista
come fomentatore di una nuova guerra europea, avvertendo
che la sua prospettiva
andava in rotta di collisione con il nazismo poiché
gli interessi geostrategici dell’Italia nell’area
danubiana e balcanica cozzavano con quelli della Germania
e infine ravvisando nell’asse con la Germania
hitleriana la scelta più sciagurata che l’Italia
potesse fare poiché si consegnava nelle mani
dell’imperialismo peggiore??.
Pur nella sua scarna essenzialità, questa interpretazione
aveva favorito la politica
del PCI dopo l’entrata in guerra dell’Italia
e, via via che i rovesci militari provocavano la crisi
del fascismo, aveva permesso a Togliatti di individuare
nello sganciamento dalla Germania un obiettivo efficace,
capace di intercettare dinamiche che interessavano la
monarchia, il Vaticano e parti significative della borghesia,
cogliendo le linee di frattura del “blocco storico”
del fascismo??. Ancor più importante, alla caduta
del fascismo gli aveva consentito di elaborare quella
politica che, dopo il riconoscimento sovietico del governo
Badoglio, al rientro di Togliatti in Italia prese l’appellativo
di “svolta di Salerno”. La documentazione
resa disponibile dalla “rivoluzione degli archivi”
ne mostra i condizionamenti e le oscillazioni fra dicembre
???? e marzo ??????. Ma non avremmo dovuto attendere
le rivelazioni del Diario di Dimitrov per scoprire che
essa era stata concordata con Stalin: l’aveva
reso noto Togliatti stesso nel discorso celebrativo
pronunciato alla Camera dei deputati il ? marzo ????
in occasione della morte del dittatore sovietico??.
L’interpretazione della storia d’Italia
sintetizzata nelle Tesi di Lione era stata
fortemente influenzata dall’esigenza di inquadrare
l’avvento del fascismo nella crisi
generale della società italiana originata dalla
Grande Guerra e conteneva una critica
radicale del Risorgimento. Quella interpretazione veniva
ora rivista in punti essenziali. Legittimato dall’indirizzo
antifascista del comunismo internazionale, Togliatti
si dedicò a sceverare le correnti progressive
del liberalismo italiano per collegarvi la sua politica.
Ma le conclusioni della seconda guerra mondiale determinarono
revisioni ancora più ampie. Esse avviarono un
mutamento dei paradigmi della cultura politica del PCI,
di cui Togliatti fu l’interprete principale.
L’eredità di Cavour, di Mazzini
e di Giolitti
Nel formulare la «politica di unità nazionale»
egli appare estremamente avvertito
di quella che sarebbe stata la condizione dell’Italia
alla fine della guerra. La
Conferenza di Casablanca (??-?? gennaio ????), che aveva
deciso la «resa incondizionata » delle potenze
dell’Asse, e quella di Quebec (??-?? agosto ????),
che assegnava ai comandi militari alleati le decisioni
politiche nei territori occupati,
accrescevano il rischio di una divisione del paese,
occupato per due terzi dalle
armate naziste. L’armistizio e il riconoscimento
dello status di paese cobelligerante,
ottenuti dal “Regno del Sud”, non bastavano
a garantire all’Italia un trattamento
non del tutto umiliante al tavolo della conferenza di
pace. Per conquistare
una condizione meno svantaggiosa, l’Italia, pensava
Togliatti, avrebbe dovuto
partire dal riconoscimento della sua situazione e delle
sue responsabilità:
era un paese vinto, corresponsabile dello scatenamento
della guerra, aggressore
della Francia, della Grecia, della Jugoslavia e dell’Unione
Sovietica. L’unica possibilità di migliorare
la propria condizione consisteva quindi nello sviluppo
della
guerra di liberazione e nel contributo che essa avrebbe
potuto dare alle potenze
alleate accelerando la sconfitta di Hitler. Tutto ciò
comportava la rinuncia,
in futuro, alle ambizioni coloniali perseguite dall’Italia
da Crispi a Mussolini. La
consapevolezza che dalla guerra sarebbe scaturita una
dimensione del tutto nuova
delle “grandi potenze” rendeva evidente
che l’Italia non avrebbe potuto più
ambire a essere una di loro. Avrebbe dovuto battersi,
invece, per un nuovo assetto
europeo, basato sull’indipendenza nazionale e
la cooperazione internazionale
fra tutti i popoli. La permanenza della coalizione antifascista
avrebbe garantito
la pace e l’equilibrio di una nuova “Europa
delle nazioni”, amica anche
dell’URSS, assurta al rango di grande potenza
mondiale. Ma soprattutto l’Italia
avrebbe dovuto svolgere un ruolo attivo per contrastare
ogni rischio di rottura
della Grande Alleanza e battersi perché l’Europa
non venisse divisa in blocchi
contrapposti. In essi Togliatti ravvisava il pericolo
maggiore per il paese a causa
della sua arretratezza, della sua debole competitività
e dell’essere un’economia
di trasformazione, per la quale era indispensabile la
più ampia circolazione degli
scambi??. Questa visione era intrisa di una forte diffidenza
verso l’ipotesi federalista che sarebbe durata
per tutto il ventennio successivo. Lo «spazio
europeo », per Togliatti, si estendeva dall’Atlantico
agli Urali ed egli pensava che la
prospettiva «mai più guerra in Europa»
potesse essere garantita solo dal permanere della collaborazione
fra i paesi della Grande Alleanza. Vi era un’evidente
sottovalutazione delle ragioni che in breve volgere
di tempo ne determinarono la rottura e, quando questa
si verificò, Togliatti puntò le sue carte
sul suo superamento, mantenendo fino all’ultimo
riserve fondamentali sull’integrazione europea.
Credo che la sua posizione fosse condizionata dai timori
suscitati dalla
preponderanza strategica degli Stati Uniti e dall’adesione
alla teoria dell’imperialismo, dalla quale derivavano
una visione unilaterale dei pericoli di guerra e una
sottovalutazione del dato più rilevante scaturito
dalla seconda guerra mondiale: l’interdipendenza??.
La sua concezione dell’indipendenza nazionale
appare quindi anacronistica: nel mondo del dopoguerra
la creazione di spazi economici e politici sovranazionali
era un fatto ineluttabile e progressivo; le chances
dell’Italia nella sfera di influenza in cui essa
era collocata non potevano risiedere che nella capacità
di coglierne il “nesso internazionale” virtuoso.
È difficile dire quanto Togliatti credesse alla
possibilità che la divisione del mondo originata
dalla guerra fredda venisse superata in tempi politicamente
utili. In ogni caso, la situazione e il “legame
di ferro” con l’URSS non gli consentivano
la possibilità di giocare un’altra carta;
onde alla politica nazionale del PCI veniva a mancare
l’elemento basilare di un “nesso internazionale”
spendibile. Ma non è compito di questo scritto
approfondire la politica estera di Togliatti. Per il
periodo ????-?? essa è stata ricostruita in modo
persuasivo da Roberto Gualtieri e da Silvio Pons, ai
cui studi rinvio ??. Vorrei dedicare, invece, la mia
attenzione al ripensamento della storia della politica
estera italiana che la nuova collocazione del PCI sollecitava.
Lo si può riassumere nella valorizzazione di
quelle correnti della tradizione risorgimentale che
avevano saputo conquistare e difendere l’indipendenza
nazionale perseguendo una politica di equilibrio europeo
ed erano state capaci di cogliere le opportunità
derivanti anche dai contrasti fra le potenze europee,
ma non in chiave sciovinistica, bensì per concorrere
a una politica di sicurezza e di cooperazione internazionale.
In estrema sintesi, la tradizione riassunta nella formula
«indipendenti sempre,
isolati mai». In occasione della Conferenza di
Londra, per sostenere una soluzione
negoziata fra l’Italia e la Jugoslavia del problema
della frontiera orientale
e della questione di Trieste, il ?? settembre ???? Togliatti
scriveva:
Ritengo che una politica nazionale dell’Italia
deve rimanere fedele all’idea direttrice che fu
di Camillo Cavour, di Giuseppe Mazzini e persino di
Giovanni Giolitti, secondo la quale il popolo italiano
deve essere amico e stretto collaboratore dei popoli
slavi dell’Adriatico??. Nel rapporto al V Congresso,
contrastando la costituzione di blocchi contrapposti,
affermava che, a qualunque di essi l’Italia avesse
aderito, avrebbe avuto il ruolo del «vassallo
di qualcuno», come già era accaduto «nei
primi decenni della Triplice »??; e il ?? luglio
????, intervenendo all’Assemblea Costituente sulla
formazione del secondo governo De Gasperi, ribadiva
quella linea affermando: «Ciò che dico
è del resto nella tradizione [...] che parte
da Cavour, che continua con Visconti Venosta e con tutti
i Ministri degli Esteri italiani che seppero fare una
intelligente politica nazionale».
Il richiamo di questa tradizione era reiterato soprattutto
per sostenere l’«interesse
» dell’Italia a che l’Unione Sovietica
non venisse esclusa dal concerto europeo.
Nel rapporto al V Congresso, dopo aver ribadito che
l’Italia doveva fare
una politica di amicizia anche con l’URSS non
«per motivi ideologici», ma per
«motivi nazionali», ricordava che «dal
Congresso di Vienna fino al ????-??» la
Russia era stata la potenza che più aveva favorito
l’unità d’Italia. Certo, quell’atteggiamento
era stato originato dal suo interesse a promuovere un
nuovo equilibrio europeo nel Mediterraneo. Ma proprio
per questo l’Italia del dopoguerra
avrebbe trovato nell’Unione Sovietica un valido
appoggio al fine di evitare di divenire il vassallo
«di un grande imperialismo straniero». Dunque,
l’amicizia con
l’Unione Sovietica corrispondeva a un indirizzo
di indipendenza nazionale ??.
Questa interpretazione culmina nel Discorso su Giolitti
(?? aprile ????). Come è
noto, esso segna uno dei punti di maggiore innovazione
di Togliatti rispetto alla
storiografia dominante e alla stessa visione gramsciana
della storia d’Italia dall’unità
al fascismo: Giolitti è sottratto alla tradizione
«trasformistica» e presentato come un «riformista»
sconfitto dal sopravvenire della «guerra imperialistica»??.
È molto significativa la sottolineatura del suo
atteggiamento riluttante verso la
guerra di Libia: «Il pericolo che da quella scintilla
potesse sorgere un incendio
più grande – scrive Togliatti – non
è perduto di vista, ma non domina». Giolitti,
dunque, «grazie all’apporto diretto e indiretto
della diplomazia zarista», si dispose
alla guerra come a «una questione da regolare»
in fretta per «non avere più
quella pendenza» in un futuro prossimo che si
annunciava turbolento e incontrollabile.
Così, concludeva Togliatti, veniva continuata
«la tradizione piemontese,
che è tradizione di contatto e amicizia con la
grande potenza orientale e ricerca
di appoggio di quella parte». In quella tradizione
iscriverà alcuni anni dopo
anche Badoglio, sottolineando la fermezza con cui aveva
saputo difendere, dopo
il «lungo armistizio», le ragioni della
dignità e dell’indipendenza nazionale??.
Questione cattolica e questione vaticana prima
e dopo il fascismo
Anche la questione vaticana, ovviamente, è legata
alla politica estera. Ma nella sua
reimpostazione piuttosto che il richiamo di tradizioni
utili, che non c’erano, prevalgono considerazioni
derivanti dalla nuova collocazione del PCI come partito
di
governo, dal ruolo di Togliatti nel comunismo internazionale
e dalla percezione
dei mutamenti che cominciavano a interessare la Chiesa
stessa.
Nelle Tesi di Lione la questione vaticana, insieme alla
questione meridionale,
costituiva una specificazione della «questione
contadina»??. Gramsci inquadrava
l’unità d’Italia nel «nesso
storico europeo», nel quale il Vaticano era stato
Gentiloni e della condanna del Modernismo, ancora inconciliata
con il liberalismo
e la democrazia??. Tuttavia, affinatasi nelle prove
della Grande Guerra e dell’avvento del fascismo,
la riflessione di Gramsci era stata attirata sia dalla
nascita del Partito popolare, sia dal suo precoce sacrificio
al fascismo, diversamente da quanto avveniva oltralpe
nei rapporti fra il Vaticano e l’Action française??.
Nel ???? Togliatti aveva dedicato uno scritto importante
alla Fine della “questione
romana”, nel quale concludeva che la Chiesa, al
pari di «tutti gli strati della
borghesia italiana», «era irresistibilmente
tratta ad unirsi al fascismo» per difendere
la società capitalistica. Tuttavia, egli non
negava che il Concordato fosse
uno strumento valido, in via di principio, per superare
l’opposizione vaticana
allo Stato unitario; né mancava di avvertire
che la collaborazione con il fascismo
avrebbe potuto essere «scontata dalla Chiesa con
una ribellione di masse
» di tipo ereticale e scismatico. Infine, presagiva
che «nel campo internazionale
» il fascismo non ne avrebbe tratto vantaggi «esageratamente
grandi, né di
lunga durata», perché la Chiesa si sarebbe
ben guardata «dal perdere quel carattere di universalità
che è la migliore garanzia della sua funzione
controrivoluzionaria nel mondo intiero». Sebbene,
incalzata dalla modernità, fosse obbligata a
rimodulare il suo ruolo e i suoi obiettivi, «per
la sua stessa struttura organica, per tutte le posizioni
ideali che essa difende e per lo scopo ultimo cui mira
tutta la sua attività», proseguiva Togliatti,
la Chiesa restava «la potenza più
“antidemocratica” del mondo»??. Quando
egli rientrò in Italia il mondo era cambiato.
Il Vaticano aveva avuto un ruolo attivo nella caduta
di Mussolini e nell’indurre il governo Badoglio
all’armistizio ??; nel radiomessaggio del Natale
???? Pio XII aveva iniziato il riorientamento della
Chiesa verso la democrazia ?? e il Vaticano era schierato
con la Grande Alleanza antifascista. Stalin aveva interrotto
le persecuzioni religiose, realizzato una solida alleanza
con la Chiesa ortodossa (risorsa essenziale della guerra
patriottica) e manifestato la volontà di riconoscere
la libertà religiosa??. Il ?? luglio ???? Togliatti
incontrò riservatamente monsignor Montini, segretario
di Stato provvisorio, e i loro contatti proseguirono
almeno fino alla fine del gennaio ???? avendo a oggetto
gli interessi della Chiesa sia in URSS e in paesi importanti
nei quali essa si era insediata, come la Polonia, sia
in Italia, dove il PCI appariva una garanzia per i futuri
assetti democratici. In quel momento al Vaticano Togliatti
interessava tanto come tramite con Mosca, quanto come
leader politico che aveva evitato all’Italia la
«prospettiva greca»??. Com’è
noto, Togliatti avviò un dialogo di ampio respiro
con il mondo cattolico, i cui cardini erano l’apertura
del partito ai cittadini di qualunque confessione religiosa
e la ricerca di un «patto di unità d’azione»
anche con la DC, basato sul programma di governo dei
partiti antifascisti ??. Questa strategia culminò
nel rapporto al V Congresso, nel quale Togliatti riconosceva
il valore dei Patti Lateranensi poiché avevano
dato una «soluzione definitiva alla questione
romana» e sul Concordato aggiungeva: «Questo
è per noi uno strumento di carattere internazionale
oltreché nazionale, e comprendiamo benissimo
che non potrebbe essere riveduto se non per interesse
bilaterale, salvo violazioni che portino una parte o
l’altra a denunciarlo»??. Si trattava di
una questione basilare per lo Stato italiano, sulla
quale il PCI non avrebbe mutato avviso con il mutare
della sua collocazione e quando la DC propose di inserire
il Concordato nella Costituzione esso, unico fra i partiti
di sinistra, votò l’art. ? per evitare
– affermava Togliatti – gravi minacce alla
pace religiosa. In seguito egli difese con forza quella
scelta perché era coerente con la «politica
di unità nazionale», perché la collaborazione
fra le masse comuniste, socialiste e cattoliche era
la base delle lotte per l’attuazione della Costituzione
e perché dopo il ?? aprile ???? il Concordato
aveva costituito persino un argine contro l’invadenza
clericale nella vita della società e dello Stato??.
È degno di nota che Togliatti informò
preventivamente il Vaticano del voto favorevole all’art.
?, il che prova che i contatti proseguivano malgrado
l’inizio della guerra fredda??.
Come dimostra anche il caso della ratifica del trattato
di pace, che il PCI favorì
poco dopo con la sua astensione quando era ormai fuori
dal governo??, i mutamenti intervenuti nella sua cultura
politica erano profondi ed è difficile spiegarli
senza risalire alla percezione delle novità originate
dalla guerra e alle revisioni in tema di dottrina della
guerra e concezione della democrazia a cui Togliatti
aveva atteso nel ventennio precedente.
Fra le maggiori novità Togliatti, caso raro fra
gli uomini politici del tempo,
percepì che l’invenzione della bomba atomica
mutava il carattere della guerra??.
Pertanto riteneva che l’avvento dell’era
atomica avrebbe inciso profondamente
anche sulla cultura, la collocazione e il ruolo della
Chiesa nel mondo. Quindi, anche
negli anni più aspri della guerra fredda e della
scomunica non rinunciò a proporre
un dialogo con le masse cattoliche in difesa della pace
e nel ????, collegandosi
alla proposta sovietica di una conferenza europea per
la sicurezza collettiva,
cercò di riaprire il dialogo anche con il Vaticano??.
Infine, quando giunse la distensione, ebbe un ruolo
attivo nella preparazione dell’incontro fra papa
Giovanni
XXIII e il genero di Chru&cëv Alexei Adjubej,
direttore dell’“Izvestija”, che
rappresentò il segnale più vistoso del
dialogo avviatosi fra il Vaticano e Mosca??.
Ma forse ancora più importante è la percezione
della portata storica del Concilio
Vaticano II, col quale, scrisse Togliatti, la Chiesa
poneva fine all’«età costantiniana
» e cessava di essere il baluardo della società
capitalistica??. Quelle analisi e
la persuasione sempre più convinta che il mutamento
della natura della guerra
imponesse un mutamento della concezione della politica,
originarono le innovazioni
più rilevanti della cultura politica del PCI:
l’approdo a una valutazione positiva
del «fenomeno religioso»?? e l’idea
della collaborazione fra credenti e non
credenti per prevenire i pericoli di una guerra e affrontare
insieme le nuove sfide
globali in nome della «comune umanità»??.
Il fascismo come problema storico
Togliatti elevò l’antifascismo a «dottrina
del rinnovamento della nazione italiana»,
il cui cardine era l’instaurazione di una «democrazia
progressiva»??. Essa consisteva
in un regime parlamentare basato sul ruolo eminente
dei partiti, la collaborazione
fra i partiti antifascisti al governo, una Costituzione
«programmatica» che
sancisse l’economia mista, la possibilità
di riforme di struttura e i diritti sociali di
un Welfare avanzato??. Come si vede, sono indirizzi
del tutto analoghi a quelli sui
quali si basò la ricostruzione negli altri paesi
dell’Europa occidentale. Contro l’ipotesi
di un sistema rappresentativo basato sui CLN Togliatti
optò per il modello
parlamentare e in seguito anche per questo sottolineò
che la «democrazia progressiva » era cosa
diversa dalla «democrazia popolare» instaurata
nei paesi dell’Europa centrale e orientale??.
In Italia si poneva il problema di «estirpare
le radici» non di un fascismo possibile, ma di
un «fenomeno politico» storicamente sperimentato:
un regime durato più di vent’anni, che
aveva portato il paese alla catastrofe. La “giustificazione
storica” della politica di unità nazionale
poggiava quindi sull’analisi del fascismo. Rispetto
agli sviluppi che Togliatti le aveva dato negli anni
Venti e Trenta??, l’accento cadeva ora sulle origini,
piuttosto che sul “regime”, e tendeva a
sottolinearne la funzione conservatrice sfocando l’attenzione
sui suoi aspetti di modernità.
Se ne capisce il perché: la modernizzazione dell’Italia
prevista dal “programma
dell’antifascismo” era antitetica alle modernizzazioni
del fascismo: prevedeva
la liquidazione del regime di bassi salari e di bassi
consumi che costituiva il
tratto distintivo del capitalismo italiano?? e il ribaltamento
del «regime autoritario
di massa»?? in una democrazia intensamente partecipata,
basata sulla mobilitazione sociale e sui partiti di
massa. Nel ribadire, quindi, il concetto basilare delle
Tesi di Lione, cioè che per spiegare «nascita
e avvento» del fascismo si doveva «risalire
alla struttura stessa della società e dello Stato
italiano», Togliatti spingeva lo sguardo molto
più indietro del Risorgimento: sulla scia dei
Quaderni del carcere, riandava ai limiti economico-corporativi
del protocapitalismo italiano, ricordava la crisi del
Seicento, sottolineava come l’Italia fosse rimasta
quasi del tutto estranea al secolo dei Lumi e nell’Ottocento
fosse stata un «paese arrivato alla restaurazione
senza avere avuto una vera e propria rivoluzione».
L’unificazione nazionale si era basata su un «blocco
industriale-agrario» nel quale l’elemento
industriale era debole, ristretto e permanentemente
condizionato da un elemento agrario semifeudale??. Ancor
più degno di nota, però, è che
a questa storia Togliatti facesse risalire un carattere
originario dell’«intelligenza italiana»,
alla quale attribuiva un ruolo decisivo nel fatto che,
nei momenti topici di crisi e di svolta del fascismo,
l’intera nazione avesse fatto blocco con esso??.
Anche questo filone di ricerca derivava dai Quaderni
e originava un’innovazione significativa nell’analisi
togliattiana del fascismo poiché ne ampliava
la ricognizione dei rapporti con la cultura italiana
e nell’agenda politica comportava un’attenzione
particolare alla «quistione politica degli intellettuali
». Il tema è di grande rilievo poiché
segnala un aspetto del «partito nuovo»,
al quale finora gli studi non hanno dato adeguata attenzione.
L’obiettivo di Togliatti non era solo quello di
creare un partito comunista di massa, ma anche di mutare,
attraverso la sua azione, i rapporti fra gli intellettuali
e il popolo-nazione. La “politica culturale”
ha una densità e un tratto specifico nella visone
togliattiana del partito poiché ne delimita le
capacità di direzione politica: non si può
assolvere una “funzione nazionale” senza
avere una grande influenza sulla cultura del paese.
Ma non possiamo approfondire qui questo problema. Tornando
ai temi di
questo paragrafo, Togliatti pose al centro delle sue
analisi la crisi della cultura italiana fra Ottocento
e Novecento e su di essa tornò ripetutamente
fino alla fine dei suoi giorni. Quanto al fascismo,
se, nella riflessione postbellica, la ricchezza delle
analisi del «regime reazionario di massa»
appare affievolita, tuttavia essa ispirò la politica
di «pacificazione nazionale» di Togliatti
??. Inoltre, essa era palesemente sullo sfondo dell’autocritica
che egli pronunciò nel ???? per non aver saputo
accostare le nuove generazioni fasciste e recepirne
i fermenti ideali e le nuove sensibilità, con
grave danno per la capacità dei comunisti di
lottare contro il
fascismo prima e per la costruzione del «partito
nuovo» dopo la sua caduta??. Il
tema del consenso al fascismo fu posto invece come problema
cruciale della ricerca
storica negli ultimi anni della sua vita, in una stagione
della politica italiana
profondamente mutata, nella quale Togliatti, come diremo,
non pensava più
all’unità antifascista come prospettiva
di governo ??. Palesemente insoddisfatto
per lo stato degli studi, egli promosse attraverso l’Istituto
Gramsci un convegno
storico sul fascismo di notevoli ambizioni, impegnandosi
a svolgere lui stesso una
relazione dedicata all’analisi e al dibattito
del Comintern sul fascismo; ma il convegno non si poté
realizzare perché egli non riuscì a preparare
la sua relazione??.
La crisi della cultura italiana fra Ottocento
e Novecento
Com’è noto, la principale risorsa intellettuale
della politica culturale di Togliatti fu
la pubblicazione degli scritti di Antonio Gramsci. Ad
essa egli affiancò un’opera
costante di lettura e interpretazione condizionata dall’evolvere
della lotta politica
in Italia e dalle vicende del comunismo internazionale??.
Il pensiero di Gramsci agì
come chiave di lettura della crisi della cultura italiana
fra Ottocento e Novecento,
e al tempo stesso come reagente della sua risoluzione.
La «questione» degli intellettuali aveva
un rilievo così grande nella politica di Togliatti
poiché egli condivideva il pensiero di Gramsci
che, fin dagli anni Venti, «riconosceva»
in loro «il tessuto connettivo della società
italiana attraverso i secoli»??. Essi dunque avevano
avuto e continuavano ad avere un ruolo determinante
nell’unificazione della nazione e nella vita dello
Stato. L’interpretazione della crisi culturale
che aveva favorito l’avvento del fascismo venne
proposta in modo definitivo nel discorso dedicato a
Gramsci Pensatore e uomo d’azione il ?? aprile
???? nell’aula magna dell’Università
di Torino. Se le correnti ideali prevalenti nella prima
metà dell’Ottocento avevano fatto lega
con «i principi, la chiesa e i proprietari feudali»
per «limitare le ripercussioni in Italia della
Rivoluzione francese»??, la cultura positivistica
che aveva preso il sopravvento dopo l’unità
aveva avuto una funzione benefica fornendo l’humus
al primo socialismo italiano, ma al tempo stesso ne
aveva segnato la debolezza: l’evoluzionismo, il
fatalismo e l’incapacità di elaborare una
propria visione della storia d’Italia e una concezione
soggettivistica della politica e della storia.
Il socialismo italiano aveva avuto un ruolo decisivo
nel promuovere l’unità della
nazione e la cultura positivistica era stata un tramite
essenziale fra intellettuali e popolo.
Ma il movimento socialista non aveva avuto pensatori
di rilievo e Antonio
Labriola, il suo unico intellettuale europeo, ne era
rimasto ai margini come una figura isolata. Onde il
socialismo non era riuscito a elaborare un programma
di rinnovamento e di riforma della nazione italiana.
La rinascita idealistica aveva avuto un ruolo progressivo
nel provocare la dissoluzione del positivismo: aveva
promosso una visione “energica”, laica e
immanentistica della realtà e della storia. Ma
il suo obiettivo principale era stato quello di sbarrare
la strada al marxismo, espungendo Labriola dal movimento
del pensiero italiano del secondo Ottocento come un
corpo estraneo. Perciò la crisi del positivismo
aveva creato un vuoto nei rapporti fra gli intellettuali
e le masse popolari, nel quale avevano fatto irruzione
le
correnti più congeniali al nazionalismo e al
nascente imperialismo italiano: vitalismo, irrazionalismo,
filosofie dell’azione. Così era stata incapsulata
e travolta anche quella scuola “economico-giuridica”
che aveva dato vita a un indirizzo di studi storici
e sociali molto promettenti, ai quali aveva attinto
il giovane Gramsci. Nel complesso la riforma dell’hegelismo
di fine Ottocento aveva avuto dunque un segno di conservazione
e di reazione; e se dinanzi ai suoi sviluppi estremi
e indesiderati Croce si era tirato indietro cercando
di farvi argine, durante il fascismo la sua voce autorevole
non aveva costituito molto più che una testimonianza.
Col fascismo, invece, aveva fatto lega Gentile, condividendone
fino all’ultimo il destino.
Alla caduta del fascismo Croce e Gentile si stagliavano
ancora come le figure
dominanti della cultura italiana e della sua crisi.
I Quaderni del carcere prefiguravano quindi una riforma
dei suoi indirizzi che – secondo quanto Gramsci
stesso aveva scritto – doveva costituire sia un
«anti-Croce», sia un «anti-Gentile
». Si trattava di rifare con l’idealismo
italiano l’operazione che Marx aveva fatto
con la filosofia di Hegel. Essa non poteva prendere
le mosse da Croce e da Gentile, ma dalle correnti del
liberalismo rivoluzionario del Risorgimento; quindi,
da De Sanctis e da Spaventa.
Già nella conferenza pisana del ???? Togliatti
aveva indicato in Bertrando
Spaventa «il più grande filosofo [italiano]
del secolo passato» e nel suo scritto
sulle prime categorie della logica di Hegel l’appiglio
di una riforma della dialettica
hegeliana, che aprisse la strada alla filosofia della
praxis??. Ma una genealogia
del marxismo in Italia non era stata ancora tentata
e Togliatti vi si applicò egli
stesso nel saggio dedicato ad Antonio Labriola nel ??????.
In esso sottolineava
l’ambivalenza della filosofia di Spaventa, aperta
a uno sviluppo in direzione sia
dell’attualismo, sia della filosofia della praxis,
ma considerava coerente con l’indirizzo del suo
pensiero solo quest’ultima e ad essa collegava
il cammino percorso da Labriola, mentre considerava
la riforma attualistica un travisamento. Ma in questa
sede conta di più sottolineare che in quel saggio
Togliatti rendeva esplicito il debito del suo programma
di ricerca con il modo in cui Spaventa aveva impostato
il tema della «circolazione europea della filosofia
italiana del Rinascimento ». Bertrando Spaventa
aveva elaborato il suo programma scientifico per fare
della penetrazione di Hegel la base di un’egemonia
culturale che cementasse l’unità della
nazione ??, ma dinanzi alla prospettiva della filosofia
della praxis si era arrestato. L’importanza di
Labriola nella cultura italiana del secondo Ottocento
stava quindi nel fatto che con lui quel passaggio era
avvenuto e, con lo sviluppo che Gramsci aveva dato al
marxismo, erano poste le basi di una nuova egemonia,
promotrice di una unità della nazione diversa
e più piena: un’egemonia
culturale che mirava a mettere fine alla frattura fra
intellettuali e popolo??.
Il rinnovamento e l’apertura della cultura italiana
alla cultura internazionale
seguirono vie diverse da quelle auspicate da Togliatti.
Negli ultimi anni della sua
vita, quindi, egli pensò a un nuovo progetto,
che esordisse dall’elaborazione teorica
e dalla generalizzazione dell’esperienza ormai
quarantennale del PCI??. Ma il movimento comunista internazionale
era ormai in crisi e Togliatti lo percepiva acutamente
??. D’altronde, a chi si sarebbe potuto affidare
un compito di tanta mole?
Un capitalismo di bassi salari e bassi consumi
Col passare del tempo la «politica di unità
nazionale», la Resistenza e la guerra di
liberazione divennero oggetto di riflessione storica
e da esse Togliatti partì nel formulare i suoi
giudizi sui primi due decenni della democrazia repubblicana.
Alla
“politica di Salerno” egli attribuiva il
merito della rinascita del paese: non solo per-
ché aveva evitato la “prospettiva greca”,
ma anche perché, con l’ingresso dei partiti
antifascisti, il governo Badoglio aveva unificato l’“Italia
libera” e il Nord partigiano,
ponendo le basi per un rapido sviluppo della Resistenza
e l’esito vittorioso
della guerra di liberazione. L’accantonamento
della questione istituzionale era
stata la premessa essenziale e l’aver posto la
sua decisione nelle mani del popolo
aveva costituito sia l’atto di nascita della democrazia
postfascista, sia la via più efficace per giungere
all’eliminazione di casa Savoia. L’enfasi
con cui Togliatti giudicava i risultati della politica
di Salerno era giustificata da considerazioni che mi
sembra opportuno ricordare: quella politica era stata
osteggiata, con intenti diversi,
sia dalle truppe di occupazione britanniche, sia da
quelle americane; aver
raggiunto gli obiettivi prestabiliti era stato quindi
un atto di recupero della dignità
e dell’indipendenza nazionale. Essa aveva consentito
all’Italia di guadagnare un
trattamento diverso e migliore di quello che spettò
alla Germania e al Giappone
alla fine della guerra. Inoltre, la «democrazia
progressiva», recepita dalla Costituzione, aveva
avviato la sperimentazione di una nuova via di avanzata
al socialismo basata su una democrazia parlamentare:
la prima tentata in Europa occidentale (anche perché
l’Italia era uscita per prima dalla guerra) e
l’unica adatta a paesi capitalistici sviluppati
di tradizione parlamentare consolidata.
Per queste ragioni la guerra fredda e la fine dei governi
di unità nazionale
non avevano interrotto il processo costituente e, grazie
alla collaborazione fra comunisti, socialisti, azionisti
e sinistra democristiana, era stato possibile inserire
nella Costituzione il programma di riforme economiche
più avanzato d’Europa??.
Per contro, grazie anche alla pressione delle truppe
di occupazione, il programma
riformatore della Resistenza era stato bloccato e la
ricostruzione si era risolta
in una «restaurazione dell’economia italiana
com’era sotto il fascismo».
Con tale giudizio Togliatti intendeva il ripristino
del vecchio modello di sviluppo
fondato su bassi salari e bassi consumi. Fra il ????
e il ???? l’ispiratore della
politica economica di De Gasperi era stato Luigi Einaudi,
fautore di un “liberismo
dottrinario”. Questo aveva condizionato anche
il piano delle riforme successive:
una riforma agraria stentata, che lasciava in vita i
vecchi patti agrari, e una
regolazione discrezionale dell’economia pubblica
che, malgrado la sua crescita
impetuosa, ne ribadiva la funzione di puntello dell’accumulazione
monopolistica
privata e apriva la strada a un dilagante sistema di
corruzione.
L’Italia del primo decennio repubblicano era dunque
il risultato d’una combinazione
contraddittoria fra la continuità delle strutture
economiche, rafforzata
dalla continuità burocratica dello Stato centralistico,
e la discontinuità del sistema
politico, caratterizzato invece dallo sviluppo dei partiti
di massa e dell’azione
sindacale (le riforme avviate da De Gasperi nel ????
erano considerate una
risposta al piano del lavoro della CGIL e alla mobilitazione
sociale promossa dalle
sinistre), sorretti dal radicamento dell’antifascismo
fra strati sempre più ampi
delle masse popolari.
In questa visione s’inquadrava il giudizio sull’azione
politica di De Gasperi.
Della “restaurazione capitalistica” egli
non era stato certo il solo responsabile.
Tuttavia, Togliatti gli attribuiva la colpa di aver
plasmato la DC come «partito
di fiducia della borghesia» e di aver subito i
condizionamenti della Chiesa pa-
celliana e della destra cattolica (comitati civici,
“operazione Sturzo”). Infine, gli
addossava la responsabilità di aver reintrodotto,
con l’anticomunismo, col «processo alla
Resistenza» e con la repressione dei conflitti
sociali, i metodi di governo tradizionali della borghesia
italiana. Onde il paese era oppresso da una
perdurante offensiva clericale e dal prevalere di umori
reazionari nello spirito
pubblico. Chiave di volta del suo sistema di governo
era l’unità politica dei cattolici,
decisa dal Vaticano ma fortemente voluta anche da De
Gasperi poiché il consenso
della DC era condizionato dal sostegno delle gerarchie
ecclesiastiche. Ma
in un paese caratterizzato da una forte polarizzazione
sociale tanto sui temi della
politica economica, quanto su quelli della politica
internazionale, si generavano
tensioni e fratture fra l’indirizzo politico dei
governi centristi e le masse popolari:
il “blocco” del ?? aprile si incrinava e
De Gasperi tentò di mantenere «il
monopolio politico della DC» con la legge maggioritaria
del ????. Essa assegnava
un premio di maggioranza così ampio che, in caso
di vittoria, la DC avrebbe
potuto cambiare la Costituzione unilateralmente. Togliatti
ricorda che De Gasperi
non volle accogliere proposte di negoziato sulla misura
del premio di maggioranza
lasciando così alle opposizioni l’opportunità
di allargare le alleanze su
un terreno a loro favorevole. Fu un errore fatale che
portò alla sconfitta della
“legge truffa” e alla fine politica del
leader democristiano. Insomma, egli scrive,
sebbene saldamente antifascista, De Gasperi aveva nello
spirito e nella cultura i
tratti del «notabile reazionario» e questo
ne faceva il fautore di una democrazia
ben più ristretta di quella disegnata nella Costituzione.
Quest’ultima era rimasta
«inapplicata» mentre De Gasperi aveva operato
per realizzare una «democrazia
protetta», costretta nel letto di Procuste della
«strategia della dipendenza
»?? sia dagli Stati Uniti d’America che
dal Vaticano. Il giudizio di Togliatti sull’opera
politica di De Gasperi non appare certo «equanime»,
come il titolo del
saggio che gli dedicò nel primo anniversario
della morte prometteva; ma non è
questa la sede per sottoporre a critica storiografica
le sue valutazioni. Gli si può
riconoscere comunque il merito di aver interpretato
la politica di De Gasperi alla
luce dei problemi della storia d’Italia, senza
enfatizzarne troppo il condizionamento
internazionale??.
Le classi popolari dal Risorgimento alla Repubblica
Togliatti percepì per tempo la crisi del centrismo
e favorì la politica di movimento
di Nenni in vista dell’“apertura a sinistra”??.
Non si può dire, invece, che fosse
avvertito di quanto avveniva nell’economia italiana,
che sfociò nel “secondo miracolo economico”
del ????-??. Il PCI dovette aggiornare in fretta la
sua analisi e
ne tirò le conclusioni agli inizi del centro-sinistra.
Il mutamento era stato impo-
riconobbe che stavano cambiando alcuni caratteri originari
dell’economia italiana:
È la prima volta nella storia del nostro paese,
in tutta la storia della borghesia italiana, che essa
è riuscita a raggiungere livelli di competitività
internazionale e può quindi presentarsi nell’arena
della concorrenza internazionale con posizioni, se non
sempre di vantaggio, perlomeno di parità con
le altre borghesie di struttura storicamente più
forte??.
Partendo da qui il PCI procedette a un rinnovamento
programmatico il cui cardine
era – come già nel ????-?? – un’economia
di alti salari e alti consumi. Ma, a
differenza di quindici anni prima, l’obiettivo
sembrava più realistico. L’Italia era
avviata verso la piena occupazione. La “programmazione
democratica”, l’industrializzazione del
Mezzogiorno, la riforma dei patti agrari, la riforma
urbanistica, fiscale, della scuola e dell’università,
la realizzazione dell’ordinamento regionale e
di un Welfare moderno costituivano i punti di un programma
condiviso da un arco di forze molto ampio. Esso comprendeva
tutto il movimento sindacale, i
comunisti, i socialisti, i socialdemocratici, i repubblicani
e la sinistra cattolica.
Con i due convegni di San Pellegrino e il congresso
di Napoli (????, segretario
Aldo Moro), quel programma venne assunto anche dalla
DC e posto a base
dell’«esperimento di centro-sinistra»??.
Nascendo sul presupposto della «delimitazione
della maggioranza a sinistra
», secondo Togliatti la nuova formula politica
poteva risolversi in una «manovra
trasformistica» oppure «essere l’inizio
di un rinnovamento» destinato a
sfociare in «una svolta a sinistra della politica
nazionale»: molto dipendeva dall’iniziativa
del PCI e ancor di più dall’azione delle
masse popolari che condividevano il programma del centro-sinistra??.
Sul piano parlamentare il PCI decise quindi di esercitare
un’opposizione «di tipo particolare»:
la nazionalizzazione
dell’energia elettrica venne approvata con il
suo voto determinante ??. Nella mobilitazione di massa
esso faceva leva sulle rivendicazioni operaie, che ormai
andavano oltre il salario e si estendevano all’organizzazione
del lavoro, al potere
sindacale in fabbrica e alle riforme sociali. Nell’iniziativa
politica Togliatti mirò
a rafforzare l’unità tra le forze che condividevano
il programma riformatore
enunciando con chiarezza i suoi obiettivi: innanzitutto,
egli affermava, quel
complesso di forze era lo stesso che con la sua unità
aveva consentito di elaborare
la parte più avanzata della Costituzione riguardante
la programmazione
economica e i diritti sociali; in secondo luogo, ci
si poteva rifare al precedente
storico significativo che quella unità non era
venuta meno ma aveva continuato
a operare anche dopo che le sinistre erano state estromesse
dal governo, fino al
????. Ad ogni modo, ora il PCI non mirava più
alla formazione di governi di unità
antifascista, poiché non si trattava di «distruggere
le radici del fascismo», ma di
realizzare riforme di struttura di un capitalismo ormai
avanzato, maturo per l’introduzione di «elementi
di socialismo». Non era pensabile, quindi, realizzare
quel programma senza scalzare «il monopolio politico
della DC»: vale a dire determinando un mutamento
di equilibri politici e sociali così ampio e
profondo
da mettere in crisi l’unità politica dei
cattolici ??.
Questa prospettiva si basava su una visione dei primi
due decenni dell’Italia
repubblicana, secondo la quale nel ????-?? il moto riformatore
avviato dalla Resistenza era stato interrotto, ma non
vinto, grazie soprattutto al PCI che nel quindicennio
successivo aveva diretto l’azione delle classi
popolari in modo tale che
non smarrissero la funzione nazionale e la capacità
di iniziativa sui temi essenziali
dello sviluppo democratico del paese, conquistate nella
Resistenza e nella fase costituente della Repubblica:
Sono venti anni – scriveva Togliatti nell’editoriale
del primo numero di “Rinascita” settimanale
– che si combatte, in Italia. Vent’anni
che due forze avverse, l’una di progresso e rivoluzione,
l’altra di conservazione e reazione, si affrontano
e misurano in un conflitto che ha avuto le più
diverse fasi, nessuna delle quali, però, si è
conclusa in modo tale che potesse significare il sopravvento
definitivo dell’uno o dell’altro dei contendenti
[...]. Il gigante
dell’energia popolare non ha potuto essere messo
a terra [perché le classi popolari] sono diventate,
in un momento decisivo della storia nazionale e della
vita dello Stato italiano, protagoniste di questa vita
e di questa storia. Sono le classi popolari che hanno
fondato lo Stato italiano odierno. Esse e non il vecchio
ceto dirigente e privilegiato, hanno organizzato e diretto
la Resistenza, la guerra di liberazione, la conquista
di un regime di democrazia e di progresso. Da questo
dato di fatto parte e sopra esso si fonda tutta la situazione
del nostro paese. Ed è un dato che non muta,
che conserva tutto il suo valore, nonostante
le trasformazioni profonde che la situazione subisce??.
Retrospettivamente, queste valutazioni presupponevano
un raffronto fra la Resistenza e il Risorgimento, al
quale Togliatti applicava la categoria gramsciana di
«rivoluzione passiva». L’occasione
gli era stata fornita dalla conferenza tenuta a
Torino, in un ciclo di lezioni intitolato Il Risorgimento
e noi. Nella sua conferenza,
dal titolo Le classi popolari nel Risorgimento, Togliatti
svolse un’ampia argomentazione contro la tesi
storiografica di Rosario Romeo che attribuiva a Gramsci
l’interpretazione del Risorgimento come «rivoluzione
agraria mancata»??. Il
discorso di Togliatti si concludeva accogliendo il parallelo
fra il Risorgimento e
la Resistenza, ma, a proposito della definizione di
questa come «secondo Risorgimento», puntualizzava
che, più che una reiterazione, la Resistenza
aveva rappresentato una «correzione» del
Risorgimento poiché con essa, per la prima volta
nella storia d’Italia, le classi popolari avevano
assunto un ruolo predominante
nella fondazione e nella vita del nuovo Stato.
I temi affrontati dal centro-sinistra interessavano
tutte le forze politiche rappresentative del movimento
operaio e avrebbero dovuto vedere la loro partecipazione
solidale al governo del paese. Nel IX e X Congresso
del partito Togliatti riprendeva, perciò, sia
pure con molta cautela, il tema del «partito unico»
fra comunisti e socialisti, che aveva costituito oggetto
di una relazione specifica di Longo al V Congresso.
Il tema era ripreso anche come antidoto a una possibile
rottura totale dei rapporti unitari fra comunisti e
socialisti (nel sindacato, nei “comuni rossi”,
nella Lega delle cooperative) e contraltare alle pressioni
del PSDI, dei repubblicani e della DC che ne sollecitavano
la «deriva centrista». Esso aveva dunque
una funzione eminentemente tattica poiché il
progetto del partito unico, se
fosse stato realizzato, avrebbe significato prima o
poi l’assorbimento del PCI in un
partito socialdemocratico ed è dubbio che Togliatti
ritenesse questa prospettiva
auspicabile o soltanto possibile. Ad ogni modo, va annotato
che il tema non venne
ignorato.
Inoltre, riprendeva il confronto fra comunismo e riformismo
insistendo, come
nel ????-????, sul concetto che il nodo della discussione
non riguardava il gradualismo o la via parlamentare,
metodo e prospettiva condivisi da entrambi, bensì
la concatenazione delle riforme “parziali”
in un unico disegno e in un unico
processo di riforme della società e dello Stato??.
Spingendosi ancora più innanzi
nel confronto, egli quindi esplicitava i presupposti
riformistici della «via italiana
al socialismo»; e nel rapporto al X Congresso
chiariva che la prospettiva prescelta
dal PCI era quella del socialismo processo: È
evidente che nell’accettare questa prospettiva,
che è quella dell’avanzata verso il socialismo
nella democrazia e nella pace, noi introduciamo il concetto
di uno sviluppo graduale, nel quale è assai difficile
dire quando, precisamente, abbia luogo il mutamento
di qualità ??.
Ovviamente un’evoluzione riformistica del quadro
politico ed economico italiano
non dipendeva solo dal PCI, ma soprattutto dalla disponibilità
delle classi
dirigenti a riconoscere la legittimità del movimento
operaio come forza di governo,
e questa possibilità, che nella storia d’Italia
non si era mai data, non veniva
presa in considerazione neppure allora. Com’è
noto, prendendo a pretesto
una non grave inversione del ciclo economico internazionale,
agli inizi del ????
il ministro del Tesoro e la Banca d’Italia misero
l’alt al programma riformatore
del centro-sinistra, condannando la formula politica
al fallimento. Il modello di
sviluppo fondato sui bassi salari e i bassi consumi
doveva essere preservato; i caratteri originari del
capitalismo italiano non ammettevano “riforme
di struttura”.
L’ultimo editoriale di “Rinascita”
conclude, quindi, la riflessione di Togliatti
sulla storia d’Italia proprio su questo nodo,
lasciando aperti interrogativi di fondo
quanto mai dilemmatici: In quale misura i gruppi dirigenti
della grande borghesia italiana, industriale e agraria
sono disposti ad accogliere anche solo un complesso
di modeste misure di riformismo borghese?
In quale misura, cioè, è possibile, in
Italia, un riformismo borghese? Invitiamo gli
studiosi di storia e di economia ad approfondire questa
questione, che è di decisiva importanza non tanto
per giudicare il passato quanto per tracciare le linee
di una prospettiva.
La questione è strettamente collegata a quella
delle sorti di un partito socialdemocratico, che in
Italia non è mai riuscito ad avere la stessa
parte che in altri paesi europei, e degli altri partiti
di lavoratori. |