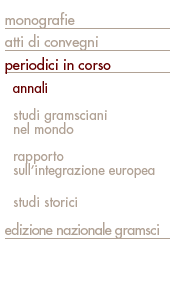|

|

|
 |
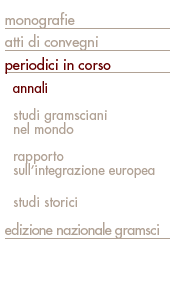

|
| <–
torna
indietro
|
|
ANNALE IV
Guida agli archivi
della Fondazione Istituto Gramsci di Roma
a cura di Linda Giuva
Roma, Editori Riuniti,
1994
p. 289, L. 40.000
ISBN 978-88-359-3891-0 |
| |
Introduzione
di Linda Giuva
La formazione del settore archivi della Fondazione Istituto
Gramsci è al momento dell'istituzione della Fondazione
stessa. Essa è legata alle vicende dell'archivio
del Pci e all'atteggiamento politico e culturale maturato
verso la propria memoria scritta da parte del gruppo dirigente
comunista.
Sin dal primo progetto approvato dalla segreteria del
Pci nell'ottobre del 1948 – due anni prima della
costituzione dell'Istituto – tra gli scopi della
Fondazione era indicato quello del recupero della documentazione
archivistica relativa al movimento operaio italiano conservato
a Mosca presso l'Istituto Marx-Engels-Lenin-Stalin. La
formulazione di tale obiettivo era generica e non si faceva
alcun esplicito riferimento all'archivio del Pcd'I che
si trovava lì depositato, ma il dato più
rilevante da cogliere è che nella carta d'intenti
fondativa la formazione di un settore che si occupasse
del recupero e della conservazione di documentazione archivistica
aveva un posto di dignità pari a quello degli altri
settori e campi d'intervento della Fondazione. In realtà
nel corso degli anni cinquanta, da Mosca non provenne
nulla. L’attività di conservazione si concentrò
sul periodo della Resistenza e fu rivolta a reperire e
versare presso la sede dell'Istituto le carte delle Brigate
Garibaldi, della Direzione Nord del Pci e ad avviare il
lavoro di recupero delle carte di Antonio Gramsci. Parallelamente
a quest’azione, la Fondazione, insieme alla segreteria
del Pci, lanciò un appello alle organizzazioni
periferiche affinché si impegnassero nella raccolta
di fonti documentarie da affidare alla Fondazione. lnterlocutori
privilegiati dovevano essere i vecchi militanti, comunisti,
socialisti, anarchici, che conservavano materiali salvati
dalle persecuzioni e devastazioni fasciste. L’appello
al recupero di tale documentazione avvenne a ridosso della
decisione di istituire una commissione per definire un
progetto di storia del Pci, ma esso andava al di là
di questa circostanza, pur abbastanza significativa. Esso
riproponeva quello che è un aspetto costante e
costitutivo della tradizione del comunismo italiano vale
a dire la centralità della memoria storica nella
costruzione dell'identità politica.
Nell'obiettivo di costituire un centro, identificato con
la Fondazione, ove fosse possibile raccogliere, conservare,
mettere a disposizione degli studiosi tale materiale «prezioso
per la storia del movimento operaio, per la storia del
partito, per la storia stessa d'Italia», è
possibile individuare, inoltre, quelli che furono i punti
intorno ai quali avrebbe ruotato negli anni successivi
il dibattito storiografico di ispirazione marxista: nesso
tra storia del movimento operaio e storia d'Italia, importanza
del lavoro filologico e quindi della base documentaria
nella ricerca storica, problema dell'accesso alle fonti
vale a dire della consultabilità dei documenti
di partito.
Sin dalla costituzione, quindi, si delinea quella che
sarà, dal punto di vista organizzativo, una caratteristica
del settore archivi della Fondazione: il suo essere, da
una parte, luogo di concentrazione di archivi veri e propri,
dall'altra, centro di raccolta di documentazione di varia
provenienza.
Gli anni sessanta rappresentano un salto di qualità.
Ancora una volta l'occasione fu fornita dai lavori di
una commissione costituita per celebrare il 40° anniversario
della fondazione del Pci. Nella definizione del programma
delle iniziative, tutte rivolte a ripercorrere le tappe
più significative della storia del partito, si
affermava la necessità di fare riferimento a un
corpus documentario più preciso e circoscritto.
Per la prima volta si usciva dai generici appelli per
la raccolta di fonti e si parlava di archivio di partito.
In particolare, nella riunione dei responsabili delle
riviste chiamate a elaborare i progetti editoriali relativi
alla celebrazione dell'anniversario, svoltasi il 15 dicembre
1960, si chiedeva «un centro di raccolta del materiale
fino al 1926; [ ... ] un'indagine a Mosca, presso l'archivio
del Pci, per vedere cosa c'è; una raccolta del
materiale dal dopoguerra a oggi. L’indicazione emersa
in tale occasione venne fatta propria dalla segreteria
del partito che il 28 febbraio 1961 decise di incaricare
Franco Ferri, allora direttore dell’Istituto Gramsci,
e Luigi Amadesi «per un primo lavoro sull'archivio
a Mosca». Il lavoro durò più anni
e si concluse con il ritorno in Italia, seppure in copia,
di quella parte dell'archivio del Pcd'I che, durante gli
anni Venti e Trenta, era confluita a Mosca nell'archivio
della Terza internazionale. Un ruolo decisivo in tale
operazione venne svolto da Togliatti il quale, nel 1960,
pubblicò per la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
documenti relativi alla formazione del gruppo dirigente
comunista tra il 1923 e il 1924 provenienti dall'archivio
del Pcd'I conservato a Mosca (oltre che dall'archivio
Tasca conservato presso la Feltrinelli), fornendo, in
tal modo, l’input per l'avvio di una storia del
partito fondata su solide base documentarie.
La seconda metà degli anni Settanta segnò
un'altra tappa significativa del processo che ha portato
alla formazione del nucleo relativo all'archivio del Pci
presso la Fondazione Istituto Gramsci. Il problema non
era più l'archivio del Pcd'I, ampiamente consultato
e utilizzato dagli storici, ma quello del secondo dopoguerra,
conservato presso la sede di Botteghe oscure. Qui, alla
fine degli anni Sessanta, si era avviata l'organizzazione
di un vero e proprio archivio stabilendo un titolario
per l'archivio corrente e la definizione di un progetto
per l'ordinamento di quello storico. Dal dibattito sviluppatosi
durante la seduta della direzione del partito del 10-11
gennaio 1974, e dalle decisioni prese dalla stessa, si
traggono alcune importanti informazioni. Innanzitutto
si registra uno spostamento dell'attenzione verso il secondo
dopoguerra che darà luogo, successivamente, al
versamento presso la Fondazione di un intero fondo, le
Federazioni. Inoltre, dopo aver stabilito alcune regole
per la consultazione, venne lanciato un appello ai dirigenti
comunisti affinché affidassero le proprie carte
all'archivio del partito. Tale richiesta si poggiava sulla
convinzione che l'elaborazione e l'azione dei singoli
acquistassero significatività storica e politica
in quanto parte integrante dell'elaborazione e dell'azione
collettiva del partito.
È da questo momento
che arrivarono alla Fondazione, in anni diversi determinati
dalle vicende biografiche dei singoli, gli archivi dei
più importanti dirigenti comunisti. A questo proposito,
è necessario fare alcune osservazioni che ci aiutano
a comprendere la fisionomia di quegli archivi. La concezione
prevalente era che un dirigente non poteva trattenere
tra le proprie carte i documenti di partito. La conservazione
di quelle ultime in un posto diverso dall'archivio del
partito stesso era considerata un depauperamento del patrimonio
archivistico e una forma di soggettivismo non accettabile.
Tale regola è stata sempre condivisa anche da quei
dirigenti che avevano forti il senso e la consapevolezza
del proprio valore. Pertanto, è raro trovare tra
le carte di personaggi quali, Grieco, Sereni, Amendola
documenti di partito. Le eccezioni a questo comportamento
– costituite, per esempio, da Tasca e Secchia –
confermano il principio generale che si è cercato
di esporre: la presenza di documenti più propriamente
di partito all'interno di un archivio personale sottolinea
la rottura politica e la divaricazione dell'esperienza
personale da quella del soggetto collettivo.
Comunque, nonostante questi importanti passi in avanti,
bisognerà aspettare la fine degli anni Ottanta
perché il rapporto tra archivio storico del Pci
e Fondazione acquisti un carattere meno episodico e più
«istituzionalizzato». Fino a quella data,
l'arrivo di materiale da Botteghe oscure era regolato
dalle richieste che, di volta in volta, avanzavano singoli
studiosi su particolari argomenti. I documenti erano selezionati
dagli archivisti del Pci, senza che la Fondazione avesse
la possibilità di conoscere i criteri in base ai
quali veniva operata la scelta. Con la decisione della
direzione del 1986, resa pubblica nel 1988, la situazione
cambiava radicalmente e dal Pci iniziava il versamento
integrale, anche se ancora in copia, del proprio archivio
storico del secondo dopoguerra a partire dai fondi più
«politici» vale a dire le carte prodotte dagli
organismi dirigenti centrali. Ciò spiega il carattere
disomogeneo, sia nella consistenza che nella «serialità»),
dei diversi fondi, successivi al 1944, presenti nella
Fondazione.
L’idea di procedere alla elaborazione di una guida
agli archivi conservati presso la Fondazione Istituto
Gramsci di Roma prese corpo nell'ormai lontano 1989. Con
la decisione della direzione del Pci dell'anno precedente,
si erano create le condizioni che rendevano matura l'impresa.
Il primo fondo che arrivò all’istituto fu
quello dei verbali della direzione a partire dal 1944
e subito si accese intorno a questi documenti l'attenzione
degli storici e dei giornalisti che affollarono la sala
studio della Fondazione. Alla direzione dell'Istituto
– da 1988 affidata a Giuseppe Vacca – non
sfuggì la portata del cambiamento che l'arrivo
di questa nuova documentazione comportava, trasformando
il ruolo svolto dalla sezione archivi nell'ambito dell'organizzazione
e delle iniziative dell'istituto. Non si trattava solo
di un mero incremento quantitativo ma del fatto che per
la prima volta l'intero archivio storico del Pci si ricomponeva:
ai documenti provenienti da Mosca e relativi agli anni
1921-1943 si aggiungevano quelli del secondo dopoguerra,
creando le condizioni per una lettura più completa
e ricca di tutta la vicenda storica del Pci. Inoltre,
l'essere il depositario dell'archivio storico di un partito
politico imponeva all'Istituto l'assunzione di una precisa
responsabilità nei confronti dell'intera comunità
scientifica nazionale e internazionale garantendo la massima
trasparenza nella gestione di questo patrimonio. Due furono
le decisioni prese dalla Fondazione per fare fronte a
queste esigenze. La prima fu la formulazione di un regolamento
che definisse in maniera chiara i termini della consultabilità
degli archivi. Ciò fu fatto tenendo conto delle
legittime richieste di tutela della riservatezza avanzate
dai proprietari degli archivi conservati nella Fondazione
e di massima liberalità dell’accesso alla
consultazione presentate dalla comunità degli storici?
La seconda fu quella di procedere all'elaborazione di
una guida agli archivi. Quest'ultima si presentava, infatti,
come un'operazione culturale in grado di soddisfare molteplici
richieste: fornire agli studiosi uno strumento di consultazione
e di orientamento; garantire all’utenza l'esercizio
di un diritto di controllo nel rispetto dei limiti di
consultabilità sempre presenti nelle realtà
archivistiche; valorizzare il patrimonio conservato dalla
Fondazione contribuendo così ad attivare quella
circolarità che è propria del rapporto tra
ricerca e strumenti della ricerca; stimolare nuove domande
a vecchie fonti e aprire nuovi campi di lavoro storiografico.
Esiste ormai un'ampia gamma di tipologie di guide archivistiche
generali, particolari, settoriali, tematiche, topografiche.
All'interno di ciascuna tipologia, diversi e vari sono
i criteri che possono essere adottati per la collocazione
e la descrizione del patrimonio archivistico; la scelta
del metodo dipende dagli obiettivi che si vogliono raggiungere,
dal tipo di archivi su cui si opera, dall'impostazione
cultura di chi esegue il lavoro. Dopo aver analizzato
i diversi fattori che concorrono alla definizione di una
metodologia di lavoro, è maturata la scelta di
adottare il modello elaborato e applicato nella Guida
generale degli Archivi di Stato italiani. E questo essenzialmente
per due considerazioni. Innanzitutto perché abbiamo
ritenuto che uno strumento descrittivo che dia conto soprattutto
della struttura ovvero dalla forma assunta dalla sedimentazione
delle carte «conserva il massimo della polisemia
intrinseca all'archivi» e dà la possibilità
di soddisfare un’utenza più ampia di quella
che potrebbe riconoscersi in guide tematiche o troppo
tagliate sulla descrizione del contenuto degli archivi.
Infatti, per quanto analitica e precisa quest'ultima possa
essere, vi è sempre una selezione soggettiva basata
sull'interpretazione di chi effettua la descrizione. La
seconda considerazione ha la valenza di una sfida. È
possibile esportare l'esperienza della Guida generale,
maturata e sperimentata prevalentemente su archivi di
organi statali, adattandola a realtà archivistiche
di diversa tipologia e formazione? I criteri descrittivi
adottati per la Guida generale possono esercitare il ruolo
di modello per una normalizzazione di questo specifico
strumento di ricerca? La risposta a questi interrogativi
è stata positiva. È necessario precisare,
però, che il modello della Guida generale non è
stato applicato rigidamente. I principi mutuati da quell'esperienza,
così importante per gli archivisti italiani e non,
possono essere riassunti in alcuni punti: a) adozione
del criterio della rappresentazione della struttura archivistica
con le sue articolazioni e gerarchie; b) coerenza e omogeneità
dei livelli descrittivi; c) differenziazione costante
delle aree descrittive all'interno dei fondi. A questi
principi, che potremmo definire di orientamento per la
fase di progettazione e impostazione del lavoro, va aggiunto
quello, non meno importante, dell'applicazione uniforme
dei criteri di trasmissione delle informazioni perché
«nell'elaborazione degli strumenti di ricerca, i
criteri formali di presentazione delle informazioni –
basati essenzialmente sulla gerarchia dei titoli, sulla
scelta dei corpi e caratteri differenziati e di spazi
delimitanti aree distinte, sull'uso logico e costante
della punteggiatura e delle maiuscole – rappresentano
non un mero fatto estetico, peraltro importante, ma un
sistema di comunicazione che renda anche graficamente
leggibile la struttura del fondo, l'articolazione delle
serie, la descrizione delle unità fondata su criteri
filologici».
La fase più impegnativa del presente lavoro è
stata quella della comprensione della natura e della tipologia
degli archivi presenti nell'Istituto. L’applicazione
del principio di provenienza e del criterio basato sull'individuazione
delle modalità di formazione dei fondi ci ha aiutato
a distinguere due grandi sezioni: quella degli archivi
propri e quella degli archivi impropri. Della prima fanno
parte i fondi delle organizzazioni e di persone e della
seconda i fondi che non sono stati prodotti da un ben
preciso soggetto ma che sono prevalentemente il risultato
di un'azione di recupero effettuata per iniziativa o degli
operatori che hanno lavorato in tale settore o dell'Istituto
stesso o di singole persone. Rendere esplicita tale distinzione
è di fondamentale importanza soprattutto quando
si opera in strutture, come la Fondazione Istituto Gramsci,
dove, per motivi facilmente comprensibili, la demarcazione
tra istituto di conservazione di archivi storici e centro
di documentazione non sempre è ben netta.
Anche l’identificazione dei soggetti produttori
ha comportato un notevole impegno di ricerca e di studio.
Eccezion fatta per gli archivi di persone, che presentavano
problemi di descrizione e non di identificazione, la sezione
dei fondi prodotti dalle organizzazioni presentava delle
difficoltà; in particolare la parte dell’archivio
del Pci relativa agli anni 1921-1943. In questo caso,
la tradizione archivistica dell’Istituto, utilizzata
ampiamente da tutti gli storici che hanno studiato e citato
documenti provenienti da tale fondo, non reggeva alla
verifica del metodo storico. Si pensava comunemente, infatti,
che i fascicoli ivi compresi facessero parte tout court
dell’archivio del Pcd’I, i cui originali sono
conservati a Mosca. In realtà, la ricostruzione
del complesso percorso archivistico e storico effettuato
da queste carte - di cui diamo notizia nella relativa
scheda della Guida- ci ha convinto che sia più
corretto parlare di fondo del Pcd’I come parte dell’archivio
della Terza internazionale.
Una volta chiarito il quadro generale all’interno
del quale muoverci e stabilite le strutture e le articolazioni
dei vari aggregati archivistici, è stato scelto
come livello di base su cui poggiare la descrizione archivistica
il fondo. Per individuare i fondi abbiamo trovato particolarmente
efficaci le indicazioni fornite da Paola Carucci, che
definisce il fondo «ciascun complesso documentario
che abbia un carattere di unitarietà, sia che si
tratti dell’archivio di un determinato ente (archivio
in senso proprio), sia che si tratti di un complesso di
documenti prodotti da enti diversi ma confluiti per ragioni
varie nell’ente che ha effettuato il versamento
o il deposito, sia che si tratti di un complesso di documenti
che sia il risultato di smembramenti, fusioni e riordinamenti
eseguiti in Archivi di concentrazione, sia che si tratti
di miscellanee o di raccolte». Tale definizione
ci ha permesso di poter applicare lo stesso livello per
tutti e tre i tipi di archivio presenti nella Fondazione
vale a dire sia per gli archivi di organizzazione (il
fondo corrisponde alla struttura che ha prodotto e/o ricevuto
le carte), sia per quelli di persone (il fondo corrisponde
al personaggio), sia per le raccolte (il fondo corrisponde
alla singola raccolta). In alcuni casi (Terza internazionale,
Partito comunista italiano, Archivio storico delle donne
Camilla Ravera), quando la struttura del soggetto produttore
nonché l’organizzazione della sua memoria
storica si presentavano particolarmente complesse e articolate,
è stato necessario introdurre un livello superiore,
il superfondo. Il più delle volte, il fondo è
stato articolato in serie; in rari casi in sottoserie.
Solo in due casi (Federazioni e Antonio Gramsci) abbiamo
introdotto il raggruppamento di serie che è un
livello privo di rilievo strutturale ma funzionale a una
più agevole lettura. Per il fondo Palmiro Togliatti
è stato necessario prevedere una specifica ripartizione
per indicare due tranches di documenti di diversa provenienza
e formazione.
È necessario, a questo punto,
fare una precisazione. Gli archivi conservati nella Fondazione
si presentano in maniera diversa: in alcuni casi sono
ordinati per materia, in altri cronologicamente; alcuni
non sono ordinati, altri riproducono l'ordinamento originario.
In tali situazioni, è molto forte la tentazione
di far precedere la fase descrittiva da interventi di
ordinamento o riordinamento. Ma, eccezion fatta per alcuni
fondi per i quali tale passaggio è stato ineludibile
pena l’impossibilità di descrivere il materiale,
motivazioni di ordine pratico, facilmente comprensibili,
hanno spinto a operare tenendo ben separati il lavoro
della guida da quello dell'ordinamento. Laddove lo stato
delle carte non permetteva una descrizione aderente al
reale ordinamento, si è seguito il suggerimento
avanzato nelle istruzioni operative del 1969 per la stesura
della Guida generale, da Pavone e D'Angiolini i quali
insistevano «sulla necessità di dare un minimo
di organizzazione razionale alla voce, procedendo sulla
carta, quando non fosse stato possibile operare sulle
carte, alle distinzioni e ai raggruppamenti richiesti
visto che «per la compilazione di una guida non
è necessario che gli archivi siano ordinati e inventariati
e poiché «le svariatissime strutture con
cui gli archivi stessi si presentano non possono essere
riproposte sic e simpliciter», si è individuato
un modo «convenzionale» per la descrizione
dei fondi applicato in maniera omogenea e uniforme. Pertanto,
quando non è stato possibile far coincidere la
descrizione con l'ordinamento reale delle carte, sono
stati costruiti fondi (Giovanni Amendola e Tatiana Schucht)
e serie «virtuali», vale a dire aggregazioni
di dati che sono tali solamente sulla carta ma che non
corrispondono all'ordine materiale dei documenti. La creazione
di queste realtà virtuali non è avvenuta
in modo arbitrario ma è stata il risultato di uno
studio archivistico e storico delle carte e del soggetto
che le ha prodotte. Nel caso di archivi di persone, la
elaborazione di serie quali Corrispondenza, Scritti e
discorsi, Documentazione è stata operata estendendo
un'organizzazione esistente in archivi già ordinati
e che ben si adattava a quelli non ordinati. In questi
casi, il modello elaborato per la descrizione nella Guida
può servire anche per effettuare, successivamente,
l’ordinamento reale delle carte. Un caso diverso
è rappresentato dal fondo Pcd’I 1921-1943.
L’ordinamento cronologico di quest’ultimo
rendeva molto difficile la descrizione delle carte. Le
serie virtuali sono state elaborate dopo aver constatato
che, all’interno di ciascun anno, le carte erano
disposte secondo un percorso gerarchico che andava dai
documenti prodotti dagli organismi centrali internazionali
a quelli delle strutture periferiche, dagli organi dirigenti
alle sezioni di lavoro, dal partito alle organizzazioni
di massa. In altri termini, l’analisi della documentazione
aveva evidenziato una sorta di «titolario»
non formalizzato che, pur non essendo stato applicato
per ordinare materialmente le carte, poteva servire alla
descrizione dei documenti del fondo secondo uno schema
che, in ultima istanza, non sconvolgeva i principi a cui
si era ispirato il soggetto produttore nella formazione
dell’archivio.
Questa impalcatura è trasmessa al lettore attraverso
l’uso costante e omogeneo di spazi e caratteri tipografici.
Il nome del superfondo è evidenziato con il carattere
maiuscolo; quello del fondo con il maiuscoletto alto e
basso; quello della serie con lo spaziato; per la sottoserie
si è usato il tondo facendo rientrare la relativa
descrizione. I raggruppamenti di serie che, come abbiamo
specificato, non hanno una rilevanza strutturale, sono
indicati con il carattere tondo rientrato a destra.
L‘ordine in cui sono stati presentati i fondi corrisponde
a un inquadramento che possiamo definire tipologico. La
lettura del sommario ci aiuta a comprendere l’organizzazione
complessiva della Guida. Innanzitutto va sottolineato
che nel sommario compaiono solo i fondi. Questi sono accorpati
in tre sezioni. Nella prima sono collocati gli archivi
prodotti da organizzazioni politiche e culturali; nella
seconda gli archivi di persone; nella terza gli archivi
che abbiamo definito «impropri», vale a dire
raccolte, collezioni ecc. di varia provenienza. Mentre
all’interno della seconda e terza sezione i fondi
si succedono secondo il semplice ordine alfabetico, la
complessità della prima sezione ha reso necessaria
un’ ulteriore tripartizione non formalizzata da
titoli. Nella prima sottoripartizione vi sono, disposte
in ordine cronologico, le carte degli organismi internazionali:
Terza internazionale (che è un superfondo), Soccorso
rosso, Internazionale contadina; nella seconda trovano
posto, sempre in ordine cronologico, due fondi che hanno
una loro specifica autonomia e provenienza: Pcd’I
1922-1925 e Brigate Garibaldi; nella terza è collocato
il superfondo Partito comunista italiano che raccoglie
tutti i fondi del partito prodotti dopo il 1943. L’ordine
di presentazione di questi ultimi è gerarchico;
eccezion fatta per i primi due fondi che riguardano gli
anni della Resistenza, i successivi procedono partendo
dall'istanza più alta e rappresentativa –
il congresso, fonte di legittimazione delle altre strutture
– e passando per gli organi centrali, le sezioni
centrali di lavoro – disposte secondo quella che
era la tradizionale scala di importanza le strutture periferiche
e gli organismi internazionali, che, nel secondo dopoguerra,
non svolgevano, almeno ufficialmente, lo stesso ruolo
di quelli del periodo precedente. Come si può notare,
l'organizzazione della prima sezione è effettuata
utilizzando sia il criterio cronologico sia quello funzionale.
Ci è sembrato che in questo modo venisse reso più
evidente l'intreccio che caratterizza la storia, le modalità
di formazione nonché il recupero degli archivi
conservati nella Fondazione. Questo schema di presentazione
è utilizzato anche per la descrizione del patrimonio
archivistico conservato dagli altri istituti Gramsci.
Così delineata la struttura generale della Guida,
si può passare ad analizzare le informazioni fornite
al lettore. La scheda descrittiva che accompagna i singoli
fondi è idealmente divisa in due aree che si identificano
in base alla qualità dei dati presentati. La prima
area potrebbe essere definita come area delle informazioni
sussidiarie. In essa rientrano tutti quei dati relativi
alla biografia, alla storia dell'ente, agli strumenti
bibliografici che svolgono una funzione di supporto nella
ricerca archivistica. L’obiettivo è quello
di fornire non un quadro esaustivo bensì solo quegli
elementi che, a giudizio delle autrici delle schede e
della curatrice, favoriscono una contestualizzazione storica
dei documenti presenti nel fondo. La seconda area è
quella delle informazioni primarie vale a dire la vera
e propria descrizione archivistica. La visualizzazione
di queste due parti della scheda è ottenuta attraverso
l'uso di due corpi tipografici diversi: più piccolo
per la prima area, più grande per la seconda. Per
ogni fondo vengono fornite le seguenti indicazioni:
a. Intestazione. Il criterio seguito è quello di
chiamare il fondo con il nome del soggetto produttore
delle carte. Laddove non è stato possibile –
come nel caso delle raccolte o di alcuni fondi che sono
pervenuti alla Fondazione in maniera tale da rendere difficile
l'esatta individuazione della struttura (Materiali del
Kominform, Organizzazioni, comuniste della Venezia Giulia)
– il nome indica il contenuto generale delle carte.
b. Dati generali. Gli elementi forniti sono relativi alla
consistenza, agli anni, al supporto materiale (indicato
solo nei casi in cui non si tratta di originali), ai mezzi
di corredo. Questi dati sono forniti sempre a livello
di fondo; è stato possibile riportarli anche disaggregati
per serie solamente nei casi in cui queste ultime corrispondono
all'ordinamento reale delle carte: mancano, quindi, per
le serie virtuali e per i fondi disordinati o in via di
ordinamento.
Le informazioni relative alla consistenza sono date rispettando
le unità di conservazione effettivamente usate
(fascicolo, busta, scatola). Va precisato che il fascicolo
è stato utilizzato dagli archivisti della Fondazione
che hanno lavorato all'organizzazione dei documenti sia
nell'accezione di mera unità di conservazione sia
in quella, più propria, di unità archivistica.
Tra i mezzi di corredo, quello più frequentemente
citato è l'elenco. Abbiamo scartato la qualifica
di inventario perché gli strumenti attualmente
utilizzati per la consultazione sono stati elaborati con
criteri propri di una lista di documenti piuttosto che
con quelli scientifici dell'inventario. Quando tra i dati
generali non compaiono indicazioni circa il mezzo di corredo,
significa che il fondo ne è privo o possiede strumenti
di consultazione relativi a singoli spezzoni di documentazione.
In quest'ultimo caso, è segnalato accanto alla
serie cui si riferisce.
c. Storia istituzionale e biografie. Come precedentemente
segnalato, sono stati riportati solamente i dati giudicati
utili per la definizione di coordinate storiche all'interno
delle quali leggere i documenti.
d. Bibliografia. Sono segnalati i repertori bibliografici
e archivistici, le opere biografiche e autobiografiche,
le pubblicazioni di scritti e di documenti, i lavori storici
che danno conto della storia delle strutture organizzative.
Per quanto riguarda il Pci, la vasta mole di pubblicazioni
nella forma sia di storie generali, sia di storie di singoli
dirigenti, sia di edizioni di atti ufficiali di partito
e di documenti tratti dall'archivio dello stesso, ci ha
sconsigliato di procedere alla formulazione di una bibliografia
generale. Indicazioni parziali e strettamente collegate
ai documenti, sono state date di volta in volta per singoli
fondi.
e. Stona del fondo. Si tratta di informazioni relative
alla provenienza delle carte, alle date di versamento
presso la Fondazione, agli ordinamenti o riordinamenti
effettuati. Nel caso in cui sono utilizzate le serie virtuali,
è specificato l'attuale ordinamento fisico del
fondo. Come ben sanno gli operatori del settore archivistico,
la conservazione della tradizione delle vicende della
documentazione scritta è affidata, il più
delle volte, ai ricordi dei protagonisti e alla trasmissione
orale. Pertanto, quasi tutte le informazioni relative
a questa parte della scheda si fondano sulla buona memoria
degli archivisti della Fondazione e del Pds.
f. Descrizione archivistica. Eccezion fatta per i fondi
di scarsa consistenza, la descrizione è effettuata
a livello di serie e, in alcuni casi, di sottoserie. Come
abbiamo già sottolineato, obiettivo prioritario
era quello di disegnare la struttura dei fondi, la loro
articolazione interna, i rapporti gerarchici esistenti
fra loro. Ma la descrizione non poteva non illustrare
anche il contenuto dei fondi. È questa la parte
della scheda più esposta a una formulazione soggettiva.
Tenendo conto di questo rischio, sono stati fissati due
criteri per orientare la descrizione: la tipologia documentaria
presente nonché l'esistenza di nuclei documentari
ritenuti particolare mente importanti ai fini della significatività
storica dei singoli fondi o serie. Inoltre, si è
usata la formula «si segnala» per indicare
documenti anomali, materiali prodotti da altri soggetti,
carte giudicate interessanti dall'autrice della scheda
oppure momenti significativi.
La rilevazione dei dati è stata conclusa alla fine
del 1993. L’anno successivo è stato interamente
dedicato alla definizione dei criteri redazionali che,
come abbiamo già detto, hanno una grande importanza
per lavori come questo. Pertanto nella Guida non sono
riportati gli incrementi di fondi già esistenti
né i nuovi versamenti avvenuti nel corso del 1994.
Vorrei rivolgere un affettuoso ringraziamento a Giuseppe
Vacca, che per primo ha creduto in questo lavoro, ne ha
condiviso le motivazioni, lo ha seguito nel suo lungo
cammino con l'entusiasmo che gli è proprio, e a
Paola Carucci, che ha messo generosamente a disposizione
la sua esperienza e competenza. Desidero ricordare, inoltre,
Mario Serio, fino a qualche mese fa sovrintendente dell'Archivio
centrale dello Stato, istituto del quale faccio parte,
che mi ha incoraggiato e sostenuto. Si ringraziano, inoltre,
Fabrizio Zitelli, Gastone Gensini, Camillo Danieli che
con i ricordi maturati nella loro lunga militanza archivistica
hanno reso possibile la ricostruzione dei percorsi degli
archivi; Marcello Forti che ha sopportato pazientemente
le incursioni e le invasioni di campo; Claudio Natoli
e Aldo Agosti che hanno fornito utili informazioni; tutti
gli amici della Fondazione che hanno seguito la lunga
gestazione della Guida e ne hanno atteso, fiduciosi, la
pubblicazione. |
|
|
 |
| |
| ©
copyright 1996, 2015
| FONDAZIONE
ISTITUTO GRAMSCI onlus |
cf 97024640589
|
| sede
legale, uffici amministrativi
|
ROMA VIA PORTUENSE 95c
|
tel. 0039 0683901670 fax 0039 0658157631 |
| segreteria,
archivi, biblioteca
|
ROMA VIA SEBINO 43a| tel. 0039 065806646 fax 0039 0658157631 |
|
|